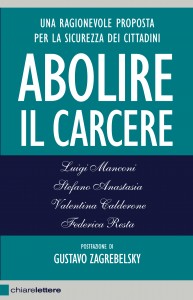Pubblichiamo il documento base, che sarà arricchito da ulteriori apporti, di Expo 2015 che inizierà il 1 maggio a Milano
CARTA DI MILANO (EXPO 2015 – TESTO INTEGRALE)
“Salvaguardare il futuro del pianeta e il diritto delle generazioni future del mondo intero a vivere esistenze prospere e appaganti è la grande sfida per lo sviluppo del 21° secolo. Comprendere i legami fra sostenibilità ambientale ed equità è essenziale se vogliamo espandere le libertà umane per le generazioni attuali e future.”
Human Development Report 2011
Noi donne e uomini, cittadini di questo pianeta, sottoscriviamo questo documento, denominato Carta di Milano, per assumerci impegni precisi in relazione al diritto al cibo che riteniamo debba essere considerato un diritto umano fondamentale.
Consideriamo infatti una violazione della dignità umana il mancato accesso a cibo sano, sufficiente e nutriente, acqua pulita ed energia.
Riteniamo che solo la nostra azione collettiva in quanto cittadine e citta- dini, assieme alla società civile, alle imprese e alle istituzioni locali, nazio- nali e internazionali potrà consentire di vincere le grandi sfide connesse al cibo: combattere la denutrizione, la malnutrizione e lo spreco, pro-muovere un equo accesso alle risorse naturali, garantire una gestione sostenibile dei processi produttivi.
Sottoscrivendo questa Carta di Milano
affermiamo la responsabilità della generazione presente nel mettere in atto azioni, condotte e scelte che garantiscano la tutela del diritto al cibo anche per le generazioni future; ci impegniamo a sollecitare decisioni politiche che consentano il raggiungimento dell’obiettivo fondamentale di garantire un equo accesso al cibo per tutti.
Noi crediamo che
• tutti abbiano il diritto di accedere a una quantità sufficiente di cibo sicuro, sano e nutriente, che soddisfi le necessità alimentari personali lungo tutto l’arco della vita e permetta una vita attiva;
• il cibo abbia un forte valore sociale e culturale, e non debba mai essere usato come strumento di pressione politica ed economica;
• le risorse del pianeta vadano gestite in modo equo, razionale ed efficiente affinché non siano sfruttate in modo eccessivo e non avvantaggino alcuni a svantaggio di altri;
• l’accesso a fonti di energia pulita sia un diritto di tutti, delle generazioni presenti e future;
• gli investimenti nelle risorse naturali, a partire dal suolo, debbano essere regolati, per garantire e preservare alle popolazioni locali l’accesso a tali risorse e a un loro uso sostenibile;
• una corretta gestione delle risorse idriche, ovvero una gestione che tenga conto del rapporto tra acqua, cibo ed energia, sia fondamentale per garan- tire il diritto al cibo a tutti
• l’attività agricola sia fondamentale non solo per la produzione di beni ali- mentari ma anche per il suo contributo a disegnare il paesaggio, proteg- gere l’ambiente e il territorio e conservare la biodiversità.
Noi riteniamo inaccettabile che
• ci siano ingiustificabili diseguaglianze nelle possibilità, nelle capacità e nelle opportunità tra individui e popoli;
• non sia ancora universalmente riconosciuto il ruolo fondamentale delle donne, in particolare nella produzione agricola e nella nutrizione;
• circa 800 milioni di persone soffrano di fame cronica, più di due miliardi di persone siano malnutrite o comunque soffrano di carenze di vitamine e minerali; quasi due miliardi di persone siano in sovrappeso o soffrano di obesi- tà; 160 milioni di bambini soffrano di malnutrizione e crescita ritardata;
• ogni anno 1,3 miliardi di tonnellate di cibo prodotto per il consumo umano siano sprecati o si perdano nella filiera alimentare;
• più di 5 milioni di ettari di foresta scompaiano ogni anno con un grave danno alla biodiversità, alle popolazioni locali e sul clima;
• le risorse del mare siano sfruttate in modo eccessivo: più del 30% del pesca- to soggetto al commercio è sfruttato oltre la sua capacità di rigenerazione;
• le risorse naturali, inclusa la terra, possano essere utilizzate in contrasto con i fabbisogni e le aspettative delle popolazioni locali;
sussista ancora la povertà energetica, ossia l’accesso mancato o limitato a servizi energetici e strumenti di cottura efficienti, non troppo costosi, non inquinanti e non dannosi per la salute.
Siamo consapevoli che
• una delle maggiori sfide dell’umanità è quella di nutrire una popolazione in costante crescita senza danneggiare l’ambiente, al fine di preservare le risorse anche per le generazioni future;
• il cibo svolge un ruolo importante nella definizione dell’identità di ciascuna persona ed è una delle componenti culturali che connota e dà valore a un territorio e ai suoi abitanti;
• gli agricoltori, gli allevatori e i pescatori operano in una posizione fonda- mentale per la nostra nutrizione; essi hanno uguali diritti e doveri in rela- zione al loro lavoro, sia come piccoli imprenditori sia come grandi imprese;
• siamo tutti responsabili della custodia della terra, della tutela del territorio e del suo valore ambientale;
• è possibile favorire migliori condizioni di accesso a cibo sano e sufficiente nei contesti a forte urbanizzazione, anche attraverso processi inclusivi e partecipativi che si avvalgano delle nuove tecnologie;
• una corretta educazione alimentare, a partire dall’infanzia, è fondamentale per uno stile di vita sano e una migliore qualità della vita;
• la conoscenza e la pratica dei modi di produrre, sia tradizionali sia avanza- ti, è essenziale per l’efficienza dei sistemi agricoli, dall’agricoltura familiare fino a quella industriale;
• il mare ha un valore fondamentale per gli equilibri del pianeta e richiede politiche sovranazionali: un ecosistema marino integro e sano ha una rilevanza cruciale per il benessere collettivo, anche perché la pesca fornisce lavoro a milioni di persone e il pesce, per molti, rappresenta l’unica fonte di nutrienti di alta qualità;
• per far fronte in modo sostenibile alle sfide alimentari future è indispensabile adottare un approccio sistemico attento ai problemi sociali, culturali, economici e ambientali e che coinvolga tutti gli attori sociali e istituzionali.
Poiché sappiamo di essere responsabili
di lasciare un mondo più sano, equo e sostenibile alle generazioni future in quanto cittadine e cittadini, noi ci impegniamo a
• avere cura e consapevolezza della natura del cibo di cui ci nutriamo, infor- mandoci riguardo ai suoi ingredienti, alla loro origine e al come e dove è prodotto, al fine di compiere scelte responsabili;
• consumare solo le quantità di cibo sufficienti al fabbisogno, assi- curandoci che il cibo sia consumato prima che deperisca, donato qualora in eccesso e conservato in modo tale che non si deteriori; evitare lo spreco di acqua in tutte le attività quotidiane, domestiche e produttive;
• adottare comportamenti responsabili e pratiche virtuose, come riciclare, rigenerare e riusare gli oggetti di consumo al fine di proteggere l’ambiente;
• promuovere l’educazione alimentare e ambientale in ambito familiare per una crescita consapevole delle nuove generazioni;
• scegliere consapevolmente gli alimenti, considerando l’impatto della loro produzione sull’ambiente;
• essere parte attiva nella costruzione di un mondo sostenibile, anche attraverso soluzioni innovative, frutto del nostro lavoro, della nostra creatività e ingegno.
In quanto membri della società civile, noi ci impegniamo a
• far sentire la nostra voce a tutti i livelli decisionali, al fine di determinare progetti per un futuro più equo e sostenibile;
• rappresentare le istanze della società civile nei dibattiti e nei processi di formazione delle politiche pubbliche;
• rafforzare e integrare la rete internazionale di progetti, azioni e iniziative che costituiscono un’importante risorsa collettiva;
• promuovere l’educazione alimentare e ambientale perché vi sia una con- sapevolezza collettiva della loro importanza;
• individuare e denunciare le principali criticità nelle varie legislazioni che disciplinano la donazione degli alimenti invenduti per poi impegnarci attivamente al fine di recuperare e ridistribuire le eccedenze;
• promuovere strumenti che difendano e sostengano il reddito di agricoltori, allevatori e pescatori, potenziando gli strumenti di organizzazione e cooperazione, anche fra piccoli produttori;
• valorizzare i piccoli produttori locali come protagonisti di una forma avanzata di sviluppo e promuovere le relazioni dirette tra produttori, consuma- tori e territori di origine.
In quanto imprese, noi ci impegniamo a
• applicare le normative e le convenzioni internazionali in materia ambientale e sociale e favorire forme di occupazione che contribuiscano alla realizzazione personale delle lavoratrici e dei lavoratori;
• investire nella ricerca promuovendo una maggiore condivisione dei risultati e sviluppandola nell’interesse della collettività, senza contrapposizione tra pubblico e privato;
• promuovere la diversificazione delle produzioni agricole e di allevamento al fine di preservare la biodiversità e il benessere degli animali;
• migliorare la produzione, la conservazione e la logistica, in modo da evi- tare (o eliminare) la contaminazione e da minimizzare lo spreco, anche dell’acqua, in tutte le fasi della filiera produttiva;
• produrre e commercializzare alimenti sani e sicuri, informando i consumatori su contenuti nutrizionali, impatti ambientali e implicazioni sociali del prodotto;
• promuovere adeguate tecniche di imballaggio che permettano di ridurre i rifiuti e facilitino lo smaltimento e il recupero dei materiali usati;
• promuovere innovazioni che informino i consumatori su tempi di consumo compatibili con la natura, qualità e modalità di conservazione degli alimenti;
• riconoscere il contributo positivo della cooperazione e degli accordi strutturali sulla filiera, specialmente quella alimentare, tra agricoltori, produttori e distributori, per una più efficace previsione della domanda;
• contribuire agli obiettivi dello sviluppo sostenibile sia attraverso l’innovazione dei processi, dei prodotti e dei servizi sia attraverso l’adozione e l’adempimento di codici di responsabilità sociale.
Quindi noi, donne e uomini, cittadini ‘di questo pianeta, sottoscrivendo questa Carta di Milano, chiediamo con forza a governi, istituzioni e organizzazioni internazionali di impegnarsi a:
• adottare misure normative per garantire e rendere effettivo il diritto al cibo e la sovranità alimentare;
• rafforzare le leggi in favore della tutela del suolo agricolo, per regolamenta- re gli investimenti sulle risorse naturali, tutelando le popolazioni locali;
• promuovere il tema della nutrizione nei forum internazionali tra governi, assicurando una effettiva e concreta attuazione degli impegni in ambito nazionale e un coordinamento anche nell’ambito delle organizzazioni internazionali specializzate;
• sviluppare un sistema di commercio internazionale aperto, basato su re- gole condivise e non discriminatorio capace di eliminare le distorsioni che limitano la disponibilità di cibo, creando le condizioni per una migliore sicurezza alimentare globale;
• considerare il cibo un patrimonio culturale e in quanto tale difenderlo da contraffazioni e frodi, proteggerlo da inganni e pratiche commerciali scorrette, valorizzarne origine e originalità con processi normativi trasparenti;
• formulare e implementare regole e norme giuridiche riguardanti il cibo e la sicurezza alimentare e ambientale che siano comprensibili e facilmente applicabili;
• sostenere e diffondere la cultura della sana alimentazione come strumento di salute globale;
• combattere ed eliminare il lavoro sia minorile sia irregolare nel settore agroalimentare;
• lavorare alla realizzazione di una struttura sovranazionale che raccolga le attività di informazione e analisi dei reati che interessano la filiera agro-alimentare e che rafforzi la cooperazione per il contrasto degli illeciti;
• declinare buone pratiche in politiche pubbliche e aiuti allo sviluppo che siano coerenti coi fabbisogni locali, non emergenziali e indirizzati allo sviluppo di sistemi alimentari sostenibili;
• promuovere patti globali riguardo le strategie alimentari urbane e rurali in relazione alla sostenibilità e all’accesso al cibo sano e nutriente, che coinvolgano sia le principali aree metropolitane del pianeta sia le campagne;
• aumentare le risorse destinate alla ricerca, al trasferimento dei suoi esiti, alla formazione e alla comunicazione;
• introdurre o rafforzare nelle scuole e nelle mense scolastiche i programmi di educazione alimentare, fisica e ambientale come strumenti di salute e prevenzione, valorizzando in particolare la conoscenza e lo scambio di culture alimentari diverse, a partire dai prodotti tipici, biologici e locali;
• sviluppare misure e politiche nei sistemi sanitari nazionali che promuovano diete sane e sostenibili e riducano il disequilibrio alimentare, con attenzione prioritaria alle persone con esigenze speciali di nutrizione, di corretta idratazione e di igiene, in particolare anziani, donne in gravidanza, neonati, bambini e malati;
• promuovere un eguale accesso al cibo, alla terra, al credito, alla formazione, all’energia e alle tecnologie, in particolare modo alle donne, ai piccoli produttori e ai gruppi sociali più svantaggiati;
• creare strumenti di sostegno in favore delle fasce più deboli della popolazione, anche attraverso il coordinamento tra gli attori che operano nel set- tore del recupero e della distribuzione gratuita delle eccedenze alimentari;
• includere il problema degli sprechi e delle perdite alimentari e idriche all’interno dell’agenda internazionale e nazionale, attraverso investimenti pubblici e privati a favore di sistemi produttivi più efficaci;
• valorizzare la biodiversità a livello sia locale sia globale, grazie anche a indicatori che ne definiscano non solo il valore biologico ma anche il valore economico;
• considerare il rapporto tra energia, acqua, aria e cibo in modo complessivo e dinamico, ponendo l’accento sulla loro fondamentale relazione, in modo da poter gestire queste risorse all’interno di una prospettiva strategica e di lungo periodo in grado di contrastare il cambiamento climatico.
Poiché crediamo che un mondo senza fame sia possibile e sia un fatto di dignità umana, nell’Anno Europeo per lo sviluppo e in occasione di Expo Milano 2015, noi ci impegniamo ad adottare i principi e le pratiche esposte in questa Carta di Milano, coerenti con la strategia che gli Stati membri delle Nazioni Unite hanno elaborato per sradicare il problema della fame entro il 2030.
Sottoscrivendo questa Carta di Milano noi dichiariamo di portare la nostra adesione concreta e fattiva agli Obiettivi per uno Sviluppo Sostenibile promossi dalle Nazioni Unite.
Un futuro sostenibile e giusto è anche una nostra responsabilità.
Firme
Elenco dei Contributor e dei documenti di riferimento
1 Associazione Volontari per il Servizio Internazionale (AVSI), Università di Milano, MLFM, Rotary Aquaplus, Contributo per la Carta di Milano
2 BancaMondiale,HumanOpportunityIndex
3 Barilla Center for food and nutrition, Milan Protocol
4 Comitato scientifico delle Università di Milano per Expo – Comune di Mila- no, Contributo per la Carta di Milano
5 Commissione Europea (EU), Food Use for Social Innovation by Optimising Waste Prevention Strategies
6 Commissione Europea (EU), Impact assessment on measures addressing food waste to complete SWD (2014) 207 regarding the review of the EU wa- ste management targets
7 Comunicazione della Commissione Europea al Parlamento Europeo, al Consiglio Europeo, al Comitato Economico e sociale Europeo e al Comitato delle Regioni, Tackling unfair trading practices in the business-to-business food suply chain
8 Conclusioni dell’Indagine conoscitiva della Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati sulla valorizzazione delle produzioni agroalimentari nazionali con riferimento all’Esposizione Universale di Milano 2015, 27 novembre 2014 Indagine conoscitiva 27/11/14 Commissione Agricoltura – Camera dei Deputati del Parla- mento Italiano
9 CNH Industrial, Contributo per la Carta di Milano
10 Consorzio AASTER, Il territorio e Expo
11 Feeding knowledge, Best Practices – Expo Milano 2015
12 Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, Laboratorio Expo, Patto della Scien- za: Access to Energy and Economic Development, a cura di S. Pareglio, E. Chiappero-Martinetti, J. Bonan, N. von Jacobi e M. Fabbri
13 Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, Laboratorio Expo, Patto della Scien- za: Collective Goods, a cura di S. Pareglio, E. Chiappero-Martinetti, J. Bonan, N. von Jacobi e M. Fabbri
14 Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, Laboratorio Expo, Patto della Scien- za: Social Sustainability, a cura di S. Pareglio, E. Chiappero-Martinetti, J. Bonan, N. von Jacobi e M. Fabbri
15 Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, Laboratorio Expo, Patto della Scien- za: The way to future food production, a cura di C. Sorlini, B. Dendena, S. Grassi
16 Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, Laboratorio Expo, Patto della Scienza: Food security: what’s behind and what’s next, a cura di C. Sorlini, B. Dendena, S. Grassi
17 Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, Laboratorio Expo, Patto della Scienza: Safe and nutritious food for all, a cura di C. Sorlini, B. Dendena, S. Grassi
18 Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, Laboratorio Expo, Patto della Scienza: Food aesthetics and culture of the senses, a cura di U. Fabietti, F. Riva, M. Badii
19 Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, Laboratorio Expo, Patto della Scienza: Food and belonging: bodies, territories and agricultures, a cura di U. Fabietti, F. Riva, M. Badii
20 Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, Laboratorio Expo, Patto della Scienza: Food Heritage, a cura di U. Fabietti, F. Riva, M. Badii
21 Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, Laboratorio Expo, Patto della Scienza: Technological and social innovation, a cura di S. Vicari, D. Diamantini, E. Colleoni, N. Borrelli
22 Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, Laboratorio Expo, Patto della Scienza: New Urban Governance, a cura di S. Vicari, D. Diamantini, E. Colleoni, N. Borrelli
23 Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, Laboratorio Expo, Patto della Scienza: Urban equity, a cura di S. Vicari, D. Diamantini, E. Colleoni, N. Borrelli
24 Fondazione Triulza, Contributo per la Carta di Milano
25 Gruppo San Pellegrino, Paper per Expo delle Idee
26 Inalca, La clessidra ambientale: una proposta per la Carta di Milano
27 International Food Policy Research Institute (IFPRI), Contributo per la Carta di Milano
28 Le idee di Expo verso la Carta di Milano, Report tavolo tematico 1 – Il mondo che ha fame: vecchi e nuovi poveri e il diritto al cibo
29 Le idee di Expo verso la Carta di Milano, Report Tavolo tematico 2 – Fino all’ultima goccia d’acqua
30 Le idee di Expo verso la Carta di Milano, Report Tavolo tematico 3 – La nostra madre terra
31 Le idee di Expo verso la Carta di Milano, Report Tavolo tematico 4 – Sviluppo sostenibile: modelli a confronto
32 Le idee di Expo verso la Carta di Milano, Report Tavolo tematico 5 – Una casa per la società civile: Cascina Triulza
33 Le idee di Expo verso la Carta di Milano, Report Tavolo tematico 6 – Ricettività e turismo: obiettivo 20 milioni di visitatori
34 Le idee di Expo verso la Carta di Milano, Report Tavolo tematico 7 – Un’occasione unica per lavoro e imprese
35 Le idee di Expo verso la Carta di Milano, Report Tavolo tematico 8 – Quota 50 miliardi: l’export dell’agroalimentare italiano
36 Le idee di Expo verso la Carta di Milano, Report Tavolo tematico 9 – La lotta alla contraffazione alimentare
37 Le idee di Expo verso la Carta di Milano, Report Tavolo tematico 10 – Agromafie
38 Le idee di Expo verso la Carta di Milano, Report Tavolo tematico 11 – La sfida alle indicazioni geografiche
39 Le idee di Expo verso la Carta di Milano, Report Tavolo tematico 12 – La sfida di Expo 2015: la cultura come seme per l’età della conoscenza
40 Le idee di Expo verso la Carta di Milano, Report Tavolo tematico 13 – Patrimonio UNESCO: dalla dieta mediterranea agli stili di vita
41 Le idee di Expo verso la Carta di Milano, Report Tavolo tematico 14 – Educazione Alimentare: un investimento per il futuro
42 Le idee di Expo verso la Carta di Milano, Report Tavolo tematico 15 – Vietato sprecare
43 Le idee di Expo verso la Carta di Milano, Report Tavolo tematico 16 – Aggiungi un posto a tavola: la ristorazione di domani
44 Le idee di Expo verso la Carta di Milano, Report Tavolo tematico 17 – WE – Women for Expo
45 Le idee di Expo verso la Carta di Milano, Report Tavolo tematico 18 – Il cibo dello spirito
46 Le idee di Expo verso la Carta di Milano, Report Tavolo tematico 19 – Cibo sport e benessere
47 Le idee di Expo verso la Carta di Milano, Report Tavolo tematico 20 – Un incrocio di culture: le comunità straniere ad Expo Milano 2015
48 Le idee di Expo verso la Carta di Milano, Report Tavolo tematico 21 – Il Padiglione Italia: il Paese in vetrina
49 Le idee di Expo verso la Carta di Milano, Report Tavolo tematico 22 – i Paesi partecipanti di Expo 2015: un’agenda internazionale
50 Le idee di Expo verso la Carta di Milano, Report Tavolo tematico 23 – I cluster: un modello innovativo
51 Le idee di Expo verso la Carta di Milano, Report Tavolo tematico 24 – La cooperazione internazionale allo sviluppo
52 Le idee di Expo verso la Carta di Milano, Report Tavolo tematico 25 – La biodiversità salverà il mondo
53 Le idee di Expo verso la Carta di Milano, Report Tavolo tematico 26 – Mondo obeso e malnutrito: salute, malattie e disturbi alimentari
54 Le idee di Expo verso la Carta di Milano, Report Tavolo tematico 27- Sai cosa mangi? La sicurezza alimentare
55 Le idee di Expo verso la Carta di Milano, Report Tavolo tematico 28 – Mare Magnum
56 Le idee di Expo verso la Carta di Milano, Report Tavolo tematico 29 – La ricerca in campo agroalimentare
57 Le idee di Expo verso la Carta di Milano, Report Tavolo tematico 30 – AgriLAB: Innovazione in agricoltura
58 Le idee di Expo verso la Carta di Milano, Report Tavolo tematico 31 – La logistica del cibo
59 Le idee di Expo verso la Carta di Milano, Report Tavolo tematico 32 – Milano la città che ospita Expo
60 Le idee di Expo verso la Carta di Milano, Report Tavolo tematico 33 – Regione Lombardia, terra dell’Expo
61 Le idee di Expo verso la Carta di Milano, Report Tavolo tematico 34 – I territori in Expo
62 Le idee di Expo verso la Carta di Milano, Report Tavolo tematico 35 – La città nella città
63 Le idee di Expo verso la Carta di Milano, Report Tavolo tematico 36 – Expo: una smart city che guarda al futuro
64 Le idee di Expo verso la Carta di Milano, Report Tavolo tematico 37 – Per una Esposizione Universale sostenibile
65 Le idee di Expo verso la Carta di Milano, Report Tavolo tematico 38 – Open Expo
66 Le idee di Expo verso la Carta di Milano, Report Tavolo tematico 39 – Legalità: un valore non negoziabile, una best practice per il futuro
67 Le idee di Expo verso la Carta di Milano, Report Tavolo tematico 40 – Post Expo: che fare?
68 Le idee di Expo verso la Carta di Milano, Report Tavolo tematico 41 – 1 novembre 2015: l’eredità politica di Expo 2015
69 Le idee di Expo verso la Carta di Milano, Report Tavolo tematico 42 – Guerra alla povertà
70 Mediterranean Nutrition Group, La nutrizione nei primi 1000 giorni
71 Milan Center for Food Law and Policy
72 Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale – Direzione Generale della Cooperazione allo Sviluppo (MAECI-DGCS), Contributo per la Carta di Milano
73 Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Nuove linee guida sulla cooperazione internazionale
74 Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Carta di Livorno
75 Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Carta di Bologna contro gli sprechi alimentari
76 Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Piano Nazionale di Prevenzione dello Spreco Alimentare (PINPAS)
77 Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (MiPAAF), Contributo per la Carta di Milano
78 Ministero Federale Tedesco per la Nutrizione e l’Agricoltura, Review of the Global Forum for Food and Agriculture (GFFA) 2015
79 Mozione a prima firma on. Fiorio, Atto 1/00052 del 27 maggio 2013 di- scusso e approvato il 3 giugno 2014 (in nota: Parlamento Italiano, Atto 1/00052 3/06/2014.)
80 Mozione a prima firma sen. Formigoni, Atto 1/00269 del 10 giugno 2014 e altre abbinate. Discusse e approvate il 18 giugno 2014. (in nota: Parla- mento Italiano, Atto 1/00269 3/06/2014.)
81 Mozione a prima firma sen. Gaetti, Atto 1/00275 del 17 giugno 2014 discusso e approvato il 18 giugno 2014 (in nota:Parlamento Italiano, Atto 1/00275 3/06/2014.)
82 Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU), Millenium Development Goals, 2000
83 Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU), UN Water: The post 2015 Water Thematic Consultation Report
84 Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU), Zero Hunger Challenge
85 Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura(FAO), Contributo per la Carta di Milano
86 Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO) e Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), Dichiarazione di Roma sulla nutrizione, 2014
87 Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura(FAO), Declaration of the World Summit on Food Security, 2009
88 Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura(FAO), How to feed the World 2050
89 Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura(FAO), State of World Fisheries and Aquaculture 2014
90 Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura(FAO), Fondo Internazionale per lo Sviluppo Agricolo, Programma Alimentare Mondiale, The State of Food Insecurity in the World 2014
91 Programma per lo Sviluppo delle Nazioni Unite, Human Development Index
92 Sindacati confederali Milano (CIGL, CISL, UIL), Contributo per la Carta di Milano
93 Steering Committee del Comitato Scientifico dell’Unione Europea per Expo, Global food and nutrition security and the role of research in the EU: a discussion paper
94 Urban Food Policy Pact, coordinato dal Comune di Milano
95 Waste Watcher Knowledge for Expo, Rapporto 2014
96 Women for Expo, Contributo per la Carta di Milano
Condividi su Facebook