
Convegno della Democrazia Cristiana Italiana DC – Il politico DC Carlo Donat Cattin, Roma , febbraio 1980 (Contrasto)
Pubblichiamo, per gentile concessione dell’autore, il testo dell’intervento, del professor Francesco Malgeri, alla presentazione del libro, avvenuta martedì scorso nella sala dell’Istituto “Luigi Sturzo” di Roma, del giornalista Giorgio Aimetti su Carlo Donat Cattin . Il libro di Aimetti, pubblicato dalla Casa Editrice “Rubbettino” «Carlo Donat-Cattin. La vita e le idee di un democristiano scomodo» (Soveria Mannelli, 2021, pagine 540, euro 29), è una lunga e densa biografia del leader della sinistra sociale della DC. Il libro, frutto di una ventennale ricerca, è di grande interesse storico. Sono presenti anche documenti importanti e inediti. Ne pubblichiamo due . L’Osservatore Romano, organo della Santa Sede, in una sua anticipazione del libro ha pubblicato due lettere, presenti nel saggio, di Donat Cattin. Le lettere si riferiscono alla vicenda dolorosissima del figlio Marco. Come si sa Marco era finito in carcere per terrorismo. La prima delle lettere è una risposta ad una lettera, mai trovata , di una suora impegnata nell’assistenza ai carcerati. La seconda lettera è inviata al Presidente della Repubblica, Francesco Cossiga, dopo la morte di Marco travolto da un’auto mentre soccorreva dei feriti di un incidente stradale. Sono due lettere molto toccanti. I documenti sono ripresi dalla testata che ha rilanciato le lettere pubblicate dall’Osservatore Romano: http://www.ildomaniditalia.eu/un-padre-nella-tormenta-in-un-volume-di-giorgio-aimetti-le-lettere-di-carlo-donat-cattin-losservatore-romano/
Il mio giudizio su questo libro di Giorgio Aimetti ho già avuto modo di esprimerlo nella mia Introduzione, nella quale ho già sottolineato come l’autore abbia delineato la biografia politica di Donat-Cattin, sulla base di una ampia documentazione, cogliendo la fisionomia, il carattere, il ruolo e l’azione di una personalità politica che ha lasciato tracce profonde della sua presenza in campo sindacale, politico e di governo, in una lunga e intensa stagione, che attraversa la seconda metà del secolo scorso. A Ra
Abbiamo a disposizione, con questo libro, la ricostruzione di un percorso denso di avvenimenti, progetti, istanze sociali, politiche e culturali che hanno profondamente inciso sulla storia italiana nel corso di quegli anni.
Ma in questo mio intervento vorrei sottolineare altri aspetti, più generali, che emergono con evidenza da questo libro, che si colloca nel campo di una storiografia attenta a ricostruire le vicende di quegli anni, attraverso una lettura condotta con serietà di metodo e onestà intellettuale.
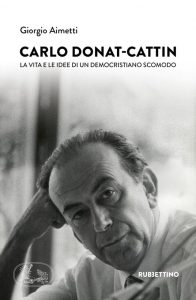 È ben noto come le vicende di quegli anni e in particolare il ruolo della Democrazia cristiana, siano stati – soprattutto a livello mediatico e nel giudizio di alcuni esponenti della nuova classe politica – oggetto di una sorta di demolizione, che tende a colpire l’intera storia politica italiana della seconda metà del secolo XX.
È ben noto come le vicende di quegli anni e in particolare il ruolo della Democrazia cristiana, siano stati – soprattutto a livello mediatico e nel giudizio di alcuni esponenti della nuova classe politica – oggetto di una sorta di demolizione, che tende a colpire l’intera storia politica italiana della seconda metà del secolo XX.
Si può affermare che questo libro fa giustizia delle non poche forzature interpretative, dettate in molti casi da una distorta rappresentazione della vita politica italiana del secondo dopoguerra, influenzata da logori pregiudizi e soprattutto, direi, dalla ignoranza di chi ne scrive o ne parla.
Un giudizio che prende corpo non tanto alla luce di una riflessione sulla storia politica del paese, con le sue luci e le sue ombre, ma in una sorta di demonizzazione di un passato che viene rappresentato come espressione della partitocrazia, dell’assistenzialismo, del consociativismo, della corruzione e del malcostume.
Una sorta di giudizio sommario che tende a disconoscere le fasi più importanti dell’intera nostra storia nazionale, sul piano dello sviluppo economico-sociale e della crescita civile e democratica del Paese.
Questo giudizio sembra dimenticare quanto, in quegli anni, le forze politiche, ciascuna per la propria parte, hanno vissuto stagioni segnate da importanti risultati ed anche da una grande partecipazione ideale alle battaglie che hanno sostenuto.
Sembra non tener conto di quanto i partiti che ne furono protagonisti siano stati strumenti fondamentali nella crescita e nella formazione di grandi masse che si affacciavano alla vita democratica.
Si deve ad essi la ricostruzione del paese, l’avvio di uno sviluppo economico che ha permesso per lunghi anni una esistenza serena ad una gran parte di cittadini, superando profonde sacche di miseria ereditate da quasi un secolo di storia nazionale, una crescita democratica tale da portare anche coloro che non si riconoscevano nel metodo della democrazia parlamentare, ad accettarlo con convinzione.
Certamente, con il passare degli anni, non sono mancati, i limiti e i processi degenerativi, nei quali i partiti hanno assunto un ruolo e un peso che andava al di là di un corretto equilibrio tra forze politiche, istituzioni, poteri economici, apparati dello Stato, alimentando una crisi destinata a minare il sistema politico che aveva contraddistinto la storia della nostra Repubblica.
In questa lunga e complessa storia un compito di primo piano venne esercitato dalla Democrazia cristiana, un partito che, con la sua presenza e il suo ruolo dominante, è stato protagonista della storia dell’Italia repubblicana.
Un partito che seppe farsi interprete del paese, dei diversi interessi e delle diverse attese che emergevano dalla società civile, dal mondo del lavoro e delle professioni, con l’attenzione alle esigenze del mercato e dello sviluppo capitalistico, ma sensibile anche al bisogno di assistenza sociale e del sostegno dello Stato per le categorie più deboli dei cittadini, ispirando la propria azione al rispetto della persona e ad una visione pluralista e articolata della società, al di fuori da qualsiasi concezione di stampo classista.
Un partito che visse la sua dialettica interna a volte in forma vivace e irrequieta, attraversata da personaggi che, seppur animati da una comune ispirazione, maturata nell’ambito della loro formazione cristiana, seppur sorretti dall’esigenza dell’unità e della condivisione delle scelte, anche nei momenti più delicati, esprimevano diverse sensibilità e orientamenti, arricchendo, con la loro presenza la dialettica interna di in partito interclassista e non chiuso all’interno di una connotazione ideologica.
Insomma, in seno alla Democrazia cristiana troviamo una pluralità di personalità, ciascuna delle quali rappresentava, con le sue idee, il suo retroterra sociale e culturale e con i suoi legami con diverse realtà locali e regionali, un modo originale di essere democristiano, a testimonianza della complessa e flessibile fisionomia del partito.
Il libro di Giorgio Aimetti ha il merito di offrirci l’immagine di una delle espressioni più forti e incisive che hanno attraversato la storia italiana e la storia della Democrazia cristiana.
Una figura di primo piano che si distinse per la sua straordinaria personalità, nel ricco campionario di figure che la Democrazia cristiana ha saputo esprimere nel corso della sua storia.
Questo libro ci consente di ripercorrerne la lunga e incisiva presenza nelle vicende sociali e politiche del nostro paese, e per questo dobbiamo essere grati a Giorgio Aimetti.
LETTERE DI CARLO DONAT CATTIN
Lettera a Suor Teresilla
Cara sorella,
devo prima di tutto farmi perdonare per il ritardo col quale le rispondo, causato dalla mia vita randagia e dalla minima capacità di lavoro che mi rimane dopo l’infarto. Ma voglio soprattutto ringraziarLa per l’azione che svolge, con passione, per dare aiuto e riportare alla speranza giovani carcerati per terrorismo e in particolare per l’ultimo dei miei figli, Marco. Mi rendo conto di un’opera sacrificata, esposta alla conoscenza degli abissi del male, non soltanto contro la vita, ma anche e continuamente contro la dignità degli uomini in un sistema di reclusione antiquato e tendente a peggiorare anziché recuperare i condannati. Ma la nostra storia di comunità cristiana nasce ai piedi di un patibolo ed ha le sue radici alimentate dal sangue dei martiri, di infinite testimonianze nella carcerazione, nelle torture e nelle esecuzioni capitali finali. Che Dio l’assista e la Madre di ogni misericordia Le sia sempre vicina. La prego non soltanto per Marco, se pure l’egoismo parentale me lo richiama davanti a tutti nell’immaginazione e nel cuore, ma per tutti quelli che Lei riesce ad avvicinare, e per quelli che non sono avvicinati in alcun modo o non lo vogliono.
Nella mia vita ho cercato di pensare al prossimo, di operare per il prossimo, quello che il linguaggio cristiano chiama con questo nome, ma, me ne rendo conto, in forme più generali ed astratte: la giustizia per tutti, il miglioramento delle condizioni di vita, la promozione delle classi subalterne (…). Cosa diversa è l’incontro col prossimo, uomo per uomo, quel sofferente, quel carcerato, quel disperato; è in più di un caso peso lasciato ad altri, alla costituzione di corpi specializzati come quelli delle suore, per la ripugnanza o il fastidio istintivo ed edonistico provocato dalla nostra natura chiusa, e ad un tempo che ha eliminato ogni trascendenza e riduce la vita alla soddisfazione personale (…).
Questi sono alcuni dei ragionati motivi, cara sorella, per i quali non sono sordo alla sua passione e non mi irrito per la sua conseguente aggressività; e per i quali la mia gratitudine non sarà mai sufficiente.
Quando parla dei partiti, se ho bene inteso, lei parla del potere pubblico. Ed allora consideri che — rispetto a quanti hanno avuto coinvolgimento attivo nella lotta terroristica — l’azione dei pubblici poteri, con non pochi contrasti, è stata indirizzata alla clemenza verso chi abbia mostrato di dissociarsi dal suo passato, mentre è diventata pesantissima (…) verso chi non voglia sconfessarsi. Oggi l’attenzione è concentrata sul tema cosiddetto dei “pesci piccoli” per ottenere l’affrancamento. Credo che in un domani non lontanissimo e forse non lontano si giungerà a forme di remissione non dissimili da quelle stabilite già nel 1947 a beneficio dei fascisti di Salò ed anche dei partigiani che compirono reati nel corso della Resistenza, tenendo conto, tra l’altro, che quel periodo abbondò — come ogni guerra civile e politica — di nefandezze efferate.
Il compito essenziale del potere politico, alimentato dai partiti, ognuno con la
propria concezione della vita, è, nel caso, in questo campo. Devo dire che si è
stentato a far passare criteri di clemenza, specie rispetto alla mentalità media di
una fascia notevole del mondo cattolico. Mia moglie ed io abbiamo anche sentito il
gelo della ripulsa e dell’emarginazione. Molto più accentuate dal mondo comunista,
che — per altre ragioni — mi ritiene un nemico e, secondo i suoi sistemi, persona
perciò da eliminare, almeno moralmente. Ma, al di là del contatto umano dei
singoli, mentre tra i comunisti è prevalsa l’idea di una clemenza utilitaria — quella
verso il “pentito” in quanto delatore —, nel nostro mondo, in parte legato alla
mentalità inquisitoria, al rogo per la salvezza dell’anima, alla giustezza della pena
anticipata degli uomini, alla salutarietà dei tormenti, è stato ed è ancora difficile
entrare nell’anima del perdono. Agiscono in contrasto con quest’atteggiamento
donne e uomini come Lei, padre Bachelet, padre Riboldi, molti amici di C.L. e, in
generale, la mentalità più attenta della maggior parte dei sacerdoti (…).
Sul piano dei sentimenti non Le dirò molte parole. Marco sa di avere non soltanto
il perdono, ma l’amore di sua madre, dei suoi fratelli e mio. Sappiamo com’è difficile la vita carceraria e ci siamo resi conto, perciò, anche di alcuni errori
successivi. (…)
E mentre compio ogni tanto l’esame delle mie responsabilità per le vicende di
Marco, prego il Signore perché gli sia vicino anche attraverso la presenza Sua,
suor Teresilla, e degli altri che, nel nome di Gesù di Nazareth, sentono con più
forza l’amore. Con un cordiale saluto, Carlo Donat-Cattin.
*****
Lettera a Cossiga
Caro Cossiga,
mi vorrai perdonare del ritardo col quale, anche a nome di mia moglie, ti ringrazio
del biglietto che hai voluto con tanta premura e tanto affetto farmi giungere a
Torino subito dopo la morte di Marco. Sono rimasto in condizioni di non saper far
nulla altro che le cose meccanicamente conseguenti. La fede è faticosa per la mia
logorata umanità; eppure “tutto è grazia”. La prova più problematica è quella di
mia moglie: un figlio, giovane, ma il figlio che vivo lacera il cuore, viene ripreso
giorno per giorno, per anni di carcere (tutti quelli stabiliti, senza privilegi e
neppure consentite condizionali), recuperato da un amore senza confini. Ti ringrazia, in particolare, per il pensiero che le hai dedicato. Cerchiamo di pregare.
Ti abbraccio.
Condividi su Facebook



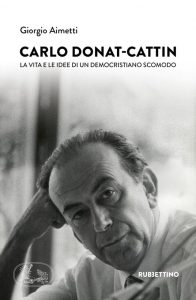 È ben noto come le vicende di quegli anni e in particolare il ruolo della Democrazia cristiana, siano stati – soprattutto a livello mediatico e nel giudizio di alcuni esponenti della nuova classe politica – oggetto di una sorta di demolizione, che tende a colpire l’intera storia politica italiana della seconda metà del secolo XX.
È ben noto come le vicende di quegli anni e in particolare il ruolo della Democrazia cristiana, siano stati – soprattutto a livello mediatico e nel giudizio di alcuni esponenti della nuova classe politica – oggetto di una sorta di demolizione, che tende a colpire l’intera storia politica italiana della seconda metà del secolo XX.


