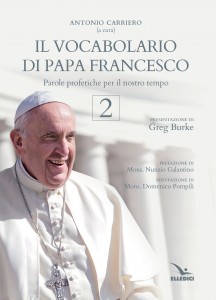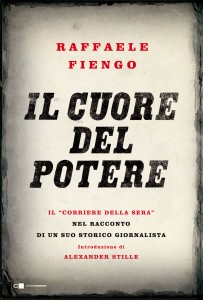Più medicine, più salute. Siamo ossessionati dal benessere e abbiamo talmente paura delle malattie (anche quelle inventate) che siamo disposti a ingerire qualsiasi pillola, e a credere a truffatori e guaritori senza scrupoli.
Bombardati da pubblicità ingannevoli, compriamo integratori di ogni specie senza sapere che per la maggior parte non servono a nulla, siamo disposti a sottoporci a esami più volte all’anno con costi elevatissimi anche quando non ce n’è bisogno, ci affidiamo a qualsiasi prodotto che sia naturale e biologico sicuri della sua efficacia, anche quando non provata scientificamente, e siamo in balia della prima novità farmaceutica che ci prometta di farci diventare più belli e più giovani. Poveri ingenui.
Ecco un libro che ci può aiutare. Di Grazia, medico di professione, combatte da anni contro truffe e ciarlatani. Riporta casi di farmaci inutili o addirittura dannosi spacciati per miracolosi, dal nuovo prodotto contro l’Alzheimer allo scandalo dell’Oscillococcinum, o di certi psicofarmaci o antidolorifici causa di morte e disturbi gravissimi. Tutto provato e documentato.
Essere informati è l’unica cura che può salvarci da facili illusioni e aiutarci a essere cittadini e pazienti più sani e consapevoli.
L’AUTORE
Salvo Di Grazia è un chirurgo specialista in Ginecologia e Ostetricia, medico ospedaliero e divulgatore scientifico. Appassionato di musica e internet. Scrive per diverse testate e siti, collabora con “Le Scienze” e “il Fatto Quotidiano”. Ha fondato nel 2008 e gestisce il blog MedBunker che è diventato con il tempo punto di riferimento sulla medicina e contro i ciarlatani della salute. Nel 2014 ha pubblicato il libro SALUTE E BUGIE (Chiarelettere) sulle terapie truffaldine.
http://medbunker.blogspot.it
Per gentile concessione dell’editore pubblichiamo un estratto del libro.
La truffa degli integratori alimentari
Fin da piccoli ci hanno convinto che, per stare meglio (ma se si sta già bene, perché dovremmo stare meglio?), è necessario (quasi obbligatorio) assumere vitamine, pillole e bustine. Un integratore, per legge, non può vantare effetti terapeutici (ovvero non può sostenere di «curare» o «guarire» da una malattia) e per questo ha una procedura di approvazione molto più semplice rispetto a quella dei farmaci standard. Questi ultimi, per essere venduti, devono superare molti test e autorizzazioni. Devono dimostrare di essere sicuri ed efficaci, bisogna presentare degli studi che ne attestino gli effetti e che vengono passati al vaglio degli enti preposti (in Italia l’Aifa, Agenzia italiana del farmaco, in Europa l’Ema, European Medicines Agency, negli Stati Uniti la Fda, Food and Drug Administration) e solo dopo diverso tempo possono essere messi in commercio. Gli integratori non sono sottoposti a un iter così rigoroso: basta dimostrare che siano innocui. Quando li compriamo, quindi, sappiamo semplicemente che non fanno male, ma non abbiamo alcuna certezza della loro efficacia: la maggioranza degli integratori in vendita non serve a niente. Ma allora perché hanno tanto successo? Per il solito motivo: siamo alla continua ricerca di un rimedio per i nostri problemi, veri o ipotetici che siano. Prendiamo per esempio gli antiossidanti. Non mi dite di non aver mai sentito parlare dei loro benefici, ne discutono ovunque in maniera quasi martellante. Esperti e medici sono d’accordo: per sconfiggere i radicali liberi (che tra le altre cose ci fanno invecchiare e ammalare) gli antiossidanti sono un’autentica panacea. Sono contenuti in molti alimenti (economici, come la frutta e la verdura) ma possiamo anche assumerli in pratiche capsule (acquistandole a caro prezzo, s’intende). Ma i prodotti della terra non esercitano sui consumatori lo stesso fascino di una pillola colorata, sono troppo semplici, ordinari, neanche ci sembra credibile che possano contenere sostanze capaci di contrastare l’invecchiamento e la malattia. Meglio assumere una piccola compressa che si manda giù con un sorso d’acqua, che magari contiene ingredienti dai nomi altisonanti e che evocano effetti portentosi. Noi non vogliamo stare meglio, vogliamo il miracolo. Non si spiegherebbe altrimenti il successo immotivato degli innumerevoli prodotti inutili venduti come fondamentali per la salute, e che troviamo sia in farmacia sia al supermercato. Si stima che il mercato statunitense degli integratori ammonti a oltre 30 milioni di dollari, in Italia è ovviamente più contenuto ma solo perché la nostra popolazione è numericamente molto inferiore a quella americana. Il dato è sorprendente, visto che in assenza di malattie o carenze specifiche un integratore non serve a nulla: né a stare meglio né tantomeno a guarire da qualcosa che non abbiamo. Vitamine, sali minerali, sostanze e derivati vegetali rappresentano un mercato enorme che ormai anche le grandi aziende farmaceutiche si vogliono accaparrare, e non a caso le due classi di integratori più vendute sono quelle relative ai dietetici e agli stimolanti sessuali, seguite dai prodotti per palestre. In molti di questi sono addirittura contenute sostanze tossiche e proibite, come i derivati delle anfetamine. Il pericolo si scopre solo quando si effettuano controlli mirati sul prodotto, cosa che, come abbiamo detto, non avviene prima del rilascio sul mercato. Una recente indagine giornalistica del «New York Times» ha dimostrato che molti integratori presenti sul mercato americano contenevano componenti non permesse, e peraltro non elencate tra gli ingredienti, che hanno causato gravi effetti collaterali, e che in tre quarti degli integratori a base di olio di pesce (venduti per i loro presunti, ma per niente accertati, effetti positivi sul sistema nervoso e sull’intelligenza) non era contenuto il quantitativo di omega-3 (la molecola che avrebbe l’effetto positivo) dichiarato in etichetta. Il boom dell’olio di pesce è legato anche alla prevenzione delle malattie cardiache ma, ancora una volta, non sembra esserci alcuna evidenza dei suoi effetti benefici. Non è così scontato che l’assunzione o l’integrazione (non necessaria) di una vitamina possa essere utile alla salute, anzi. Si è visto, per esempio, che l’assunzione di calcio, alla quale spesso si ricorre per prevenire i problemi ossei, non è soltanto inutile perché meno efficace di altre terapie, ma può essere anche dannosa, visto che sembra aumentare di circa il 20 per cento il rischio di problemi cardiovascolari (ictus, infarti). Lo stesso discorso si può fare per gli antiossidanti. Quelli contenuti negli alimenti sono utili, contrastano la degenerazione delle cellule e riescono persino a prevenire alcune malattie, ma quelli assunti come «medicina» non sembrano avere gli stessi effetti, anzi, alcuni studi hanno evidenziato pericolose controindicazioni: nelle cavie, per esempio, l’assunzione di antiossidanti ha causato il peggioramento del melanoma, un tumore cutaneo. Alcuni medici prescrivono integratori a base di glucosamina e condroitina, due sostanze ritenute benefiche per certe malattie osteoarticolari come l’artrite o per dolori alle ossa e altri disturbi delle articolazioni. Nonostante qualche evidenza positiva, non mancano certo prove della loro assoluta inutilità, come quelle notate nei confronti dei dolori dell’artrite: mentre un antinfiammatorio li riduceva, gli integratori di glucosamina o condroitina sortivano quasi lo stesso effetto di un placebo (ovvero una sostanza neutra, priva di qualsiasi effetto). Altri studi hanno rilevato un miglioramento lieve o moderato. Persino i noti fermenti lattici, se presi a sproposito, possono essere inutili, quando non dannosi. Si tratta infatti di batteri di vario tipo (si chiamano «probiotici») che vivono nel nostro intestino aiutandone le funzioni e che possono avere un ruolo positivo anche dal punto di vista immunitario. Sono contenuti in molti alimenti (come lo yogurt o i formaggi) e spesso sono prescritti per prevenire o curare la diarrea (come quella causata dall’uso di antibiotici). Alcuni studiosi hanno fatto notare che i benefici vantati dai probiotici presenti in alcuni alimenti sono annullati dall’eccessivo contenuto in zucchero degli stessi, che anzi finirebbe per renderli nocivi. Inoltre uno studio pubblicato sul «Lancet» ha constatato che la diarrea da antibiotici ha avuto gli stessi identici (piccoli) benefici sia dai probiotici sia da un placebo (un flaconcino di acqua zuccherata), negli individui oltre i sessantacinque anni. Questi esempi possono farci capire che se alcune vitamine o sostanze possono avere un’utilità in certe condizioni, in altre (e nella maggioranza dei casi) non servono a nulla. Pensate poi al business degli integratori in gravidanza. Alle donne in attesa viene consigliata l’integrazione con acido folico perché in grado di prevenire un grave problema alla colonna vertebrale del feto, anzi, dovrebbe essere assunto già prima del concepimento e fino all’undicesima settimana di gestazione, dopodiché la sua efficacia è trascurabile, anche perché lo assumiamo già normalmente con la nostra alimentazione. Utile può essere anche l’integrazione di vitamina D. Tutte le altre vitamine e sostanze che servono in gravidanza sono assunte con la normale dieta quotidiana che, ovviamente, deve essere ben bilanciata e varia. Eppure sono prescritti alle donne incinte svariati multivitaminici, prodotti che integrano decine di vitamine e sali minerali, componenti essenziali per la vita ma che, in una donna in salute e che si alimenta bene, non hanno necessità di integrazione o maggiore consumo. Da non sottovalutare il costo di questi prodotti, in genere elevato. Un affare per chi li produce. Eppure gli integratori rappresentano un richiamo irresistibile per il consumatore e per procurarseli non serve neanche una prescrizione, esattamente come se acquistassimo un gioco, un panino o un frutto: semplice e veloce. E sono spinti da un marketing aggressivo proprio perché prevedono un investimento molto basso a fronte di un guadagno (per il produttore) sicuramente interessante che punta sull’illusione del benessere di tutti noi. Tra i prodotti che hanno un inspiegabile successo di mercato ci sono anche le acque oligominerali (che contengono pochi sali minerali, come il magnesio, il sodio, il potassio e altre componenti normalmente presenti nelle acque potabili e fondamentali per la nostra salute). Ora, oltre al fatto che i sali minerali sono utili e non dannosi (e quindi non c’è alcun motivo per preferire un’acqua con pochi sali minerali rispetto a quella normale di rubinetto), spesso chi assume gli integratori lo fa con l’acqua oligominerale, sciogliendovi le bustine solubili o bevendone un sorso per mandar giù una pillola. Avviene dunque un fenomeno curioso: compriamo un integratore che ci fornisca sali minerali, evidentemente considerandoli utili, e lo assumiamo con un’acqua povera di sali minerali. Non siamo proprio strani noi consumatori?