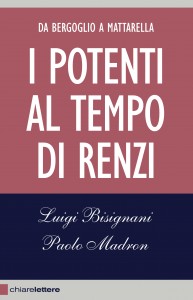Dopo il voto delle regionali il PD si sta interrogando, con forte tensione, sulle cause di questa “brutta vittoria”. Ne parliamo con Giorgio Tonini, vice-presidente del gruppo PD al Senato.
Dopo il voto delle regionali il PD si sta interrogando, con forte tensione, sulle cause di questa “brutta vittoria”. Ne parliamo con Giorgio Tonini, vice-presidente del gruppo PD al Senato.
Senatore Tonini, il test elettorale delle regionali segna, al di là del dato numerico (5 a 2 a favore del PD), una battuta d’arresto della forza propulsiva di Renzi. La clamorosa sconfitta della Paita in Liguria e quella della Moretti in Veneto pongono problemi politici pesanti. Cosa non ha funzionato?
Lei dice “al di là del dato numerico”. E certo non possiamo fermarci al 5 a 2. Ma non possiamo neppure prescinderne. In qualunque paese del mondo, un partito di governo che, a più di un anno dal suo insediamento, a luna di miele col paese ormai dimenticata, nel pieno di riforme difficili, controverse e conflittuali, spesso proprio con la propria costituency elettorale, rafforzasse o anche solo mantenesse il suo primato nei poteri locali, verrebbe considerato un vincitore e non uno sconfitto. Il Pd oggi governa 17 regioni italiane su 20. Abbiamo perso la Liguria, ma conquistato la ben più popolosa Campania. Molti vorrebbero perdere sempre così. I nostri cugini socialisti francesi, che con Hollande e Valls governano a Parigi, si sono svegliati terzi alle elezioni amministrative, dopo il centrodestra di Sarkozy e la destra di Le Pen. Noi ci siamo svegliati con qualche livido, ma ancora primi. Detto questo, è evidente che abbiamo avuto due sconfitte, certamente gravi. La più grave in Veneto, perché lì eravamo tutti uniti, mentre la destra si era divisa, e ciò nonostante siamo andati indietro, molto indietro, rispetto alle europee. L’altra sconfitta, quella in Liguria, è invece in gran parte figlia delle nostre divisioni interne: divisi, siamo stati battuti da un centrodestra che, per quanto unito, si è fermato sotto il 35 per cento. Due sconfitte e cinque vittorie. Io la chiamo, vista nel suo complesso, una brutta vittoria, una vittoria ai punti, rispetto alla bella vittoria per ko delle europee. Ma una brutta vittoria è sempre meglio di una bella sconfitta.
Qualunque vittoria sarebbe peraltro una vittoria dimezzata, in presenza di un così elevato tasso di astensione, che ha sfiorato stavolta il 50 per cento. Non crede che il Pd abbia fin qui sottovalutato questo fenomeno? Non sarebbe ora di interrogarsi su di esso in modo meno rituale e superficiale?
Sono d’accordo con lei. Penso anche che a poco servano recriminazioni e lamentazioni. A mio modo di vedere, nell’astensione di domenica scorsa si sono saldate tre componenti. La prima, quella di fondo e di lungo periodo, ha a che fare con la secolarizzazione della politica. Su questa questione, che da decenni interroga i filosofi e i sociologi della politica, c’è poco di nuovo da dire e forse anche poco da fare. La seconda componente, più recente (in Italia la sua comparsa ha coinciso con la crisi della seconda Repubblica e della guerra civile fredda tra berlusconismo e anti-berlusconismo), ha alla base la protesta contro la “casta” dei politici, più che la politica come tale. Su questo versante i rimedi sono chiari: bisogna completare l’opera di disboscamento della gìungla dei privilegi dei politici, sapendo peraltro che neppure questo sarà sufficiente, se non si riuscirà a dimostrare che la politica può riuscire a cambiare in meglio le cose, la vita concreta dei cittadini. Il Pd e il governo Renzi su questa scommessa si giocano il futuro. Infine, la terza componente, misurabile in un buon 10-15 per cento, esprime il distacco radicale rispetto all’istituzione regione in quanto tale. Non a caso, nelle città dove si votava per i sindaci, la percentuale di partecipanti al voto è salita ben oltre il 60 per cento. E oltre il 60 era stata la partecipazione alle europee, segno che l’Europa, nel bene e nel male, coinvolge le menti e i cuori degli italiani più delle regioni. Credo che in particolare su quest’ultima componente del non voto sia urgente una riflessione e un piano d’azione, per rilanciare la credibilità dei governi locali, la loro funzione democratica, che oggi se forse non è ancora compromessa, è indubbiamente assai appannata. La riforma del Senato e del titolo V deve essere l’occasione per questo rilancio.
Quello che si è notato, prendendo i due casi emblematici (Campania e Liguria), è la distanza tra la realtà nazionale e il livello locale. Insomma il gruppo dirigente nazionale è parso debole nell’imporre i criteri della rottamazione. Così siete andati al voto da una parte (Liguria) con un candidato debole, Paita, che rappresentava la continuità con Burlando, e dall’altro con “l’impresentabile” De Luca che vi creerà, con la sua vittoria, non pochi problemi. Insomma oltre al dato politico emerge una “insipienza” politico-organizzativa. Non è venuto il tempo di superare la “cultura dell’uomo solo al comando”?
Se davvero ci fosse, nel Pd, un uomo solo al comando, Renzi avrebbe potuto scegliere i candidati a sua immagine e somiglianza. Come faceva Berlusconi. Ma il Pd non è Forza Italia. Lì, per statuto, è (o era) il leader a scegliere i candidati, tutti i candidati. Noi siamo un’altra cosa. Da noi i candidati li scelgono i cittadini con le primarie. E così è stato anche stavolta. A parte i due uscenti, che non sono stati sottoposti a primarie perché nessuno li ha sfidati, Rossi in Toscana e la Marini in Umbria (peraltro né l’uno né l’altra definibili come renziani, ma semmai lealmente e apertamente collocati nel partito su opposte sponde rispetto al segretario), tutti e cinque gli altri sono stati scelti con la partecipazione decisiva di centinaia di migliaia di nostri elettori. Neppure le primarie sono un sistema perfetto. Vincere le primarie non garantisce la vittoria alle elezioni. Ma noi non ci chiamiamo Partito democratico per finta. E Renzi, e con lui tutti noi, ha fatto campagna elettorale per sette candidati che, alle primarie nazionali del 2012, avevano tutti sostenuto Bersani e non lui. E lui li ha sostenuti, tutti e sette, perché erano i nostri candidati, i candidati del Pd, scelti dai nostri elettori con le primarie. Detto questo, è evidente che c’è un problema, grande come una casa, di rinnovamento della classe dirigente diffusa: un rinnovamento che per ora si è in gran parte fermato a Roma e ha solo lambito i territori. Bisogna dedicarsi con più energia a questo lavoro, assolutamente fondamentale. Ma nel rispetto del nostro modello di democrazia, dunque formando e selezionando una nuova generazione di dirigenti, capace di farsi valere nel confronto democratico, non imponendo o eliminando qualcuno attraverso un di più di dirigismo.
Veniamo al quadro interno al PD. Anche qui ci sono problemi a non finire. Ovvero il ruolo della minoranza interna. Non le pare che un’altra lezione di queste elezioni sia quella di recuperare il “metodo Mattarella” (ovvero la ricerca delle scelte condivise)? Ha qualcosa da dire alla minoranza?
Come è normale che sia, fa più rumore un albero che cade di una foresta che cresce. L’albero ligure è caduto, sotto il peso delle nostre divisioni, e ha fatto molto rumore. Ma in tutte e sei le altre regioni, il Pd è stato unito, vincendo in cinque casi e perdendo in Veneto. Dunque, quello che lei giustamente chiama il “metodo Mattarella”, ovvero la ricerca delle scelte condivise, se non nel merito, almeno nel metodo (democratico), è il modo ordinario di vivere e di decidere dentro il Pd. Perché questo metodo possa funzionare, c’è però bisogno di richiamare una precondizione: tutti devono sentirsi impegnati dalle decisioni che, democraticamente, si prendono insieme. Una parte della minoranza, forse perché non le era mai capitato di non essere maggioranza, questo principio fa fatica ad accettarlo e rivendica il diritto di votare come crede nelle assemblee elettive e addirittura di presentare candidati alternativi alle elezioni. Il problema è che nessun partito democratico può funzionare così. Su questo punto, dunque, un chiarimento fra noi è necessario e urgente. Non c’è, peraltro, solo un problema di metodo. Le vicende interne al Pd hanno messo in evidenza anche un problema di sostanza, vorrei dire politico-culturale. Il mito fondativo del Partito democratico non è l’unità delle sinistre, ma l’unità, si potrebbe dire il ricongiungimento, dei riformisti, storicamente divisi in partiti e perfino in schieramenti diversi, in un riformismo nuovo, capace di confrontarsi in modo positivo con i grandi cambiamenti del nostro tempo. Per una parte della nostra minoranza, rischiare (e sottolineo la parola rischiare) un riformismo nuovo, non è adempiere alla nostra missione di democratici, ma tradire la nostra storia. Così come sfidare le pigrizie della sinistra conservatrice, politica e sindacale, è infrangere il mito, duro a morire, nonostante la nascita del Pd, la lezione di Veltroni e la rivoluzione di Renzi, dell’unità delle sinistre e del “pas d’ennemis à gauche”. Su questo crinale, per così dire “ideologico”, è raccomandabile il massimo rispetto reciproco e un modo di argomentare e discutere pacato, ma non si può chiedere a Renzi e a tutti noi di diplomatizzare le differenze, fino a ridurre un sano perché vero conflitto politico ad una questione di buone maniere.
E veniamo alla vicenda della Presidente dell’Antimafia, Rosy Bindi. Lunedì sera, a “Piazzapulita”, ha chiesto le scuse da parte del PD per come è stata trattata da alcuni esponenti del suo partito. Un episodio che brucia sulla “pelle” del suo partito…
Non saprei, può darsi che qualcuno abbia usato nei suoi confronti qualche parola di troppo. Resta il fatto che Rosy ha gestito un passaggio delicato e difficile, come la prima applicazione di un codice di autoregolamentazione ad un processo elettorale, in modo assolutamente sbagliato. Non lo dico io, lo hanno detto in modo inequivoco personalità insospettabili come Saviano o Cantone. Mi permetto di aggiungere che nessuna delle vicende giudiziarie che riguardano De Luca ha a che fare con la mafia o la criminalità organizzata. E dunque la sua inclusione in quella lista di “impresentabili”, peraltro alla vigilia del voto, quindi negando di fatto a lui e al Pd, come agli altri coinvolti nella vicenda, qualunque diritto di replica efficace, è stato un colpo basso che ha inquinato in modo grave il confronto elettorale. Sarebbe stato inaccettabile nei confronti di un avversario. Nei confronti di un compagno di partito lascia senza parole.
L’idea del Partito della Nazione è uscita bocciata dall’esito elettorale. Lo sfondamento a Destra non c’è stato. E questo impone sicuramente un ripensamento verso una identità più “ulivista” del partito. E’ così per lei?
Dalle elezioni regionali il Pd esce confermato nella sua funzione di “partito del Paese”, non solo perché governa 17 regioni su 20, ma anche e soprattutto perché è l’unico partito che non si limita a dare voce alla rabbia e alla paura, magari alimentandole cinicamente, ma cerca di produrre risposte di speranza attraverso l’azione politica e di governo. È vero che, rispetto alle elezioni europee, in particolare in Veneto, ma anche, in misura minore, in Liguria e in Umbria, il centrodestra ha ripreso parte dello spazio elettorale che gli avevamo sottratto. Al contrario di tanti, anche nel Pd, che paventavano la nascita del regime del partito unico renziano, non ho mai pensato che il travaso di voti dal centrodestra verso di noi fosse irreversibile. Allo stesso modo, oggi non penso che noi democratici dobbiamo tornare a considerare irraggiungibili i voti di quel fitto tessuto produttivo, civile, sociale, culturale, che è la forza di molti nostri territori, in particolare ma non solo al Nord, e rassegnarci a rientrare nel nostro tradizionale recinto identitario. Le europee hanno dimostrato, un anno fa, che quei consensi sono contendibili. E noi democratici dobbiamo restare coi piedi ben piantati in quella contesa. Solo in questo modo, peraltro, il Pd può essere il degno erede della stagione fondativa dell’Ulivo, che fu animata proprio dallo slancio verso l’unità dei riformisti, alla conquista di consensi in tutta la società italiana.
Certamente iI vincitore politico è stata la Lega di Salvini e c’è stata anche la tenuta del movimento 5 stelle, che ha ottenuto risultati rilevanti. Chi deve temere di più Renzi?
Il politologo Salvatore Vassallo ha corretto l’analisi del voto proposta a caldo dall’Istituto Cattaneo e che confrontava le mele dei voti di lista alle regionali, con le pere di quelli alle europee. Vassallo ha ripreso la più convincente metodologia, da lui stesso elaborata nell’ambito del Cattaneo, del confronto tra le performance elettorali, non delle singole liste, ma di aree politiche omogenee (centrosinistra, centrodestra, M5S), in modo da tener conto delle diverse modalità tattiche adottate dalle forze politiche nelle diverse elezioni, regolate, come è noto, da differenti leggi elettorali. Sulla base di questo metodo di calcolo, Vassallo conclude che il Pd-centrosinistra ha avuto una flessione nazionale di circa 5 punti (più che fisiologica per una forza alle prese con difficili problemi di governo) e territorialmente concentrata in Veneto e Liguria, che lo ha portato dal 42,3 per cento delle europee al 37,1 delle regionali. Al contrario, grazie alla Lega ma non solo, il centrodestra ha riconquistato quasi 13 punti percentuali, riportandosi al 35,2 rispetto allo sprofondo del 22,4 di un anno fa. Sulla base di questi dati, è assai probabile che lo sfidante del Pd, alle prossime elezioni politiche, sia il centrodestra. Anche perché il M5S esce dalle regionali al 15,7 per cento, quasi 10 punti in meno delle politiche e quasi 20 sotto l’area di centrodestra. Naturalmente, per risultare davvero competitivo, il centrodestra deve trovare uno Zaia nazionale: un federatore capace di rappresentare una proposta di governo e di assorbire e metabolizzare la Lega di Salvini, utilizzandone la forza, ma senza cederle la guida. Un’impresa non impossibile, ma tutt’altro che facile.
Ultima domanda: la legislatura arriverà al 2018?
Non sono una chiromante e non mi avventuro in previsioni. Registro solo che il Pd ha tutto l’interesse ad arrivare al 2018 per cercare di trarre il massimo beneficio, in termini di consenso, dagli effetti delle riforme, in particolare in termini di ripresa della crescita e dell’occupazione. Ma anche il centrodestra ha bisogno di tempo, per gestire un’operazione difficile come l’uscita di scena di Berlusconi e l’individuazione di un nuovo assetto e una nuova leadership. Entrambi i principali schieramenti hanno interesse a completare la riforma costituzionale e in particolare quella del Senato, senza la quale potremmo trovarci di nuovo in un Parlamento senza un chiaro vincitore, alle prese con la formazione dell’ennesimo governo non deciso dagli elettori.