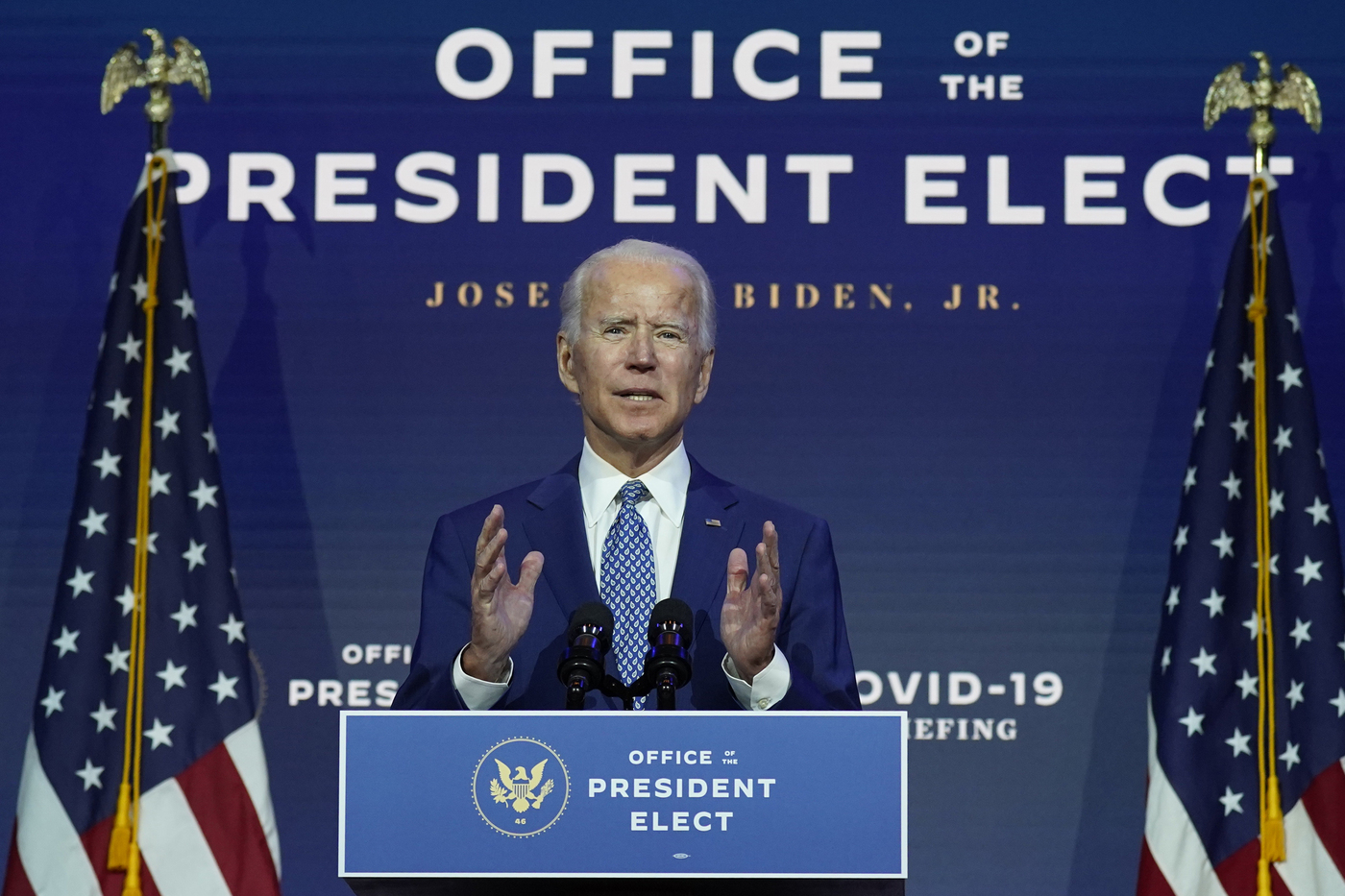Con le loro fondazioni dominano il mondo. Sempre più potenti sono le
fondazioni dei moderni “filantropi”, ma sarebbe meglio definirli
“filantropicapitalisti”. I loro nomi? Sono i soliti Gates,
Tuner, Zuckeberg. Senza dimenticare i Rockefeller. Il “turbocapitalismo”
trova, così, altri spazi di dominio. Ma quali sono i nuovi ambiti in cui
esercitano il loro potere di influenza politico e sociale? Ne parliamo con
Nicoletta Dentico, giornalista d’inchiesta, autrice di un saggio, molto
documentato, appena uscito in libreria: “Ricchi e buoni? Le trame oscure del
filantrocapitalismo” (Editrice Emi, pagg. 288, Euro 20). Nicoletta Dentico, è
esperta di cooperazione internazionale e diritti umani. Ha coordinato in Italia
la Campagna per la messa al bando delle mine vincitrice del Premio Nobel
per la Pace nel 1997, e diretto in Italia Medici Senza Frontiere con un ruolo
importante nel lancio della Campagna per l’Accesso ai Farmaci Essenziali.
Cofondatrice dell’Osservatorio Italiano sulla Salute Globale (Oisg), ha
lavorato a Ginevra per Drugs for Neglected Diseases Initiative, e poi per
l’Organizzazione mondiale della sanità. Dal 2013 al 2019 è stata consigliera
di amministrazione di Banca Popolare Etica e vicepresidente della
Fondazione Finanza Etica. Dirige il programma di salute globale di Society for
International Development (Sid).
 Nicoletta, è davvero molto interessante il tuo libro. È una autentica
Nicoletta, è davvero molto interessante il tuo libro. È una autentica
radiografia del turbocapitalismo contemporaneo. Infatti sotto la
“filantropia” c’ è un preciso disegno economico-culturale e quindi
anche politico… È così?
Distinguerei fra filantropia tout court e filantrocapitalismo, che è la fattispecie
di strategia filantropica che il mio libro vuole illuminare. Che cos’è, il
filantrocapitalismo? E’ un modello operativo con cui i ricchi imprenditori del
mondo industrializzato riescono a intrecciare la loro azione imprenditoriale
con la azione umanitaria, ovvero l’ideazione di “un’azione del bene” – diciamo
così – che serve in buona sostanza ad oliare gli ingranaggi delle imprese,
industrie multinazionali perlopiù, per favorire la loro progressiva penetrazione
e influenza nei luoghi delle decisioni politiche, a livello internazionale. Nella
logica del filantrocapitalismo scompare il discrimine tra mondo profit e mondo
non profit, anzi la lotta alla povertà diventa un approccio nuovo ed efficace ad
assicurare la massimizzazione del profitto. I ricchi filantrocapitalisti sono
convinti infatti che il mercato sia la sola soluzione alle sfide del pianeta e alle
esigenze di miglioramento sociale che riguardano gran parte della
popolazione mondiale. Da vincitori della globalizzazione, in un ordine
economico che divide il mondo sempre di più tra sommersi e salvati, i ricchi
filantropi si sono messi a gestire anche i poveri con traiettorie che quasi mai intaccano, anzi talvolta persino rafforzano, le dinamiche di ingiustizia che
governano il mondo. Ma il potere dei loro soldi ha una capacità di seduzione
senza pari, anche nei confronti della politica.
Vediamo le origini del fenomeno. Lo sappiamo che in sé la “filantropia”
esprime “amore per l’umanità”. Ma è nel contesto americano drlla fine
dell’ottocento e i primi del novecento, con Carnegie e Rockefellerr, che
la filantropia esegue la sua mutazione “genetica” : diventa “amore”
calcolato. Come si sviluppa la loro “filantropia”?
La consuetudine del “dono” come meccanismo sociale di relazioni risale agli
albori della storia umana, come ci ha spiegato il sociologo francese Marcel
Mauss, ed è una azione sociale che investe molti ambiti della vita, da quella
affettiva e religiosa a quella economica. La nascita invece della filantropia
organizzata, delle prime fondazioni che strutturano e professionalizzano la
beneficienza risale alla prima industrializzazione in America, che coincide con
la costruzione di una nazione dalla natura profondamente oligarchica. Il
nuovo capitalismo industriale della fine dell’800 favorisce il repentino sviluppo
di grandi fortune legate alla costruzione di ferrovie e strade, alle estrazioni
petrolifere, alla nascita dell’industria dell’acciaio. I Rockefeller e i Carnergie –
pur nella differenza delle loro storie – sono i due grandi plutocrati apripista.
Arricchitisi grazie ai loro monopoli industriali – nel settore del petrolio
(Standard Oil) e dell’acciaio (Carnegie Steel Company) rispettivamente – i
due tycoon decisero di mettere in campo una parte delle loro fortune per
compensare la immagine di imprenditori senza scrupoli, ma soprattutto per
neutralizzare le spinte di rinnovamento sociale che premevano da parte delle
classi sociali sfruttate e poco pagate. Insomma, una forma nuova di
bipolarismo tra capitalismo sfrenato alla ricerca di profitti, e paternalistica
beneficienza con il denaro spietatamente ammassato. Il Vangelo della
Ricchezza, il libro di Carnegie del 1889 che spiega questa strategia, è un vero capolavoro in questo senso, e servirebbe anche per capire i filantropi più moderni.
Tornando al filantropocapitalismo tu affermi che alla base c’è
l’ottimismo del win-win. Cosa vuol dire?
L’ottimismo del win-win (vincono tutti, per intendersi) deriva dalla convinzione
che il metodo imprenditoriale sia il miglior veicolo del miglioramento umano.
Con le erogazioni e soprattutto gli investimenti a favore dei poveri, è possibile
per le fondazioni filantropiche far approdare le loro imprese di riferimento in
paesi comunque non ancora colonizzati e dunque promettenti, grazie a molte
facilitazioni fiscali, o addirittura con fondi pubblici quando si tratta di
programmi internazionali di sviluppo. Vincono i poveri, e vincono i ricchi. La
logica win-win è semplice: se i poveri vengono trasformati in consumatori ,
non saranno più emarginati, perché alla fine anche loro staranno sul mercato.
E da clienti possono riconquistarsi la loro dignità.
Una delle frasi più importanti del tuo libro è : “la diseguaglianza è il
liquido amniotico del filantropocapitalismo”. Questa, secondo me, è la
chiave di lettura di tutto il libro. Alla fine l’opera del
filantropocapitalismo è la perpetuazione delle grandi differenze sociali.
È così?
Certo. Questa forma di filantropia strategica, e vorrei dire egemonica, è al
tempo stesso un effetto della deregolamentazione dell’economia e delle
finanza, e quindi un sintomo di un sistema capitalistico generalmente inadatto
e indisponibile a redistribuire le ricchezze da un lato. Ma è anche una
garanzia di mantenimento del potere finanziario, in un campo di gioco senza
regole. Sappiamo che i soldi parlano. Sappiamo che la concentrazione di
ricchezza nelle mani di pochissime persone – un fenomeno che ha raggiunto
livelli mai visti prima nella storia – implica la affermazione di un potere che è
in grado di soppiantare anche la sfera politica. Inoltre non dimentichiamo che la azione filantropica, soprattutto quando si parla di grandi fondazioni
miliardarie, è uno degli escamotage di
agevolazione fiscale più robusti che si possano immaginare. E dunque il
paradosso è che sono i cittadini che pagano le tasse a sovvenzionare i
filantropi senza aver voce in capitolo sulle loro scelte, invece di destinare quei
soldi alla fiscalità generale degli stati.
Facciamo qualche nome: Gates, Turner, i Clinton, Zuckerberg, Soros
ecc. Fanno riferimento agli USA e in Europa?
In effetti mi sono occupata perlopiù di filantropi americani, perché è lì che il
fenomeno del filantrocapitalismo si è affermato con maggior vigore e capacita
di ramificazione negli ultimi 20 anni. Ma il fenomeno filantropico sta dilagando
ovunque, si contano oltre 200.000 fondazioni nel mondo, 85.000 delle quali
sono insediate in Europa. Alcune delle realtà più affermate di
filantrocapitalismo in salsa europea sono quelle delle fondazioni di impresa
(corporate foundations), che sono nate negli ultimi anni, sulla scorta degli
Obiettivi del Millennio e ora con gli Obiettivi dello Sviluppo Sostenibile delle
Nazioni Unite. Penso alla Stiching INGKA Foundation, creata nel 1982 da
Ingvar Kamprad, il miliardario svedese che ha fondato IKEA; alla Nestlé
Foundation, che ha aperto anche un suo dipartimento salute (Nestlé Health
Service); la Welcome Trust in Gran Bretagna, che si occupa di ricerca
scientifica; la Robert Bosch Stiftung; la Vodafone Foundation, ramificata in
quasi tutti i paesi europei.
Parli molto di Gates e un pò di Soros. In cosa si differenzia Soros
rispetto agli altri?
Soros non persegue una agenda filantrocapitalista nel senso tecnico del
termine. George Soros con la sua Open Society Foundations persegue una
agenda di promozione dei diitti civili, non partecipa ai processi internazionali
delle Nazioni Unite e la sua filantropia non si porta dietro la interazione strutturale con il settore privato, come invece fanno Gates, Zuckenberg,
Clinton e altri. Soros è un filantropo iconoclasta, non per nulla i settori che
maggiormente sostiene riguardano i fenomeni migratori e le questioni sulla
proprietà intellettuale. Insomma, Soros è tutta un’altra storia!
Con la potenza del denaro riescono a condizionare Stati ed
Organizzazioni internazionali (ONU). Un esempio è la presenza
tentacolare della Fondazione di Gates. Anche qui ha avuto fiuto….dove
si sviluppa il suo progetto filantropico? Ci sono conflitti di interesse
con Microsoft?
Mutuando da Umberto Eco, potremmo definire Bill Gates l’Ur-filantropo. Il più
iconico, il più ricco, il più potente, il più intrusivo. Anche quando l’OCSE fa la
mappatura della filantropia, lascia da parte Gates perché la storia della sua
fondazione è un capitolo a parte. Gates sviluppa il suo progetto filantropico in
ogni ambito della vita umana. Il suo percorso è iniziato nel campo della
salute, e io mi sono confrontata con la sua fondazione su questo terreno. Ma
si occupa di nutrizione e agricoltura con il progetto di Rivoluzione Verde in
Africa, di cui parlo nel mio libro, insieme alla Rockefeller Foundation, si
occupa di cambiamenti climatici, di modelli di inclusione finanziaria, di
educazione (soprattutto in America), di ricerca scientifica, di politiche nel
campo dell’energia. E’ praticamente impossibile sfuggire al suo raggio di
azione. La storia di Microsoft e della sua Fondazione vanno di pari passo da
parecchio tempo, soprattutto nel campo della agricoltura in Africa questo
intreccio si è molto rafforzato come tento di raccontare nel mio libro. La spinta
alla digitalizzazione che COVID19 ha imposto al mondo non farà altro che
accelerare e irrobustire i fenomeni di interazione tra le attività di Microsoft e
quelle della Fondazione Gates.
Continuiamo a parlare di Gates. Sappiamo che è molto interessato alla
ricerca sul vaccino anti Covid. Come si intrecciano le cose?
Bill Gates nel 2015, dopo lo scoppio di Ebola in Africa, fece confluire a
Seattle importanti esponenti della comunità scientifica per la definizione di
scenari sanitari. In quella occasione fu annunciato che un patogeno molto
contagioso sarebbe arrivato prima o poi, ed era solo una questione di tempo.
Da quel momento la sua fondazione ha irrobustito gli investimenti nelle
industrie farmaceutiche e soprattutto biotech. In America, in Europa, in Cina.
Dunque, al momento dell’arrivo di Covid19, Gates era probabilmente l’uomo
più preparato per organizzare la rete internazionale di industrie di cui è
importante investitore. Anche perché è sempre Gates che ha creato le entità
pubblico-private più accreditate ormai nella orchestrazione di ricerca e
produzione di vaccini nel mondo: la Global Alliance for Vaccine Immunization
(GAVI) e la Coalition for Epidemic Preparedness Innovation (CEPI) . Quindi possiamo dire che è lui il kingmaker della partita che riguarda i vaccini, e la
loro distribuzione nei paesi del sud del mondo.
Approfondiamo, ancora, un poco la vicenda dei vaccini anticovid. Le
grandi multinazionali come Pfizer, per esempio, sono coinvolte. Una
delle battaglie è quello sul vaccino come Bene comune. Non sarà facile
agli Stati imporre questo status. Qual è il tuo pensiero?
Certo la partita dei vaccini poggia su moltissimi progetti di ricerca – non se ne
sono mai visti tanti in un solo periodo temporale – ma su poche realtà
industriali. Non dobbiamo dimenticare che prima di Covid19 l’85% della
produzione di vaccini dipendeva da 4-5 aziende al masssimo. I governi
occidentali hanno finanziato la ricerca per il vaccino con imponenti contributi
pubblici (16 miliardi di euro la CE, 11 miliardi di dollari gli USA) ma senza
porre alcuna condizione all’industria farmaceutica quanto a prezzi, strategie
di accesso, trasparenza degli studi clinici. E mentre i leader politici
continuano a parlare di vaccino bene comune, le aziende brevettano le
innovazioni di know how e prodotti scoperti anche grazie a un finanziamento
pubblico senza precedenti.
L’emergenza sanitaria prodotta dal nuovo coronavirus richiede – come mai
prima – condizioni di accesso rapido a tutti gli strumenti medicali, inclusi i
prodotti farmaceutici come diagnostici vaccini e farmaci, per la prevenzione
del contagio e la cura delle persone malate. La perdurante scarsità di prodotti
medicali che colpisce soprattutto – ma non solo – i paesi a basso e medio
reddito mette in grave pericolo la vita del personale sanitario nel mondo,
determina il decesso di un numero significativo di lavoratori essenziali,
prolunga la pandemia. Per questo in questi giorni siamo impegnati in una
campagna di raccolta firme che chiede al governo italiano di sostenere la
richiesta di India e Sudafrica all’Organizzazione Mondiale del Commercio di
sospendere tutti i diritti di proprietà intellettuale in materia di prodotti
farmaceutici e medicali, durante la pandemia di Covid19. Sarà una battaglia
durissima, le aziende private e i governi occidentali si oppongono e non vogliono sentire storie, ma smuovere le acque in questo ambito potrebbe
aprire il varco al nuovo normale che dovremo costruire una volta che il
contagio sarà finito.
Torniamo ancora al filantropocapitalismo. Qual è il suo rapporto con la
democrazia?
Il filantrocapitalismo per natura e per cultura non si occupa di democrazia,
casomai usa il potere dei soldi per dirottarla e neutralizzarla. Ce lo dicono
senza equivoci le storie che ho raccontato nel libro. Lo avevano capito bene i
politici americani alla fine dell’800, il rapporto di tensione e contrasto tra
democrazia e filantropia. Peccato che le classi politiche del mondo
contemporaneo non abbiano la stessa consapevolezza di sé e della loro
responsabilità nei confronti delle costituzioni democratiche.
Per i sovranisti Gates e Soros sono i grandi nemici. Eppure anche loro, i
sovranisti, hanno le loro fondazioni. È così?
Certo che anche i sovranisti hanno le loro fondazioni e le loro filiere
filantropiche che li sostengono. Nelle loro incarnazioni contemporanee, le
fondazioni rispondono talvolta quasi esclusivamente all’esercizio del potere.
Abbiamo per esempio sentito parlare dalla inchieste giornalistiche dei miliardi
di euro che sono arrivati ai sovranisti europei da una congiuntura di donazioni
di fondazioni di estrazione rigidamente conservatrice americana, in alleanza
con finanziamenti di miliardari russi vicini a Putin, entrambi interessati ad
erodere lo stato di diritto nel nostro continente. Fondazioni che hanno trovato
sponde anche in circoli molto conservatori della Chiesa cattolica, e che tanto
per stare nelle nostre vicinanze hanno permesso a Steve Bannon di
esercitare la sua azione di influenza strategica da una abbazia del centro
Italia. Cose dell’altro mondo!
Arriviamo al termine del nostro colloquio. È possibile una vera
filantropia?
Credo che la vera filantropia, ovvero in senso etimologico l’unico vero amore
per l’umanità, è quello che passa attraverso il cammino della uguaglianza, la
libertà e la democrazia. E’ quello che riconosce a tutti e tutte la medesima
dignità.