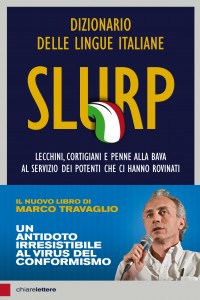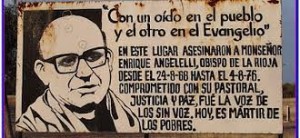Domani ricorrono i cento anni dell’entrata in guerra dell’Italia al fianco dell’Intesa contro gli Imperi centrali. Una scelta che ha segnato per sempre i destini del nostro Paese. Ne parliamo con tre studiosi, due giornalisti (Valerio Gigante e Luca Kocci) e uno storico (Sergio Tanzarella), autori di un bel volume, critico, dal titolo: La grande menzogna. Tutto quello che non vi hanno mai raccontato sulla I guerra mondiale, Ed. Dissensi, Viareggio 2015. (www.dissensi.it)
IL 24 maggio, nel nostro Paese, si fa “memoria” dei cento anni dell’entrata in guerra dell’Italia nel primo grande conflitto mondiale. Tutti i protagonisti sono morti: vittime e carnefici. Ma non è morta la retorica “nazionalista” che mistifica, ancora oggi, la verità. L’ufficialità afferma che la “grande guerra è stato un passaggio fondamentale nel processo di costruzione del nostro Paese, perché è nell’affratellamento delle trincee il primo momento vero in cui si sono “fatti gli italiani” (così l’allora sottosegretario Paolo Peluffo)”. Una tesi vuota e stantia. Al quale voi, nel vostro libro, replicate che questa è la “grande menzogna”. Perché?
VALERIO GIGANTE: Si tratta di contrapporre ad un’ideologia e ad una retorica funzionale a trasmettere l’idea di una storia nazionale senza cesure e contraddizioni, vissuta nell’ottica dell’unità di intenti e della ricerca di una fantomatica unità, o “bene comune” (che il nazionalismo e l’idea di patria spesso suggeriscono), interclassista e irredentista, un approccio critico, che dia consapevolezza a chi non ha vissuto quegli eventi, ma ne è figlio sia per storia familiare che collettiva, che quella guerra ha drammaticamente segnato l’immaginario, la cultura, la politica e la storia del nostro Paese. E che ha inciso la carne stessa delle centinaia di migliaia di vittime, mutilati, feriti, prigionieri (terribile fu la sorte dei prigionieri italiani, che non ebbero dal nostro governo alcun sostegno materiale, perché considerati vili o disertori). La guerra ha colpito chi l’ha combattuta allo stesso modo delle famiglie a cui queste persone sono state sottratte per essere restituite cadaveri, o non essere restituite affatto; o restituite a volte con devastazioni fisiche e psicologiche inimmaginabili. Perché nella I guerra mondiale tutti gli strumenti di distruzione disponibili (gas, mitragliatori, aerei, artiglieria, lanciafiamme, proiettili dum-dum, sommergibili) furono utilizzati su larga scala e senza limiti.
Veniamo alla guerra. Ancora oggi non sappiamo, se non in modo approssimativo, i numeri dei morti, dei feriti, dei civili deceduti (direttamente e indirettamente a causa della guerra), dei prigionieri abbandonati dall’Italia, dei soldati impazziti al fronte. E’ possibile dare qualche cifra?
LUCA KOCCI: In effetti i numeri non si conoscono con precisione, e già questo dà il segno della brutalità e della violenza della guerra. Secondo gli studi più attendibili, durante i 5 anni di guerra, su un totale di 74 milioni di soldati mobilitati dai Paesi belligeranti, vi furono complessivamente 10 milioni di morti (e dispersi), 21 milioni di feriti – fra cui 8 milioni di mutilati ed invalidi, quindi feriti permanenti – e 8 milioni di prigionieri su tutti i fronti. Per quanto riguarda l’Italia – e anche qui i numeri sono incerti, molto probabilmente sottostimati rispetto alla realtà – si contano oltre 650mila morti, di cui 400mila al fronte, 100mila in prigionia e i restanti a causa di malattie contratte durante la guerra. Inoltre in 500mila tornarono dal fronte mutilati, invalidi o gravemente feriti e oltre 40mila con gravissime patologie psichiche dopo anni di trincea.
L’entrata in guerra fu anche un “grande affare” per i gruppi industriali italiani che ha alimentato la grande truffa delle spese di guerra. Episodio, questo, totalmente occultato. . Un ignobile arricchimento fatto sulla pelle delle migliaia di italiani mandati a morire. Come si è sviluppata questa truffa? Chi sono stati i responsabili rimasti impuniti?
SERGIO TANZARELLA: Si trattò allora della prova generale della corruzione sistemica che avrebbe caratterizzato il nostro Stato. La Commissione parlamentare d’inchiesta sulle spese di guerra fortemente voluta da Giolitti raccolse, seppure a fatica, una documentazione imponente. Non ci fu un settore delle commesse di guerra che non fosse stato coinvolto dalla corruzione. Fatture pagate per materiali mai consegnati o solo in parte consegnati, fatture pagate due volte, forniture di materiali di pessima qualità e, finita la guerra, riacquisto a bassissimo costo di quanto non era stato nemmeno consegnato. La guerra costò in alcuni settori anche il 400% in più del dovuto, si può ben comprendere con che danno irreparabile per la casse dello Stato. Un debito enorme che l’Italia si sarebbe trascinata per decenni fin dentro la vita repubblicana. La cattiva qualità delle forniture provocò disagi gravissimi dagli armamenti fino alle stoffe delle divise che avide d’acqua ghiacciarono negli inverni di trincea o alle scarpe che duravano in media da 4 giorni a 2 mesi. La guerra si trasformò in una colossale truffa per lo Stato. Anche l’acquisto di quadrupedi negli Stati Uniti divenne occasione do corruzione, gli ufficiali addetti comprarono a caro prezzo migliaia di cavalli e di muli d età veneranda, pronti a morire ancora nel viaggio di consegna. La commissione fu di fatto neutralizzata da Mussolini, intanto arrivato al potere, e i risultati dei suoi lavori sconosciuti e inapplicati. L’industria italiana che tanto aveva sostenuto gli interventisti trasse profitti illeciti ed enormi. Fra le industri più note l’Ansaldo che fatturò due volte e si fece pagare due volte una intera fornitura di cannoni o l’Ilva che aveva investito centinaia di milioni per finanziare la stampa nazionale e locale perché creasse nell’opinione pubblica un clima di complessivo consenso alla guerra.
La guerra è stata “preparata” anche dall’opinione pubblica di allora. Una enorme macchina propagandistica al servizio della politica interventista. Poche sono state le voci critiche. Chi si è distinto in questo è stato è stato il Pontefice Benedetto XV. Un profeta inascoltato…E’ così?
VALERIO GIGANTE: Tra la fine del 1914 e il maggio del 1915, in pochi mesi l’Italia passò dal più convinto neutralismo al più acceso nazionalismo. Trascinando gran parte dell’opinione pubblica su posizioni belligeranti. Un risultato del genere non può che essere attuato attraverso una capillare organizzazione del consenso, una delle prime attuate in maniera così sistematica e capillare in Italia, che coinvolgeva scrittori e testate giornalistiche, riviste letterarie e singoli intellettuali. Una circostanza che dovrebbe far riflettere sull’efficacia della propaganda nelle società di massa. All’interno di questo panorama culturale, intellettuale e anche religioso di sostanziale esaltazione, o almeno di acritica accettazione della guerra, emerge la figura di Benedetto XV…
SERGIO TANZARELLA: il quale ebbe il coraggio di esprimere da subito una condanna totale e ferma nei confronti della guerra di cui intuì le straordinarie capacità mortifere. Le righe da lui dedicate alla guerra nella sua prima enciclica del 1° novembre 1915 Ad beatissimi sono di una chiarezza esemplare. Scontentò tutti con questa posizione e ancor più con le proposte di pace o almeno di armistizio che più volte concretamente avanzò. Nessuno le prese in considerazione e per questa sua posizione fu condannato alla cancellazione nella storia del ’900 tanto che possiamo definirlo il papa sconosciuto. Ma non si limitò soltanto alla condanna e alla possibilità di tregua, armistizio e pace, promosse forme di assistenza ai prigionieri di guerra e di collegamento e informazione tra prigionieri e famiglie. Un’opera silenziosa e preziosa soprattutto quando l’Italia decise di abbandonare i propri militari prigionieri considerandoli disertori.
Nel vostro libro analizzate anche la figura molto controversa di Padre Agostino Gemelli. Un frate totalmente asservito alla propaganda guerrafondaia. Qual era il suo ruolo?
SERGIO TANZARELLA: Gemelli era capitano medico assegnato al Comando Supremo. In quel ruolo fu uno dei più ascoltati consulenti di Cadorna. Come psicologo si propose di trovare i modi per abbassare ogni forma di resistenza tra i soldati rispetto alla morte che li attendeva negli inutili assalti. Alla stessa morte Gemelli attribuiva una valenza religiosa in grado di convincere i fanti che si trattava della condivisione con la missione salvifica del Cristo. Gli articoli di Gemelli di quegli anni e il suo libro Il nostro soldato sono un’abominevole raccolta di pensieri raccapriccianti dove la fede viene posta a servizio di una causa di morte. Gemelli scriveva che la conversione del soldato si realizzava sul letto dell’ospedale prima di morire, ma era cominciata al fronte e ad essa aveva dato un contributo decisivo una singolare forza di catechesi, la catechesi del cannone. Pertanto la guerra era compresa come provvidenziale occasione di rinascita cristiana. Gemelli fu molto abile a preparare un intruglio di edificazione-rassegnazione di fronte alla catastrofe della guerra offrendo ad essa una mistica consolatrice come quando scrive: «Per noi che rimaniamo, per le spose, per le madri, per i figli, per le sorelle, per gli amici, per i compagni d’armi, per quanti siamo in lutto in queste giornate di prova la morte dei nostri giovani è ragione di conforto. Essi hanno accettato di morire, perché hanno sentito la bellezza cristiana del sacrificio per la patria. Essi hanno fatto di più: hanno fatto risuonare nella morte questa dolce voce della speranza cristiana che consola, che rende forte, che sprona al sacrificio, che ci fa degni insomma dell’ora della prova che oggi viviamo»
Altra figura negativa è stata quella del generale Cadorna (insieme al Comando supremo). In cosa si è “distinto”?
SERGIO TANZARELLA: Dal punto di vista strategico per la totale incompetenza a comprendere le caratteristiche della nuova guerra dove gli assalti ripetuti alle trincee nemiche erano destinati al totale fallimento, le nuove armi permettevano di difendere le trincee dalle ondate di fanti che egli mandava incurante a morire. Una scelta folle che mostrò progressivamente il totale disprezzo che aveva per la vita umana. Ma l’incapacità strategica apparve sin da subito quando, dichiarata la guerra da parte italiana, Cadorna temporeggiò tanto da lasciare agli austriaci tutto il tempo di rinforzare le fortificazione fino a renderle inespugnabili. A questo si accompagnò il ben più grave sistema repressivo per costringere con ogni mezzo i soldati ad andare a morire. Qualsiasi dubbio sulla guerra e ogni forma di protesta fu repressa nel sangue con processi farsa, con sentenze che ebbero immediata applicazione, con tribunali speciali fino alle esecuzioni sul posto (lasciando ai comandanti totale arbitrio di vita e di morte nei confronti dei sottoposti). Altro sistema largamente diffuso furono le decimazioni tra i soldati fortemente volute da Cadorna per instaurare un regime di terrore nella truppa. Cadorna era un cattolico devoto e assunse questo ruolo di spietato carnefice come personale missione a servizio della guerra. L’obbedienza cieca divenne elemento della una mistica di guerra nella quale il campo di battaglia e di morte divenne il luogo del pericolo e dell’onore.
Altro inganno fu la propaganda costruita sulla Vittoria. Perché?
LUCA KOCCI: Appena conclusa la guerra, prese il via una sorta di “frenesia commemorativa” fatta di monumenti ai caduti, grandi sacrari militari, fino alla trasformazione del Vittoriano in monumento al Milite Ignoto. In un primo momento la necessità dell’elaborazione del lutto, anche collettiva, da parte dei famigliari e degli amici delle vittime ha avuto un ruolo importante, e lapidi e monumenti ai caduti hanno svolto anche questa funzione. Ma subito dopo, e in particolare dopo la presa del potere da parte del fascismo, è stata attuata una vera e propria “politica della memoria” per costruire una sorta di religione della patria fondata sul “sacrificio eroico” dei soldati. Infatti i nuovi monumenti ai caduti spesso abbandonano le connotazioni troppo veriste per assumere quelle dei guerrieri nudi della classicità, rafforzando così i tratti eroici e trasformando il soldato-contadino in fante-guerriero, attorniato da fasci littori, scudi e daghe. A partire dal 1928, poi, il regime vieta la costruzione di monumenti di iniziativa locale e attribuisce al governo centrale la progettazione e la costruzione di grandi monumenti e sacrari nazionali. Il nuovo sacrario militare di Redipuglia – che sostituisce il precedente Cimitero degli invitti che a Mussolini non piaceva proprio perché poco eroico – è l’emblema di questo uso politico della morte e della memoria: 22 giganteschi gradoni di marmo bianco, che contengono le spoglie di oltre 100mila soldati, su ciascuno dei quali è scolpita ossessivamente la parola «Presente», come nel rito dell’appello durante i funerali o le commemorazioni dei “martiri fascisti”, a cui quindi vengono equiparati i caduti della I guerra mondiale.
Ultima domanda: Quel conflitto è stato un orrore, tutta la tecnologia di allora asservita alla macchina infernale della guerra, eppure viene “celebrato”. A cento anni di distanza lo spirito critico fatica ad emergere. Come costruire una nuova memoria storica?
VALERIO GIGANTE: Demistificare la narrazione apologetica e celebrativa della I guerra mondiale significa porre le basi per creare una più solida coscienza critica non solo del perché fu orrore quella guerra, ma di come lo sono state anche altre guerre. È per questa ragione che oggi l’ideologia dominante celebra ancora il falso “mito” della I guerra mondiale. Per rendere le masse più disponibili ad accettare come l’orizzonte della guerra esista ancora. Che esso faccia in qualche modo parte del nostro dna. Che non è bella, ma a volte è necessaria.
Va invece suscitato – ed il nostro libro si pone appunto questo obiettivo – un orrore lucido e razionale nei confronti di quella guerra come di tutte le altre, un orrore generatore di pensiero e non unicamente emotivo – nei confronti della “grande menzogna” che continua anche oggi.
Certo, la memoria è corta. E la storia non ha quasi mai insegnato nulla a chi l’ha studiata distrattamente, accontentandosi di attingere al senso comune ed alle fonti di “sistema”. Ma l’esercizio critico è una delle (poche) armi che ancora abbiamo a disposizione se non per trasformare la realtà almeno per comprenderla, che è poi la pre-condizione per tentare di cambiarla.