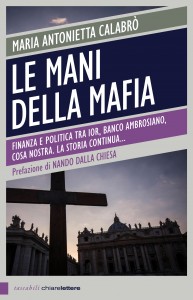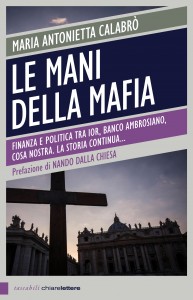 Un libro importante, uscito oggi nelle librerie per i tipi di “Chiare Lettere, che racconta la storia di trent’anni di silenzi, mancate rogatorie, ricatti e scandali, da Roberto Calvi fino a Vatileaks, in un triangolo perverso tra banche, Vaticano e mafia. Ma la storia non è finita, ora i giochi si fanno più duri. Prima di trasformare lo Ior in un’istituzione benefica da banca d’affari (sporchi) qual era, i soldi che vi sono custoditi devono uscire ed essere ripuliti. La rivoluzione di Bergoglio è solo all’inizio e incontrerà molti ostacoli. L’autrice è Maria Antonietta Calabrò, giornalista del “Corriere della Sera”, si occupa da anni di Vaticano, politica ed economia. Nel settembre del 2012 è stata coautrice de I SEGRETI DEL VATICANO sul caso del corvo e su vatileaks, un instant book pubblicato dal “Corriere della Sera” in occasione dell’inizio del processo contro il maggiordomo Paolo Gabriele.
Un libro importante, uscito oggi nelle librerie per i tipi di “Chiare Lettere, che racconta la storia di trent’anni di silenzi, mancate rogatorie, ricatti e scandali, da Roberto Calvi fino a Vatileaks, in un triangolo perverso tra banche, Vaticano e mafia. Ma la storia non è finita, ora i giochi si fanno più duri. Prima di trasformare lo Ior in un’istituzione benefica da banca d’affari (sporchi) qual era, i soldi che vi sono custoditi devono uscire ed essere ripuliti. La rivoluzione di Bergoglio è solo all’inizio e incontrerà molti ostacoli. L’autrice è Maria Antonietta Calabrò, giornalista del “Corriere della Sera”, si occupa da anni di Vaticano, politica ed economia. Nel settembre del 2012 è stata coautrice de I SEGRETI DEL VATICANO sul caso del corvo e su vatileaks, un instant book pubblicato dal “Corriere della Sera” in occasione dell’inizio del processo contro il maggiordomo Paolo Gabriele.
Maria Antonietta Calabrò, Le Mani della Mafia, Milano 2014, pagg. 416 € 14,00
Per gentile concessione dell’Editore pubblichiamo la premessa alla nuova edizione:
Quell’estate del 1991
Nel giugno del 1991, terminata la prima stesura di questo libro, ero giunta alla conclusione che il presidente del Banco ambrosiano, Roberto Calvi, era stato ucciso nell’ambito della lotta tra i clan mafiosi «perdenti» e «vincenti» di Cosa nostra siciliana. Non solo. L’omicidio di Calvi rappresentava a mio avviso la cartina al tornasole dei rapporti tra finanza, politica e il sottostante mondo criminale.
Una tesi molto «ardita», a quei tempi, alla quale ero arri- vata ricomponendo le tessere di un puzzle assai complicato disseminate fra atti, documenti ufficiali, giudiziari e non, e «fonti aperte».
Perciò, quando una bella mattina del successivo mese di luglio il Gr2 delle otto annunciò quella che oggi si chiame- rebbe una sensazionale breaking news, non rimasi sorpresa.
Di che cosa si trattava?
Uno dei pentiti più attendibili di Cosa nostra, Francesco Marino Mannoia, aveva rivelato ai magistrati i retroscena dell’uccisione del banchiere, finito stritolato nella lotta all’ul- timo sangue tra cosche che a cavallo tra gli anni Settanta e Ottanta aveva insanguinato Palermo e New York.
Davanti ai pubblici ministeri del capoluogo siciliano Guido Lo Forte e Giuseppe Pignatone, il collaboratore di giustizia, protetto dall’Fbi, sostenne che Licio Gelli aveva investito il denaro dei Corleonesi di Totò Riina nella cosiddetta banca vaticana, cioè lo Ior, l’Istituto per le opere di religione.
Testualmente Mannoia raccontò di «aver sentito dire da Stefano Bontade che Pippo Calò, Francesco Madonia e altri avevano somme di denaro a Roma attraverso Licio Gelli, che ne curava gli investimenti. Si diceva che questo denaro era investito nella banca vaticana».
La testimonianza calzava a pennello con la mia ricostruzione. Non mi restava che integrare con le dichiarazioni di Mannoia le bozze de Le mani della mafia.
Sempre nell’estate del 1991 un altro avvenimento avrebbe incrociato la storia descritta nel libro: il vertice dei Sette grandi, il G7, che si tenne a Londra dal 15 al 17 luglio.
In agenda, assieme ai tanti problemi sorti con il crollo dei regimi dell’Est europeo, c’erano le questioni legate al traffico di stupefacenti e alla criminalità organizzata. Al termine dei lavori, il G7 espresse un forte appoggio al programma anti- droga dell’Organizzazione delle Nazioni Unite e si impegnò ad aumentare gli sforzi per ridurre la «domanda» (cioè il con- sumo) di stupefacenti. Ma soprattutto esortò i paesi membri a partecipare con più energia al piano antiriciclaggio del denaro sporco avviato da una speciale task force internazionale.
L’invito, naturalmente, valeva per tutti. Ma l’Italia – rappresentata a Londra dal premier Giulio Andreotti – aveva qualcosa in più da farsi perdonare. Sul nostro paese pesava da mesi l’accusa di non fare abbastanza per contrastare la criminalità o, meglio, per impedire che il fiume di denaro sporco contagiasse, attraverso il nostro sistema bancario, tutta l’Europa.
Un anno prima, nell’aprile del 1990, al summit Cee di Dublino, il cancelliere tedesco Helmut Kohl aveva dovuto insistere perché, in vista del semestre di presidenza italiana (luglio-dicembre 1990), nei documenti ufficiali europei si parlasse esplicitamente di «mafia», e non di «criminalità organizzata» come avevano preteso Andreotti e il ministro degli Esteri Gianni De Michelis. E perché il problema fosse messo in agenda nel successivo G7 di giugno. Ne scrissi il 9 aprile 1991 sul «Corriere della Sera». Il caso era esploso. A illustrare l’articolo, la foto di una maglietta, in vendita per le strade di Roma, con la scritta «Mafia made in Italy». Il 25 maggio, sul palco del Teatro Parioli, Maurizio Costanzo bruciò una maglietta con quella stessa scritta.
Il timore al G7 di Londra era questo: se non fossero state prese misure di sicurezza adeguate, quando si fossero «abbassate» le frontiere dell’Unione, con l’entrata in funzione della cosiddetta «area Schengen», le cosche avrebbero potuto attuare in tutta Europa quello che avevano già fatto in Italia.
La testa della Piovra, infatti, continuava a essere a Palermo, anche se i suoi enormi tentacoli si erano estesi a Bangkok come a Londra, a Monaco di Baviera e a Marsiglia, fino a Montréal, Caracas, San Paolo del Brasile e in almeno venticinque città chiave degli Stati Uniti. Prossime terre di conquista, a quei tempi: i paesi dell’Est e lo sterminato territorio dell’ex Unione Sovietica.
Le famigerate cinque «famiglie» di New York non aveva- no mai costituito il cuore del potere mafioso. Era la mafia siciliana a essere diventata dal dopoguerra la più potente organizzazione criminale su scala mondiale imponendo, con una spregiudicata azione di creazione della domanda, l’uso dell’eroina, e successivamente di cocaina, in tutti i continenti. Lo stesso cartello colombiano di Medellín – come hanno dimostrato molte operazioni di polizia – non era che un partner dell’invisibile (ai più) multinazionale del crimine che ha ancora la sua «sede sociale» nel capoluogo siciliano. Una verità che ancora oggi le autorità di molti paesi, comprese quelle italiane, esitano ad accettare per intero.
Sempre nel 1991 l’Unioncamere pubblicò un rapporto nel quale veniva stimato in circa 100.000 miliardi di lire il fatturato criminale del nostro paese. Una cifra di poco inferiore al deficit pubblico italiano di quegli anni, e talmente grande da far impallidire il giro d’affari di grandi gruppi industriali nazionali. Buona parte di questo vorticoso business era frutto del traffico degli stupefacenti. I soldi sporchi servivano per acquistare società, industrie, venivano reinvestiti nell’edilizia, nella grande distribuzione. La mafia era già diventata finanza, condizionando sempre più la politica.
Il giallo di Roberto Calvi: 1900 miliardi spariti nel nulla
Roberto Calvi, presidente del Banco ambrosiano di Milano, fu trovato impiccato il 18 giugno 1982 sotto un ponte di Londra dal nome suggestivo, il ponte dei Frati neri.
Da allora sono passati più di trent’anni. Sulla fosca storia dei misteriosi Frati neri sono state svolte indagini in mezzo mondo: dall’Inghilterra all’Irlanda, al Lussemburgo, alle Bahamas, agli Stati Uniti, oltre che naturalmente in Italia.
Ora, grazie al lavoro della magistratura romana, conclusosi nel maggio del 2010, sappiamo con certezza che il banchiere è stato ucciso. Ma non per mano di chi. Né a quali scopi servisse il fiume di denaro scomparso.
Le spiegazioni parziali sono state molte: i sogni di potenza di Calvi, l’ostilità dei politici, l’acquisto da parte dell’Am- brosiano del maggiore quotidiano italiano, il «Corriere della Sera», la corruzione all’interno e all’esterno della banca, le complicità dello Ior, a quei tempi presieduto dall’arcivescovo americano Paul Marcinkus, che possedeva almeno il 10 per cento delle azioni della banca e che comunque è stato, per lunghi anni, il principale azionista del Banco.
Il sospetto che il Banco ambrosiano potesse essere uno dei canali privilegiati del riciclaggio delle narcolire c’era sempre stato. Ma prove mai. Al puzzle mancava ancora l’importante tassello costituito da Pippo Calò, il «cassiere di Cosa nostra».
Le rivelazioni del superpentito Tommaso Buscetta, pure così prudenti quando rischiavano di mettere in questione il cosiddetto «terzo livello», furono esplicite. Don Masino dichiara senza esitazioni al giudice Giovanni Falcone: «Calò è coinvolto nel crac Ambrosiano».
Passano i mesi, e da un’altra istruttoria giudiziaria, quella sulla banda della Magliana, salta fuori un’ulteriore sorpresa. Uno dei soci più stretti di Calò è proprio Flavio Carboni, l’accompagnatore di Roberto Calvi nell’ultima tragica tra- sferta di Londra.
Nel 1991, come abbiamo visto, dal suo rifugio negli Stati Uniti, il boss dell’eroina, Francesco Marino Mannoia, accusò proprio Calò di essere il mandante dell’assassinio di Calvi.
A questo punto era parso evidente a chi scrive che per svelare l’enigma del Banco ambrosiano una possibile strada fosse quella di riprendere il bandolo della matassa proprio lì dove era stato tagliato.
Le resistenze delle banche
La prima edizione di questo libro – che ha contribuito alla riapertura delle indagini sulla morte di Calvi – raccontava le scoperte fatte inseguendo quel bandolo.
Fu presentato a Roma il 6 novembre 1991. Tra i relatori, l’allora ministro dell’Interno Enzo Scotti (che insieme al suo collega guardasigilli, Claudio Martelli, di lì a poco avrebbe deciso la creazione della Direzione investigativa antimafia e della Procura nazionale antimafia) e Luciano Violante, vicepresidente vicario del gruppo Pds a Monte- citorio, che l’anno successivo sarebbe divenuto presidente della Commissione parlamentare d’inchiesta sulla mafia. Sul quotidiano «la Repubblica»1 Giuseppe D’Avanzo scrisse un lungo resoconto di quella presentazione che si tenne nella vecchia sede della sala stampa estera, in via della Mercede. D’Avanzo, tra l’altro, riportava l’allarme del responsabile del Viminale circa il rischio di infiltra- zione di capitali mafiosi («L’economia rischia di essere presa in ostaggio») e annunciava per quel giorno stesso l’incontro di Scotti con l’allora governatore della Banca d’Italia Carlo Azeglio Ciampi. L’atto di accusa di Scotti era indirizzato alle banche che non applicavano il nuovo decreto contro la ricchezza mafiosa. Quest’ultimo era stato approvato da pochi mesi, il 25 luglio 1991, cioè pochi giorni dopo il vertice del G7 a Londra e le rivelazioni di Francesco Marino Mannoia.
«Incontriamo fortissime resistenze, in nome dei sacri principi, che ci impediscono efficaci indagini antimafia in campo economico e finanziario. Questi ostacoli e resistenze vengono proprio da quegli uomini che poi si scandalizzano che in Sicilia si ammazzi qualcuno dimenticando che, dietro quei morti, c’è questa tolleranza» disse Scotti.
Continuava D’Avanzo:
Il Viminale intende chiamare banche e banchieri alle loro responsabilità. Intanto, ieri, ha già dato un assaggio dell’atto d’accusa che oggi snocciolerà ai massimi responsabili del sistema creditizio nazionale.
«Nel luglio scorso – ha esordito il ministro – per frenare il fenomeno del riciclaggio, è stato approvato un decreto legge che obbliga le banche a segnalare le operazioni anomale. è un provvedimento che non ha trovato nessuna significativa applicazione. è giunto, quindi, il momento che si parli chiaro e tondo: questo è un segnale che mi lascia, più che perplesso, inquieto. Ma insomma, io non posso credere che i dirigenti delle banche a qualsiasi livello, e soprattutto quelli a contatto con il pubblico, non siano in grado di valutare l’anomalia di alcune operazioni che vengono compiute. Possibile che a Paler- mo diminuisce l’attività produttiva, si contrae l’occupazione mentre i depositi aumentano del 25 per cento e nessuno si accorga di nulla?» Il ministro dell’Interno sembra sapere che la strada che intende imboccare non sarà comoda. E prova ad anticipare gli argomenti che gli saranno opposti. «So quali sono le obiezioni quando propongo queste osservazioni» ha continuato Scotti. «Sostengono alcuni esperti: le banche non collaborano e tacciono per evitare che i capitali, oggi custoditi in Italia, prendano il volo verso l’estero. Anzi, mi dicono, questa emigrazione di danaro è già cominciata. La fuga di capitali starebbe crescendo progressivamente e questo risultato sarebbe da attribuire all’introduzione di alcune misure restrittive in materia di controllo. E, in particolare, per l’identificazione dei libretti al portatore e della necessità di iscrizione del codice fiscale su ciascuna operazione. Bene, io non credo all’equazio- ne esportazioni di capitali uguale introduzione di misure più restrittive. Mi sembra un’interpretazione semplicistica.» «So benissimo – ha aggiunto il ministro – che ci sono responsabilità anche del sistema bancario europeo. Ma non è più possibile subire ogni giorno passivamente l’offensiva degli altri governi per la situazione italiana e non chiamarli alle loro responsabilità. Tuttavia, per chiedere una collaborazione piena del sistema bancario europeo, bisogna mostrare la piena collaborazione del nostro sistema bancario. I nostri partner cominciano a essere preoccupati. L’Inghilterra lo è da tempo, i francesi cominciano a esserlo. Finalmente cominciano a capire che cos’è la mafia, che cosa sta diventando a livello internazionale. Che cosa può diventare in un futuro prossimo con l’apertura verso i paesi dell’Est bisognosi di danaro, di valuta forte, quindi non attenti o indifferenti a un controllo del riciclaggio.»
Per il Viminale, la Piovra la si controlla aggredendone tutti i tentacoli senza voler tagliare soltanto i più protervi e clamorosi. «Dobbiamo ragionare in modo diverso rispetto al passato. C’è stato, c’è un raccordo tra la criminalità organizzata e finanza, politica, aree dei servizi segreti. Non pensiamo che la lotta alla mafia la si fa aggredendo un solo bersaglio. Certo, il proble- ma appare più evidente quando c’è l’assassinio, quando c’è il morto in strada. Si crea – è comprensibilissimo – una terribile emozione e senza dubbio questa è una realtà con cui dobbiamo fare i conti. Ma c’è una realtà più sottile alla quale dobbiamo guardare con la stessa forza di ripulsa, una realtà che tocca aree considerate pulite, tranquille, intoccabili. Anche qui ci sono bersagli da colpire.» E uno dei bersagli, per il Viminale, deve essere la ricchezza mafiosa nella consapevolezza che, se anche il money-flow criminale è soltanto una modesta frazione delle transazioni finanziarie, è capace di «prendere in ostaggio» l’economia di un paese. «Insomma – ha concluso Scotti – il nostro problema è questo: come conservare la riservatezza insita nelle operazioni finanziarie in un’economia di mercato aperta? Io non voglio distruggere il sistema bancario, ma al tempo stesso dobbiamo impedire che la potenza economica della mafia si riversi nei circuiti puliti e, utilizzando i malfattori che vi lavorano, comprometta aree più vaste, più larghe. Il sistema bancario mi sembra sordo a questo appello. Altrove qualcosa si sta muovendo. Non è a caso che la Confindustria e le grandi associazioni del mondo imprenditoriale cominciano a prendere coscienza della necessità di intervenire. Hanno posto una disponibilità a spostare più in là i limiti del segreto bancario perché si rendono ormai conto che l’inquinamento dei mercati finanziari, l’inquinamento delle attività produttive da parte della mafia, con la liquidità oggi a disposizione delle “famiglie”, è un pericolo reale. Se ne rendono conto anche le banche e i banchieri? Si sappia che il governatore della Banca d’Italia proprio all’Antimafia ha detto quanto l’economia e le banche potrebbero essere facili prede della mafia. Ebbene, questo non accadrà domani, è già accaduto.»
Incredibilmente, o forse non tanto, visto che il caso coin- volgeva la testata che era stata in mano alla loggia P2, il «Corriere della Sera» dedicò poche righe all’evento.
Questo libro dà fastidio
Scrivevo nella Nota dell’Autore della prima edizione con- siderazioni tuttora valide:
Questo libro non è, nell’intenzione dell’Autore, né potrebbe esserlo oggettivamente, un verdetto, nei confronti di nessuno. La ricerca si basa su una notevole mole di atti parlamentari, di documenti degli investigatori, di atti giudiziari, e su una loro, per quanto possibile, scrupolosa correlazione e organiz- zazione logica.
Un ampio apparato di note rende conto delle fonti di documentazione specifiche.
Evidentemente, tutte le notizie sono da considerarsi raccolte allo stato degli atti.
Tuttavia, trattandosi di una materia in cui – per citare le parole usate dal procuratore generale della Cassazione, Vittorio Sgroj, in occasione dell’apertura dell’anno giudiziario 1990 – «si appalesa drammatico» persino «il contrasto tra ciò che il giudice intuisce e ciò che riesce correttamente a dimostrare», l’Autore vuole sottolineare che non è dell’esito giudiziario delle varie vicende che si è voluto informare il lettore, né – in particolare – della colpevolezza dell’uno o dell’altro personaggio in sede penale.
Piuttosto si è voluta offrire una chiave di lettura unitaria ed esplicativa per uno tra i gialli politico-finanziari più oscuri degli ultimi vent’anni.
Proprio quando sono in gioco vicende complesse i processi giudiziari infatti possono fornire solo alcune tessere di un mosaico che è molto più ampio, come l’istituzione di nume- rose commissioni parlamentari d’inchiesta sta a dimostrare. E troppo spesso – in questi casi – l’opinione pubblica non ha gli strumenti per capire. Manca la memoria «storica», mancano le raccolte «sistematiche» delle informazioni, manca soprattutto il loro collegamento. è tale lacuna che questo lavoro intende riempire, con una ricostruzione minuziosa e attenta, e con la diligenza del cronista. Posso offrire al lettore il mio sforzo onesto e puntiglioso e la raccolta di tanti elementi.
Nonostante la tesi de Le mani della mafia fosse, alla fine del 1991, assolutamente nuova, questo libro non è mai stato oggetto di querele.
A me del resto non interessava dimostrare la responsabilità penale dei vari protagonisti. Nel 1992, quando l’istruttoria della Procura di Roma sull’omicidio del banchiere prese quota, uno dei protagonisti criminali della storia mi telefonò in ufficio, al «Corriere della Sera».
Era l’ora di pranzo. Mi disse che la tesi del libro non stava in piedi, e che soprattutto lo aveva infastidito veder mettere uno dopo l’altro fatti e circostanze. In particolare si doleva della cronologia. Mi chiese anche se ero sposata e se avevo figli. Dopo alcune ore, su consiglio del suo avvocato – così mi disse –, sempre sul telefono dell’ufficio richiamò per dirmi: «Sia chiaro, signora, che io non l’ho minacciata». Non so quale delle due telefonate poteva considerarsi peggiore.
Fui consigliata da un autorevole esponente dell’Antimafia a prendere più di una precauzione.
Incredibilmente, persino diciassette anni dopo, nel 2009, questo libro dava ancora molto «fastidio». L’emissario di un esponente politico tutt’oggi di primissimo piano mi volle incontrare per chiedere se fosse vero che io ne ero l’autrice. Erano in gioco, in quel momento, nomine importanti. Non che mi riguardassero in modo diretto, ma per qualcuno era meglio conoscere di prima mano la situazione.
Fortunatamente, la memoria lunga non appartiene solo a chi è stato un diretto protagonista di una storia che a dire opaca si pecca per difetto.
C’è un altro tipo di memoria lunga.
Nel settembre del 2000 ero negli Stati Uniti come international visitor su invito del Dipartimento di Stato. Tappe: Washington, New York, Miami. Incontri alla Corte suprema, al quartier generale dell’Fbi, al ministero della Giustizia. E anche al distretto sud di Manhattan, quello dove Rudolph Giuliani portò a processo la Pizza Connection.
Ma fu a Miami che potei incontrare uno dei due agenti della dogana americana che nel 1984 aveva scritto un rapporto in cui si documentava una singola, enorme, operazione di riciclaggio del denaro dei narcos a opera del sistema estero del Banco ambrosiano di Calvi. Milioni e milioni di dollari. Il caso era stato portato all’attenzione dello stesso presidente degli Stati Uniti. Si trattava dell’operazione Greenback descritta in questo libro. Erano passati nove anni, ma qualcuno non aveva dimenticato.
Da Schengen a Moneyval: le leggi cambiano, gli illeciti continuano
L’anno dopo, nel 2001, l’attentato alle Torri gemelle creò una seconda emergenza internazionale che ha avuto un’influenza decisiva sul versante delle indagini sulla fine del presidente del Banco ambrosiano.
Potrà suonare strano, ma è proprio così. L’attentato di al Qaeda ha infatti costretto il sistema bancario internazionale a cambiare.
Quello che era avvenuto dieci anni prima in Europa, con l’entrata in funzione di Schengen, si è ripetuto a livello planetario a partire dalla metà degli anni Duemila.
Anche il Vaticano e la sua cosiddetta banca, lo Ior, si sono dovuti adeguare. E sono dovuti entrare, a cominciare dalla fine del 2010, nel sistema internazionale di controllo dell’antiriciclaggio (Aml) e di contrasto al finanziamento del terrorismo (Cft). Hanno cioè dovuto adottare le procedure stabilite dal Gafi (il Gruppo di azione finanziaria contro il riciclaggio del denaro) e, per i paesi più piccoli (come il Vaticano), dal Comitato regionale del Consiglio d’Europa, cioè dal Comitato Moneyval.
Ci si chiederà che cosa tutto ciò abbia a che fare con una storia, quella di Roberto Calvi e della sua banca, conclusasi tragicamente trent’anni prima.
Si ricorderà che il Vaticano è stato costretto a sottoporsi ai controlli di Moneyval dopo che, il 20 settembre 2010, vennero sequestrati dalla Procura di Roma (su segnalazione della Banca d’Italia) 23 milioni di euro depositati su un conto del Credito artigiano intestato allo Ior, per operazioni ban- carie effettuate in violazione della normativa antiriciclaggio italiana. Le operazioni incriminate erano costituite da due distinti trasferimenti ordinati dallo Ior per 20 e 3 milioni di euro. Insieme al sequestro dei soldi erano stati indagati, per riciclaggio, l’allora presidente Ettore Gotti Tedeschi e l’allora direttore generale Paolo Cipriani. L’accusa: violazione della legge 173 del 1991 (quella invocata dal ministro Scotti nella presentazione di questo libro nel 1991) e del decreto legislativo 231 del 2007, che ha introdotto in Italia i criteri imposti dal Gafi dopo l’attentato alle Torri gemelle.
A seguito di questi eventi, papa Benedetto XVI, con il motu proprio del 30 dicembre 2010, ha dato applicazione alla Convenzione monetaria firmata con l’Unione europea il 17 dicembre 2009, e la prima legge antiriciclaggio vati- cana – sia pure deficitaria in molti punti – è entrata poi in vigore il 1° aprile 2011.
Ora, può sembrare incredibile, ma gli scandali più recenti che hanno coinvolto lo Ior affondano le loro radici nella storia del vecchio Banco ambrosiano.
L’istruttoria che ha portato al sequestro dei 23 milioni di euro prese avvio nel maggio del 2010.
La Corte d’appello di Roma il 7 maggio di quell’anno, pur confermando l’assoluzione per insufficienza di prove di tutti gli imputati (Flavio Carboni, Pippo Calò, Ernesto Diotallevi e Silvano Vittor) dall’accusa per l’assassinio di Roberto Calvi, aveva stabilito due punti fermi. Innanzitutto che appunto di omicidio si trattava e non di suicidio. E in secondo luogo che era stato accertato, al di là di ogni ragionevole dubbio, che lo Ior aveva riciclato ingenti capitali della mafia.
C’era poi un altro fatto, rimasto finora inedito. Ebbene, alcuni dei conti di transito presso le banche italiane utiliz- zati dallo Ior nel 2010 erano gli stessi dei tempi del Banco ambrosiano.
Nel corso del processo per l’omicidio del «banchiere dagli occhi di ghiaccio» (iniziato in Assise a Roma nel 2005) era infatti emersa la realtà dei cosiddetti «conti R», almeno sei, che erano «sfuggiti» al processo milanese per bancarotta del vecchio Ambrosiano.
Si trattava di conti dello Ior in lire, su cui figuravano transazioni con clienti esclusivamente italiani. A differenza di quanto avvenuto con i creditori esteri dell’Ambrosia- no (nei cui confronti lo Ior pagò a titolo di risarcimento transattivo, nel 1984, 250 milioni di dollari), i debiti dello Ior in lire vennero pagati per circa 100 milioni di dollari, subito dopo il fallimento della banca di Calvi, in modo che entrassero nelle poste attive di avviamento del Nuovo banco ambrosiano. Questi conti, anche detti «misti» (perché erano dello Ior, ma gli amministratori dello Ior vi operavano «in gestione confusa», cioè senza rivelare i nomi dei clienti per cui compivano le operazioni), sono rimasti attivi, sono cioè «sopravvissuti», per quasi trent’anni senza che di essi si parlasse più.
L’unica traccia ufficiale della loro esistenza risaliva al 1978, alla famosa Relazione ispettiva della Banca d’I- talia sul vecchio Banco ambrosiano firmata da Giulio Padalino.
Ma nella seconda metà del primo decennio degli anni Duemila le griglie più strette delle normative internazionali li hanno infine messi nel mirino degli investigatori.
Le quotidiane operazioni da milioni di euro tra lo Ior e alcuni istituti di credito italiani (fra cui Unicredit, Intesa Sanpaolo, Banca del Fucino) avevano destato i sospetti dell’Unità di informazione finanziaria della Banca d’Italia nel 2009. E a seguito di quella segnalazione fu accertato dai magistrati della Procura romana che lo Ior utilizzava in modo cumulativo un conto aperto presso la filiale 204 della Banca di Roma in via della Conciliazione, versandovi assegni da parte di propri clienti senza dare alcuna comunicazione in merito, violando così le norme antiriciclaggio.
Solo attraverso tale conto sarebbero transitati circa 180 milioni di euro tra il 2006 e il 2008. Le operazioni si interruppero con l’integrazione della Banca di Roma nel gruppo Unicredit.
I pubblici ministeri sospettano che le transazioni attraverso conti «schermati» intestati allo Ior celino in realtà operazioni, per conto di società o singoli individui con residenza fiscale in Italia, volte all’occultamento di vari reati, dall’evasione fiscale alla truffa. La guardia di finanza ha inoltre accertato casi di beneficiari fittizi fra quelli comunicati agli inqui- renti. Oltre al trasferimento dei 23 milioni, nel frattempo sono venute alla luce anche altre due operazioni sospette, ovvero un prelievo in contanti da 600.000 euro, effettuato nell’ottobre del 2009 dallo Ior per finalità non precisate su un conto Intesa Sanpaolo, e assegni per 300.000 euro incas- sati nel novembre dello stesso anno su un conto Unicredit. Dall’analisi degli inquirenti è risultato fittizio il nome del negoziante fornito dallo Ior, mentre la cifra proveniva in realtà da una banca di San Marino.
Ebbene, alcuni dei conti di transito presso le banche italia- ne utilizzati dallo Ior nel 2010 erano gli stessi utilizzati dallo Ior ai tempi del Banco di Calvi. è stato il segreto nascosto con maggiore efficienza di tutta la storia dell’Ambrosiano. Ne parleremo nell’ultimo dei quattro nuovi capitoli che accompagnano la riedizione di questo libro (I conti misti dello Ior: da Calvi a Scarano).
Appena ieri
Il 2012 e il 2013 hanno registrato altri eventi che incredi- bilmente hanno riportato all’attualità la vecchia storia finita a Londra sotto il ponte dei Frati neri.
Il pentito Francesco Di Carlo detto «Frankie lo stran- golatore», un mafioso trasferitosi in Gran Bretagna negli anni Settanta e che nel 1991 era stato indicato proprio da Francesco Marino Mannoia come principale indiziato dell’assassinio di Calvi, è tornato a parlare del delitto nel maggio del 2012. Nega ancora oggi di aver avuto alcun ruolo diretto: «Non sono stato io quello che ha impiccato Calvi. Un giorno scriverò tutta la vera storia. Chi lo ha fatto ha enorme potere. Sono un misto di politici, presidenti di banca, militari, vertici della sicurezza e così via. Questo è un caso che continuano ad aprire e richiudere ma che non sarà mai risolto. Più in alto sali, meno prove trovi».
Sempre nella primavera del 2012, mentre in Vaticano impazza il caso del Corvo, deflagra lo scandalo Vatileaks e il presidente dello Ior Gotti Tedeschi deve lasciare l’incarico. Il pubblico ministero romano Luca Tescaroli, intervistato da Gianluigi Nuzzi (autore del libro Sua Santità. Le carte segrete di Benedetto XVI, Chiarelettere 2012), ha accusato il Vaticano di non aver risposto a una rogatoria del 2002 che riguardava l’istruttoria sulla morte di Calvi. Le accuse di insabbiamento – lo dimostrerà il guardasigilli Paola Severino nell’ottobre del 2012 – dovevano essere rivolte semmai alla stessa Procura romana: perché quella richiesta di assistenza giudiziaria non solo non era mai arrivata Oltretevere, ma non era neppure giunta in via Arenula, sede del ministero della Giustizia italiano. Dopo le proteste ufficiali del Vati- cano contro le sue accuse, Tescaroli dovette presentare una nuova rogatoria, cui il Vaticano rispose nell’agosto del 2012.
A luglio, negli stessi giorni in cui la Santa sede «passava» con una buona pagella il primo test di Moneyval, le intercettazioni telefoniche, disposte dalla Procura romana sull’utenza del capo contabile dell’Apsa (ente che amministra il patrimonio mobiliare e immobiliare della Santa sede), monsignor Nunzio Scarano, dimostravano che il riciclaggio continuava a essere praticato dallo Ior. Nel Torrione di Nic- colò V dovevano arrivare valigie di decine di chili zeppe di banconote da 500 euro. Scarano verrà arrestato alla fine di giugno del 2013 e il caso travolgerà il vertice operativo della banca vaticana: il 1° luglio devono rassegnare le dimissioni Paolo Cipriani e il suo vice Massimo Tulli.
Due giorni dopo si viene a sapere però che Tulli e Cipriani sono anche indagati per riciclaggio in un’altra istruttoria che coinvolge cinque sacerdoti romani e il boss della Maglia- na Ernesto Diotallevi. Uno di questi preti, don Salvatore Palumbo, parroco di una popolosa parrocchia della Capitale nel quartiere bene della Collina Fleming, nel 2012 era stato addirittura arrestato insieme a Diotallevi. E dalle intercet- tazioni telefoniche disposte durante le indagini era emerso per la prima volta il nome di monsignor Scarano.
Nel dicembre del 2013 la guardia di finanza ha sequestrato 25 milioni di euro di proprietà di Diotallevi, compresa la sua abitazione, un prestigioso attico che affaccia sulla monumentale Fontana di Trevi.
Il 19 dicembre 2013, dopo una latitanza pluridecennale, viene estradato in Italia per scontare una condanna definitiva a otto anni di carcere quello che le forze dell’ordine ritengo- no il vero finanziere della mafia (mentre gli altri sarebbero ben più modesti «cassieri»): Vito Roberto Palazzolo, «The Godson», sotto indagine in Italia e negli Stati Uniti, dai tempi in cui Rudy Giuliani, procuratore del distretto sud di Manhattan, portò alla sbarra la Pizza Connection.
Sui silenzi di trent’anni di storia del Banco ambrosiano e dei suoi legami con lo Ior si sono costruite solidissime carriere, altre sono state distrutte.
Ma questi trent’anni di storia criminale sono stati uno dei fattori più importanti all’origine del «blocco» del sistema italiano. Il nostro paese è rimasto impigliato nelle maglie del potere della cosiddetta Seconda repubblica, che in parte ha funzionato da sovrastruttura (direbbe Karl Marx) di una sottostante entità economico-mafiosa che, seppur costretta ad abbandonare lo stragismo, non ha mai perso incisività.
C’è infatti una stabilità anche nel potere criminale. (…) La storia continua, trent’anni dopo…
1 Giuseppe D’Avanzo, Scotti punta l’indice sulle banche, «la Repubblica», 7 novembre 1991.
Condividi su Facebook
 Nella notte tra il 26 e il 27 marzo del 1996, sette dei nove monaci che formavano la comunità del monastero di Tibhirine, fondato nel 1938 vicino alla città di Médéa 90 km a sud di Algeri, furono rapiti da un gruppo di terroristi. Il 21 maggio dello stesso anno, dopo inutili trattative, il « Gruppo Islamico Armato » ha annunciato la loro uccisione. Il 30 maggio furono ritrovate le loro teste, i corpi non furono mai ritrovati.
Nella notte tra il 26 e il 27 marzo del 1996, sette dei nove monaci che formavano la comunità del monastero di Tibhirine, fondato nel 1938 vicino alla città di Médéa 90 km a sud di Algeri, furono rapiti da un gruppo di terroristi. Il 21 maggio dello stesso anno, dopo inutili trattative, il « Gruppo Islamico Armato » ha annunciato la loro uccisione. Il 30 maggio furono ritrovate le loro teste, i corpi non furono mai ritrovati.