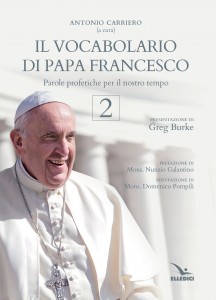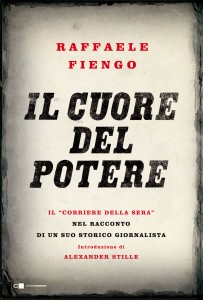Foto (Roberto Monaldo/LaPresse)
Sono giorni di grande fibrillazione per il PD. Dopo la sconfitta del 4 dicembre, la nascita del governo di “responsabilità” presieduto da Gentiloni , il Partito democratico si avvia verso una stagione congressuale assai complicata. Oggi dal palco della convention “Italia prima di tutto” Roberto Speranza, uno dei leader della minoranza bersaniana, ha lanciato la sua candidatura, alternativa a quella di Renzi, alla segreteria del PD. Domani, sempre a Roma, si svolgerà l’Assemblea Nazionale del PD. In quell’occasione Matteo Renzi farà la sua proposta per lo svolgimento del Congresso. Di tutto questo parliamo, in questa intervista, con il senatore Giorgio Tonini, Presidente della Commissione Bilancio del Senato ed esponente della maggioranza renziana.
Senatore Tonini, partiamo ancora dal Referendum costituzionale del 4 dicembre scorso. Qual è stato l’errore fatale, oltre alla personalizzazione, che ha commesso Matteo Renzi?
A me pare che il risultato del Referendum abbia messo in evidenza due limiti della nostra strategia politica. Per un verso, l’isolamento: eravamo partiti, dopo la rielezione di Napolitano, con uno schieramento politico-parlamentare che superava il 70 per cento, al punto che, durante il governo Letta, ci si era posti il problema di come tenere comunque il Referendum confermativo, anche nell’ipotesi, data quasi per certa, di superare il quorum dei due terzi, previsto dall’articolo 138. Quell’ipotesi è tuttavia tramontata molto rapidamente. Già nel periodo lettiano, abbiamo assistito all’immediato formarsi di un fronte contro la riforma, costituito dalla sinistra a sinistra del Pd e dal Movimento Cinquestelle, con l’appoggio dell’area intellettuale guidata da Rodotà e Zagrebelsky e da quella sociale che si andava organizzando attorno alla Cgil e in particolare alla Fiom di Landini. Ma nel giro di pochi mesi, abbiamo dovuto assistere anche al rapido riposizionamento della Lega e poi dello stesso Berlusconi, uscito dalla maggioranza di governo dopo il voto del 27 novembre 2013 sulla sua decadenza da senatore, per effetto della condanna definitiva per frode fiscale. Con un’abile manovra parlamentare, Letta era riuscito ad evitare la crisi del suo governo, grazie alla scissione di Alfano e alla nascita di Ncd, ma non quella della larga maggioranza per le riforme, che di fatto, alla fine del 2013, erano tornate nell’affollato archivio dei progetti impossibili. Fu Matteo Renzi, che nel frattempo aveva conquistato la leadership del Pd con le primarie dell’8 dicembre, che provò e in effetti riuscì a ricomporre la frattura con Berlusconi, grazie al Patto del Nazareno, stipulato il 18 gennaio 2014. Ma anche quel patto venne disdettato da Berlusconi, dopo l’elezione di Sergio Mattarella a presidente della Repubblica, il 3 febbraio 2015. Dico “dopo” e non “a causa” dell’elezione di Mattarella, perché ho sempre pensato che quello sia stato in larga misura un “casus belli”, utilizzato da Berlusconi per sottrarsi a un abbraccio, quello con Renzi, che stava diventando elettoralmente e politicamente soffocante. La morale di questa storia è a mio avviso chiara: in Italia è difficile, per non dire impossibile, fare riforme a larga maggioranza, perché le riforme richiedono tempi lunghi, mentre le larghe intese, nel nostro paese, a causa della debolezza dei partiti, hanno sempre e inevitabilmente vita breve. Francamente non saprei cosa rimproverare a Renzi su questo versante. Anche lui si è dimostrato abile nella tattica parlamentare e infatti la riforma è arrivata in porto con una larga maggioranza assoluta, anche se lontana dai due terzi. Ma poi, al referendum, ci siamo ritrovati soli, come la Francia di Napoleone contro la Santa Alleanza. Abbiamo aggregato attorno a noi più di 13 milioni di voti, gli stessi che aveva raccolto Veltroni nel 2008: tanti, tantissimi, ma del tutto insufficienti per vincere.
Parlava di due limiti della strategia riformista di Renzi e del Pd. Qual è stato il secondo?
L’ennesima riproposizione del “riformismo dall’alto”, del riformismo “senza popolo”. Mi spiego meglio. Il risultato del Referendum, letto in chiave solo politica, ci consegna un’immagine apparentemente semplice, quasi scontata: un Pd rimasto solo coi suoi piccoli alleati di governo, che si ferma ad un perfino lusinghiero 40 per cento, contro tutti gli altri, che alla fine mettono insieme “solo” il 60. Ma se guardiamo la composizione sociale, demografica e geografica del voto, quell’immagine si complica e di molto, perché il Sì prevale nelle aree forti del paese, quelle che guardano al futuro con un certo grado di fiducia e di speranza, mentre il No dilaga in quelle più deboli e sofferenti, tra le quali dominano la paura e la rabbia. Non credo che in questa frattura il contenuto della riforma abbia pesato, se non in minima parte: difficile credere che la differenza tra l’affermazione del Sì a Milano e il trionfo del No in Sicilia e Sardegna sia stata prodotta da come era scritto il nuovo articolo 70, dalla composizione del nuovo Senato, o dal “combinato disposto” con l’Italicum. La spiegazione di tale divario non può che essere molto più radicale e per noi ancor più dolorosa: se la parte più debole e dolente del paese ha votato No, è perché ha voluto bocciare il governo e la sua politica di riforme, istituzionali ma anche economiche e sociali. Ciò significa che il nostro riformismo non è riuscito a conquistare la fiducia del popolo e in particolare della parte di esso che, dal nostro punto di vista, più avrebbe dovuto beneficiare delle riforme: i giovani precari, i disoccupati, i meno garantiti in generale. E invece, abbiamo dovuto assistere al paradosso dei mandarini del Senato o del Cnel, “salvati” dai disoccupati del Sulcis. Come i Borboni difesi dai contadini di Sapri, che massacrarono i trecento, giovani e forti, reclutati da Carlo Pisacane. L’alleanza tra le plebi disperate e i conservatori, contro i riformisti, è un classico della storia d’Italia. Renzi ha sempre detto, giustamente, che la comunicazione è l’essenza della politica, che una buona politica non comunicata bene, semplicemente non è politica. E che contrapporre riforme e consenso è un non senso. Eravamo dunque consapevoli e avvertiti del rischio che correvamo, del riproporsi della frattura manzoniana tra buon senso e senso comune. Ma non siamo riusciti ad evitarlo. Da qui dobbiamo ripartire: dalla ricostruzione di un’alleanza riformista tra merito e bisogni, tra la maggioranza dei milanesi che ha condiviso la riforma, insieme ai nostri “cervelli in fuga” all’estero, e quella dei siciliani che, insieme alla generazione perduta dei 25-40enni condannati a una vita da precari, ha usato il No per esprimere la sua protesta e la sua rabbia.
Giuseppe De Rita, tempo fa, parlava della visione morotea e andreottiana della politica. quella morotea era la politica come visione, quella andreottiana era la politica della somiglianza agli elettori. Su quale delle due si è mosso Renzi?
In effetti De Rita, in un’intervista molto interessante rilasciata qualche mese fa alla rivista “Pandora”, ha ricordato il dibattito che si aprì negli anni ’70, all’interno della Democrazia Cristiana, tra la visione “riformista” di Moro, secondo la quale la politica deve orientare i processi sociali, accompagnarli verso un fine, dare loro un orientamento, una direzione, e quella “realista” di Andreotti, per il quale compito della politica non è quello di orientare la società, ma solo di rassomigliarle, perché solo rassomigliandole si prendono i voti. Renzi, per carattere e per modo di fare politica, non è un “moroteo”, semmai un “fanfaniano”, non privo di tratti “andreottiani”, a cominciare dalla netta preferenza per il governo rispetto al partito. Ma se vogliamo utilizzare lo schema di De Rita, la battaglia di Renzi e del Pd per le riforme si è certamente ispirata alla ambiziosa e impegnativa visione di Moro ed è andata ad impattare contro l’eterno muro di gomma della cultura dell’adattamento, per decenni impersonata in Italia da Giulio Andreotti.
La valanga di No che ha sommerso la Riforma Boschi, come si sa, è stata, per molteplici fattori, un No a Matteo Renzi. La sensazione, che si percepisce nel Paese, è che Renzi e il “renzismo” siano da archiviare. E’ sbagliata, secondo lei, questa affermazione?
Matteo Renzi è un grande combattente. La sconfitta lo ha certamente indebolito, ma la notizia della sua morte politica, avrebbe detto Mark Twain, “è fortemente esagerata”. Quanto al “renzismo”, non saprei dire esattamente cosa sia, se non la (ennesima) declinazione originale, proposta da un leader riformista, del riformismo stesso. L’Italia non ha mai conosciuto, in 70 anni di storia repubblicana, un ciclo riformista degno di questo nome. Ha conosciuto solo brevi stagioni riformiste: gli anni di De Gasperi e Vanoni, il primo centro-sinistra, alcuni aspetti della stagione della solidarietà nazionale o del governo Craxi, il primo governo Prodi e certamente il governo Renzi. Tutti tentativi bruscamente e talvolta brutalmente interrotti. Di solito dal comparire sulla scena della Santa Alleanza tra massimalisti e conservatori. Le conseguenze di questa triste anomalia italiana sono sotto gli occhi di tutti: siamo il paese col più alto debito pubblico, la crescita più bassa e la diseguaglianza più accentuata. Ma i nemici del riformismo non hanno una proposta per il paese, hanno solo il peso della loro forza, di solito messa al servizio della pura conservazione dell’esistente. Quando nei prossimi mesi questo vuoto di proposta emergerà in tutta la sua chiarezza, per le ragioni dei riformisti si aprirà una nuova finestra di opportunità. E Renzi ha ottime possibilità di essere ancora lui il leader riformista del quale il paese ha bisogno. A condizione, naturalmente, che sappia imparare e maturare dalla sconfitta.
Antonio Polito, sul “Corriere della Sera”, ha scritto che il Referendum ha segnato la fine della II Repubblica (quella basata sul maggioritario, sul leaderismo, sulla ipercomunicazione televisiva) e qualcuno palesa il ritorno alla I repubblica, ovviamente senza i giganti che l’hanno fondata. Come se ne esce Senatore?
La tesi di Polito è suggestiva, ma non del tutto convincente. Peraltro contraddice la previsione, da lui e da altri formulata durante la campagna referendaria, che poco o nulla sarebbe cambiato con la vittoria del No. La democrazia è in affanno in tutto il mondo, ma resta, oggi come ai tempi di Churchill, “il peggiore dei regimi, esclusi tutti gli altri”. E la democrazia, per funzionare, ha bisogno di alcune, semplici condizioni: stabilità di governo, pochi e grandi partiti, competizione per la leadership, contropoteri indipendenti, società pluralista. Si può dire, certamente, che la cosiddetta II Repubblica abbia fallito l’obiettivo di darci una “democrazia compiuta”. Ma non si può dire che non ci resta che rassegnarci a quella che, sempre Moro, chiamava la “democrazia difficile”. Certo, il fallimento della II Repubblica e quello del tentativo di uscirne in avanti, con la creazione del Pd, partito a vocazione maggioritaria, e una riforma che rimodellasse il sistema politico in questa direzione, ripropongono una stagione di governi deboli, di frammentazione della rappresentanza e di complessiva instabilità e precarietà. Ma questa prospettiva è l’esatto contrario di quel ciclo riformista che l’Italia non ha mai conosciuto e del quale avrebbe un disperato bisogno. Proprio per questo il No è una non risposta, che lascia intatti i problemi storici del paese. E la necessità di affrontarli.
Riuscirà il PD a tenere fermo il principio maggioritario? E se dovesse prevalere in Parlamento una legge proporzionale le ragioni profonde e organizzative del PD cambierebbero?
Per completare la transizione dalla democrazia proporzionale a quella maggioritaria era indispensabile la riforma del bicameralismo. Con due Camere entrambe dotate del potere di fiducia e un sistema politico multipolare, tenere fermo il principio maggioritario è molto difficile. Bisognerà cercare almeno di limitare il danno. Una via potrebbe essere il ripristino del Mattarellum: una via che la Corte costituzionale non ha voluto seguire, quando ha dichiarato parzialmente incostituzionale la legge Calderoli, preferendo correggerla in senso proporzionale. Vedremo se la sentenza sull’Italicum andrà nella stessa direzione. Certo è che se il “combinato disposto” tra bocciatura della riforma costituzionale e controriforma elettorale ci riconsegnerà nelle mani della politica proporzionalistica, sarà difficile fermare un movimento dal basso di segno presidenzialista. Non sottovaluterei il movimento in atto di protesta contro “l’ennesimo governo non deciso dagli elettori”. È vero che si tratta di una sgrammaticatura costituzionale, tanto più grottesca in quanto alimentata da forze che si sono opposte ad una riforma che aveva come principale obiettivo proprio la legittimazione popolare dei governi, attraverso la elezione, con un sistema maggioritario, di una sola Camera politica. Ma quando milioni di italiani si renderanno conto del paradosso e dell’inganno, la spinta popolare contro il parlamento e verso il presidenzialismo potrebbe farsi inarrestabile. La destra politica potrebbe in tal modo ritrovare una sua bandiera e un’occasione di riscossa. Questa è la vera “mucca nel corridoio” che Bersani farebbe bene a vedere. Altro che deriva autoritaria del “combinato disposto” tra riforma Boschi e Italicum…
Parliamo del governo. Governo di responsabilità per fare fronte alle emergenze (Europa, economia, terremoto. ecc). Non era il caso di cambiare la compagine governativa? La gente avrebbe compreso di più…
Inutile nascondersi dietro un dito: con la sconfitta della riforma, la legislatura è politicamente finita. Come ha giustamente affermato il presidente Mattarella, si tratta di portarla a conclusione in modo ordinato, salvando dalle macerie della riforma abbattuta dal Referendum, almeno una legge elettorale condivisa, possibilmente funzionale a garantire il massimo di stabilità possibile. Per fare questo lavoro c’è bisogno di qualche mese e dunque di un governo nella pienezza delle sue funzioni. Il Pd aveva proposto un governo istituzionale sostenuto da tutti i gruppi parlamentari. Le opposizioni hanno bocciato questa ipotesi dischiarandosi non disponibili. Non è restata dunque altra via possibile, che quella di un governo che garantisse al tempo stesso la discontinuità politica, espressa al massimo livello dal passo indietro di Renzi, e la continuità amministrativa, con la conferma della maggior parte dei ministri, tanto più opportuna nella prospettiva di una durata circoscritta a qualche mese. Il Pd si è fatto carico di questa responsabilità, assai probabilmente impopolare. Chiedere di andare subito al voto e al contempo lamentare la mancata svolta nella compagine governativa, come hanno fatto molte forze di opposizione, è talmente contraddittorio da risultare ridicolo.
Come si concilia la “responsabilità” governativa con l’esigenza della rivincita di Renzi?
Il problema non è la rivincita di Renzi, ma la delegittimazione di questo Parlamento. Non possiamo barricarci nel bunker. Se non vogliamo essere travolti, non dobbiamo avere né mostrare paura del voto. Lo spazio della “responsabilità” sta nell’aver accolto l’invito del Presidente della Repubblica a formare un nuovo governo, nella pienezza delle sue funzioni, per il tempo necessario ad approvare una riforma elettorale coerente con i dettami della Consulta. Se si pensasse di andare oltre, almeno in questo contesto politico, significherebbe capovolgere la responsabilità nel suo contrario.
Intanto all’orizzonte si profila un referendum abrogativo proposto dalla Cgil sul Jobs Act. L’infelice battuta del ministro Poletti non aiuta certo il PD. Quali iniziative pensate di mettere in campo per superare l’ostacolo? Sarà possibile trovare una soluzione ragionevole?
Se dopo la riforma costituzionale dovesse essere abbattuto a furor di popolo anche il Jobs Act, vorrebbe dire che l’Italia non solo è la grande malata d’Europa, ma a differenza della Germania dei primi anni duemila, è un malato che rifiuta di curarsi. Riforma previdenziale, riforma costituzionale e riforma del mercato del lavoro hanno rappresentato in questi anni le credenziali con le quali l’Italia si è ripresentata sulla scena europea e internazionale ed ha conquistato una rinnovata credibilità. Senza quelle riforme e quella credibilità, Mario Draghi non avrebbe potuto varare il programma di politica monetaria espansiva che ha sostenuto quel po’ di crescita e di ripresa occupazionale che abbiamo avuto in questi ultimi anni e la crisi dell’Euro sarebbe diventata ingovernabile. Senza quelle riforme e quella credibilità, l’Italia non avrebbe potuto presentarsi come alfiere di una possibile “terza via”, tra la versione più radicale dell’austerità, propugnata dai falchi della Bundesbank, e la sterilità autolesionistica della protesta populista, inutilmente applaudita ad Atene come a Madrid. La credibilità dell’Italia e della sua terza via è stata già pesantemente indebolita dall’esito del Referendum e dalle conseguenti dimissioni di Renzi. Manca solo la bocciatura popolare del Jobs Act per completare il capolavoro. Questo non significa che il Jobs Act vada considerato immodificabile. Un tagliando per verificare cosa abbia funzionato e cosa invece vada messo a punto, è non solo possibile, ma anche opportuno. Soprattutto, andrebbe attuata la parte, in gran parte finora rimasta sulla carta, che riguarda le politiche attive del lavoro, a cominciare dai centri per l’impiego e dai contratti di ricollocamento. Ma il Referendum proposto dalla Cgil sembra ignorare tutto questo e ispirarsi alla linea massimalista di Bertinotti di estensione generalizzata dell’articolo 18, culminata nel Referendum malamente perduto nel 2003. La Cgil deve decidere se seguire questa strada, contraddittoria con la sua grande storia, o se invece dare seguito alle positive pagine scritte con l’accordo sulle pensioni, recepito dalla legge di Bilancio, e con il rinnovo del contratto dei metalmeccanici, che è parso annunciare una nuova stagione, unitaria sul piano sindacale e innovativa nelle relazioni industriali italiane.
Oggi la minoranza bersaniana ha lanciato la candidatura di Roberto Speranza alla segreteria, e domani, a Roma, si svolgerà l’Assemblea Nazionale deciderà sul prossimo Congresso. Un congresso che Renzi vuole che sia rapido. Non trova che sia un altro clamoroso errore questo di Renzi? Il partito è a pezzi Senatore…
Forse non è a pezzi, ma certamente il Pd, l’unico vero partito italiano, è in affanno. Un Congresso vero è dunque necessario e urgente. Per ridare al partito una linea politica, una leadership legittimata e anche una forma organizzativa pensata e strutturata in modo innovativo. In questo caso, fare bene e fare presto sono due facce della stessa medaglia. Prendere tempo non significherebbe infatti approfondire la riflessione, ma abbandonarsi al gioco suicida delle correnti. E far mancare al paese l’ultimo appiglio a cui aggrapparsi per non finire nella riedizione della I Repubblica. E come è noto quando una pagina grande e tragica si ripete, di solito assume le sembianze della farsa. Stavolta sarebbe anche una farsa con ben poco da ridere.
Condividi su Facebook