 Papa Francesco nel visitare, il 26 giugno scorso nel 50° anniversario della morte, la tomba di Don Lorenzo Milani a Barbiana, paesino della Diocesi di Firenze, ha voluto ricordare la vita esemplare del priore di Barbiana. Il Pontefice ha spiegato il suo gesto come «risposta a quella richiesta più volte fatta da don Lorenzo al suo Vescovo, e cioè che fosse riconosciuto e compreso nella sua fedeltà al Vangelo e nella rettitudine della sua azione pastorale». Quel gesto, ha detto il Papa, «oggi lo fa il Vescovo di Roma. Ciò non cancella le amarezze che hanno accompagnato la vita di don Milani – ha precisato -, ma dice che la Chiesa riconosce in quella
Papa Francesco nel visitare, il 26 giugno scorso nel 50° anniversario della morte, la tomba di Don Lorenzo Milani a Barbiana, paesino della Diocesi di Firenze, ha voluto ricordare la vita esemplare del priore di Barbiana. Il Pontefice ha spiegato il suo gesto come «risposta a quella richiesta più volte fatta da don Lorenzo al suo Vescovo, e cioè che fosse riconosciuto e compreso nella sua fedeltà al Vangelo e nella rettitudine della sua azione pastorale». Quel gesto, ha detto il Papa, «oggi lo fa il Vescovo di Roma. Ciò non cancella le amarezze che hanno accompagnato la vita di don Milani – ha precisato -, ma dice che la Chiesa riconosce in quella
vita un modo esemplare di servire il Vangelo, i poveri e la Chiesa stessa».Tra questo modo esemplare di vivere il Vangelo c’è stata, certamente, la lotta al militarismo. Una battaglia, quella di Don Milani, ancora attuale. Ne parliamo, in questa intervista, con il professor Sergio Tanzarella. Sergio Tanzarella è ordinario di Storia della Chiesa nella Pontificia Facoltà teologica dell’Italia Meridionale a Napoli.
Professor Tanzarella, lei, insieme ad altri storici della Chiesa italiani, ha curato la pubblicazione, uscita per i meridiani della MONDADORI, di tutte le OPERE DI DON MILANI. Inoltre ha PUBBLICATO per le edizioni “Il pozzo di Giacobbe” una edizione a due lettere importantissime di don Lorenzo: la lettera ai cappellani militari e ai giudici, con un apparato di note e una articolata post fazione. Partiamo da qui, prendendo spunto, anche, da un episodio grave di questi giorni. Mi riferisco al tentativo messo in atto dall’ordinario militare e dal cardinale Sarah, di “promuovere” San Giovanni XXIII patrono dell’Esercito italiano. Tentativo riuscito. Questo è un episodio che EVIDENZIA quanto sia dura a morire, in certi ambienti cattolici tradizionalisti, la mentalità di alleanza tra trono e altare, e se si vuole la persistenza di una mentalità militarista. La domanda è: hanno ancora senso i cappellani militari?
La presenza attuale, così come è organizzata con la equiparazione di fatto alla gerarchia degli ufficiali con stellette e stipendi, appare il risultato di una concezione delle relazione Stato-Chiesa ormai inattuale, frutto di un neocostantinismo di inizio XX secolo cui diede ulteriore sviluppo il fascismo. Che dei preti possano fare un servizio di assistenza spirituale a dei soldati potrebbe anche essere accettabile, ma fuori dalla struttura e dalla organizzazione delle forze armate. Ci sono i cappellani ospedalieri e quelli delle carceri ma restano preti, non diventano né dottori né ufficiali della polizia penitenziaria. L’ordinariato militare andrebbe chiuso e le competenze rimesse alle singole diocesi. La presenza dei cappellani militari equiparati agli ufficiali è stata concepita per la I guerra mondiale e per le guerre coloniali. Qualcuno ha le lancette dell’orologio ancora ferme nel ministero della difesa e nella Chiesa. Occorrerebbe che si dicesse che i tempi di Agostino Gemelli e di Reginaldo Giuliani sono finiti, irrimediabilmente finiti. E invece questi cosa fanno? Prendono il povero Giovanni XXIII e lo fanno patrono dell’esercito.
Ritorniamo alle lettere di don Milani. La lettera ai cappellani militari non è solo una lettera a favore dell’obiezione di coscienza, ma anche una critica al militarismo che ha investito la storia d’Italia dal Risorgimento in poi. Qual è la chiave interpretativa che il priore di Barbiana utilizza per smontare IL MILITARISMO e quindi per criticare la storia ufficiale d’Italia?
La tesi sostenuta e dimostrata da Milani è che tutte le guerre italiane dall’Unità in poi sono state del tutto ingiustificabili (ad eccezione della Resistenza). Con questo giudizio crolla uno dei miti della storia nazionale insieme a quello dell’italiano buon soldato e pacifico colonizzatore. Gli italiani in guerra e nelle colonie si macchiarono di delitti e di crimini al pari di altri soldati ed eserciti. Furono tutte guerre imposte agli italiani dal potere politico e da quello industriale attraverso una astuta e ossessiva propaganda e con un sistema di coercizione che non lasciava scampo. Quella di Milani fu una denuncia tanto forte che ancora oggi non se ne fa quasi parola. Un processo di demistificazione pericolosissimo per la retorica patriottarda. Pretendere di celebrare don Milani prescindendo da questi e da altri suoi scritti è il massimo della contraddizione. Ma oggi c’è un ministero della Istruzione che mentre vuole che nelle scuole si studi Milani contemporaneamente celebra la I guerra mondiale e deporta per centinaia di ore gli studenti nelle caserme per i percorsi dell’alternanza Scuola-Lavoro.
Vi sono limiti in questa visione di don Milani? oppure, invece, mantiene una sua validità ?
Si trattò di una analisi storica acutissima che mantiene tutta la sua validità quanto ancora oggi sconosciuta. Tanto più valida se la si confronta con le logiche del ministero dell’Istruzione impegnato oggi nelle celebrazioni della I guerra mondiale ancora presentata come IV guerra di Indipendenza, decisiva per il completamento dell’unità nazionale e momento felice di coesione tra italiani. Ancora non si ha il coraggio di dire la verità, la verità oggettiva su una guerra inutile che gli italiani, soprattutto un popolo di contadini e di pastori analfabeti furono costretti a combattere, e nella quale morirono in 700.000. Una catastrofe nazionale che continua a fare paura e per questo deve essere mistificata e raccontata come atto di eroismo. Milani ebbe il coraggio di dimostrare le menzogne di questa propaganda, menzogne che circolano indisturbate ancora oggi.
Allarghiamo l’orizzonte e guardiamo all’intera opera di don Milani. Egli è stato un giudice severo sull’impegno politico dei cattolici italiani. Quali erano i criteri fondamentali per un buon impegno politico?
Certo né neutralità né moderazione. Per Milani le leggi devono servire a difendere coloro che sono svantaggiati ed esclusi nella società non i garantiti. Ma in parlamento siedono quasi tutti i rappresentanti di quest’ultimo gruppo. Per lui non si possono amare i poveri e non volere leggi migliori. Il collateralismo dei suoi anni presentava una situazione esattamente opposta a questa idea: La Pira e Dossetti erano delle eccezioni emarginate e perseguitate. Per Milani i cattolici dovevano spezzare la giustificazione del privilegio e restituire ai poveri le possibilità di cui erano privati. Non c’era però la sostituzione di una classe sociale con un’altra quanto il superamento della divisione in classi.
Milani si definisce “maestro” dei suoi ragazzi. Ma è un “maestro” che si fa compagno di cammino nel percorso di “coscientizzazione” dei ragazzi di Barbiana. C’è qualcosa che rimane ancora valido dell’esperienza di Milani? Cosa ha dire agli insegnanti di oggiAggiungi un appuntamento per oggi?
L’esempio della scrittura collettiva resta esemplare. Contro il modello della scuola e della società competitiva, della giustificazione della concorrenza, Milani applica un metodo cooperativo cui corrisponde un modello di società della condivisione. È evidente che è difficilissimo per un insegnante rifarsi a Milani anche perché la linea ministeriale, dalle prove Invalsi ai finanziamenti concessi a chi ottiene migliori risultati, è proprio quella della premialità concessa a chi è già privilegiato. Gli insegnati soffocati da circolari, funzioni dai nomi di fantasia più inverosimili, ottusità della dirigenza scolastica, classi di 30-35 studenti, inutili aggiornamenti e riunioni sono di fatto impediti. Tuttavia resta ancora spazio per organizzare una resistenza intellettuale che possa contribuire ad aiutare a formare coscienze nella autonomia e nella libertà. Il conformismo può essere combattuto: mantenendo alto il senso critico di fronte al potere che pretende genuflessioni e inchini e accrescendo il livello culturale di un popolo.
La “categoria” del povero in Milani non è solo una categoria sociologica. E’ sociologica e teologica insieme. E’ così?
Ha fatto bene a usare le virgolette. Per Milani i poveri diventano la ragione della propria vita, coloro che gli sono stati affidati e per la cui liberazione ha orientato tutta la sua pastorale. Chiariamo bene, non una azione benefica, ma un preciso impegno di giustizia sociale. Un impegno che non ha nessun altro fine che restituire ai poveri ciò di cui sono stati derubati: i diritti, la lingua, la vita. Ma essi non sono una categoria ma persone, ognuno con il proprio nome e la propria storia. Di fronte alle generalizzazioni per gruppi sociali, per ideologie, per professioni Milani ribadisce più volte il primato assoluto della persona.
Don Milani ha avuto rapporti con intellettuali del suo tempo. Come era visto dalla cultura italiana dell’epoca?
Domanda complessa. Difficile rispondere in poche battute. I suoi corrispondenti, i suoi recensori o coloro che pubblicamente ne hanno affermato l’importanza parlano da soli e offrono una idea di che genere di intellettuali potesse apprezzare Milani: Luciano Bianciardi, Ignazio Silone, Gaetano Arfè, Pier Paolo Pasolini, Tommaso Fiore, Mario Lodi, Giuseppe Gozzini e poi giornalisti come Giorgio Pecorini, Mario Cartoni, Enzo Forcella. Uomini tra loro certo diversi, ma che ebbero la capacità di cogliere in Milani la grandezza di una testimonianza liberante e senza doppi fini e la capacità di penetrare la grave crisi della società italiana oltre l’illusione dei miti delle mode, del consumismo, del benessere e del boom economico. Per cosiddetti uomini di cultura del presente mi limito a ricordare che un certo Cacciari ebbe recentemente la sfrontatezza di sostenere che Milani poteva essere paragonato al prete plurinquisito Luigi Verzè.
Per molti giovani della nostra generazione (la mia e la sua professore) è stato un punto importante nella formazione. Le chiedo: OGGIAggiungi un appuntamento per oggi cosa può dare don Milani ad un giovane?
Innanzitutto l’impegno per la ricerca della verità e poi il coraggio che ci vuole per questa ricerca. E’ il riconoscimento di una sovranità che non ha bisogno di deleghe ma di responsabilità personale. Infine la consapevolezza che occorre andare sempre controcorrente anche se facendo così occorre mettere in conto di dover pagare un prezzo altissimo per propria carriera.
Ultima domanda: tra i giovani preti è viva la memoria di don Milani?
In giro per l’Italia in questi anni ho trovato numerosi preti anziani o di mezza età che avevano letto tutto quello che potevano su Milani e di Milani. Alcuni confessavano che la sua testimonianza era stata decisiva per la propria vocazione, per la pastorale e per la vita. Il contributo di Milani per una parte del clero italiano è sorprendente, forse quasi non immaginabile, ma enorme.
La conoscenza si abbassa notevolmente per i giovani preti. Dei suoi scritti resta qualche vaghissima citazione, a volte anche imprecisa o sbagliata. Gli studi di Storia della Chiesa e di Teologia Pastorale non lo prendono nemmeno in considerazione. Ci sono ovviamente rare eccezioni tra cui i miei studenti della Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale che, ormai da molti anni, Milani cominciano a leggerlo dal primo giorno del corso di Storia della Chiesa contemporanea. E diversi di questi la lettura di Milani non la lasciano più.

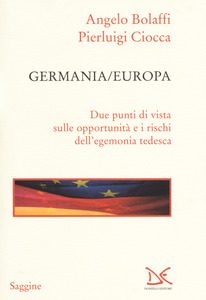 Tutta l’opinione pubblica europea si sta interrogando sulle conseguenze del voto tedesco di domenica scorsa. Un voto che ha visto il crollo di consensi elettorali dei due partiti storici: CDU e SPD. Angela Merkel,Cancelliera riconfermata dal voto, ora inizierà una lunga trattativa per dare un governo alla Germania. Cerchiamo di capire, in questa intervista, con il filosofo della politica e grande studioso della cultura germanica, come si evolverà la situazione politica tedesca.
Tutta l’opinione pubblica europea si sta interrogando sulle conseguenze del voto tedesco di domenica scorsa. Un voto che ha visto il crollo di consensi elettorali dei due partiti storici: CDU e SPD. Angela Merkel,Cancelliera riconfermata dal voto, ora inizierà una lunga trattativa per dare un governo alla Germania. Cerchiamo di capire, in questa intervista, con il filosofo della politica e grande studioso della cultura germanica, come si evolverà la situazione politica tedesca.
