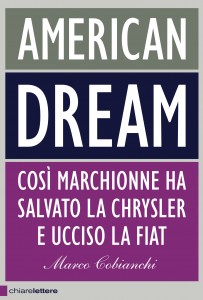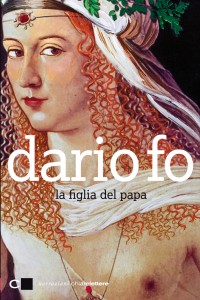“Perché avvelenarci il fegato con queste storie vecchie di oltre vent’anni, con tutti i problemi che abbiamo oggi? La risposta è semplice e agghiacciante: sono storie attuali, come tutti i ricatti che assicurano vita e carriera eterna tanto ai ricattatori quanto ai ricattati. Da ventidue anni uomini delle istituzioni, della politica, delle forze dell’ordine, dei servizi e degli apparati di sicurezza custodiscono gelosamente, anzi omertosamente, i segreti di trattative immonde, condotte con i boss mafiosi le cui mani grondavano del sangue appena versato da Giovanni Falcone, da Francesca Morvillo, da Paolo Borsellino, dagli uomini delle loro scorte, dai tanti cittadini innocenti falciati o deturpati dalle stragi di Palermo, Firenze, Milano e Roma. E su quei segreti e su quei silenzi hanno costruito carriere inossidabili, che durano tutt’oggi…
“Perché avvelenarci il fegato con queste storie vecchie di oltre vent’anni, con tutti i problemi che abbiamo oggi? La risposta è semplice e agghiacciante: sono storie attuali, come tutti i ricatti che assicurano vita e carriera eterna tanto ai ricattatori quanto ai ricattati. Da ventidue anni uomini delle istituzioni, della politica, delle forze dell’ordine, dei servizi e degli apparati di sicurezza custodiscono gelosamente, anzi omertosamente, i segreti di trattative immonde, condotte con i boss mafiosi le cui mani grondavano del sangue appena versato da Giovanni Falcone, da Francesca Morvillo, da Paolo Borsellino, dagli uomini delle loro scorte, dai tanti cittadini innocenti falciati o deturpati dalle stragi di Palermo, Firenze, Milano e Roma. E su quei segreti e su quei silenzi hanno costruito carriere inossidabili, che durano tutt’oggi…
Chi volesse capire perché in Italia tutto sembra cambiare – gattopardescamente – per non cambiare nulla provi a seguire con pazienza il filo di questo racconto. Se, alla fine, avrà saputo e capito qualcosa in più, questo spettacolo e questo libro avranno centrato il loro obiettivo: quello di mettere in fila i fatti per strappare qualche adepto al Ptt, il partito trasversale della trattativa.” Così scrive Marco Travaglio, Vice Direttore del Fatto Quotidiano, in questo che oggi presentiamo. Di seguito, per gentile concessione dell’Editore, pubblichiamo il Prologo del volume.
Prologo
Ci sono diversi modi per raccontare la trattativa Stato- mafia.
Il primo è quello dei politici, dei grandi giornali e delle tv: la presunta trattativa, la supposta trattativa, la pretesa trattativa, la cosiddetta trattativa. Forse, magari, chissà.
Il secondo è quello che raccontano le sentenze e i protagonisti.
Le sentenze sono quelle – definitive – dei processi celebrati a Caltanissetta sulle stragi di Palermo del 1992 (Capaci e via D’Amelio) e a Firenze sulle bombe di Firenze in via dei Georgofili, di Milano in via Palestro e di Roma alle basiliche di San Giovanni in Laterano e di San Giorgio in Velabro. Scrivono i giudici della Corte d’assise di Firenze (verdetto confermato fino in Cassazione):
I testimoni hanno espressamente dichiarato che la controparte mafiosa della trattativa erano i «corleonesi»; anzi, direttamente Riina. Brusca ha confermato che della trattativa gli parlò personalmente Riina. […] I testi hanno dichiarato che si mossero dopo la strage di Capaci; il col. Mori entrò in scena dopo la strage di via D’Amelio […]. In ciò che ha raccontato Brusca vi è quanto basta per essere certi del parallelismo tra la vicenda raccontata da lui e quella raccontata dal gen. Mori e dal cap. De Donno […]. L’iniziativa del Ros aveva tutte le caratteristiche per apparire come una «trattativa»; l’effetto che ebbe sui capi mafiosi fu quello di convincerli, definitivamente, che la strage era idonea a portare vantaggi all’organizzazione. Sotto questi profili non possono esservi dubbi di sorta, non solo perché di «trattativa», «dialogo», ha espressamente parlato il capitano De Donno (il generale Mori, più attento alle parole, ha quasi sempre evitato questi due termini), ma soprattutto perché non merita nessuna qualificazione diversa la proposta, non importa con quali intenzioni formulata (prendere tempo; costringere il Cian- cimino a scoprirsi; o altro) di contattare i vertici di Cosa nostra per capire cosa volessero (in cambio della cessazione delle stragi). Qui la logica si impone con tanta evidenza che non ha bisogno di essere spiegata.
Conclusione dei giudici di Firenze:
Non si comprende come sia potuto accadere che lo Stato, «in ginocchio» nel 1992 – secondo le parole del gen. Mori – si sia potuto presentare a Cosa nostra per chiederne la resa; non si comprende come Ciancimino, controparte in una trattativa fino al 18-10-1992, si sia trasformato dopo pochi giorni in confidente dei carabinieri; non si comprende come il gen. Mori e il cap. De Donno siano rimasti sorpresi per una richiesta di «show down», giunta, a quanto pare logico ritenere, addirittura in ritardo.
La stessa Corte d’assise di Firenze, nella sentenza di condanna all’ergastolo per il boss Francesco Tagliavia (già confermata in Appello) del 5 ottobre 2011, aggiunge:
Una trattativa indubbiamente ci fu e venne, quantomeno ini zialmente, impostata su un do ut des. L’iniziativa fu assunta da rappresentanti delle istituzioni e non dagli uomini della mafia.
Borsellino si oppose, giudicandola «la negazione stes- sa della battaglia condotta da sempre con Falcone» e prevedendo che la trattativa non avrebbe frenato, ma moltiplicato le stragi. Infatti fu ucciso. Per questo.
Ma di «trattativa», senza alcun aggettivo dubitativo, parlano anche i protagonisti, mafiosi e istituzionali. A cominciare da Giovanni Brusca, che per primo la rivelò nel 1996-97, costringendo i trafelati ufficiali del Ros, il generale Mario Mori (all’epoca vicecomandante) e il suo braccio destro, l’allora capitano Giuseppe De Donno, a confermarla. Ecco Mori il 27 gennaio 1998 davanti ai giudici di Firenze (dove, diversamente da quanto affer- mano i giudici, parla anche lui più volte di «trattativa»):
Incontro per la prima volta Vito Ciancimino a via di Villa Massimo dietro piazza di Spagna a Roma, nel pomeriggio del 5 agosto 1992. L’Italia era quasi in ginocchio perché erano morti due fra i migliori magistrati nella lotta alla criminalità mafiosa, non riuscivamo a fare nulla dal punto di vista investigativo, e cominciai a parlare con lui: «Signor Ciancimino, cos’è questa storia, questo muro contro muro? Da una parte c’è Cosa nostra dall’altra parte c’è lo Stato. Ma non si può parlare con questa gente?». La buttai lì, convinto che lui dicesse: «Cosa vuole da me, colonnello?». Invece disse: «Si può, io sono in condizioni di farlo». […] Ciancimino mi chiedeva se io rappresentavo solo me stesso o anche altri. Certo, io non gli potevo dire: «Be’, signor Ciancimino, lei si penta, collabori che vedrà che l’aiutiamo». Gli dissi: «Lei non si preoccupi, lei vada avanti». Lui capì e restammo d’accordo che volevamo sviluppare questa trattativa […]. Il 18 ottobre, quarto incontro. Mi disse: «Guardi, quelli accettano la tratta- tiva» […]. Poi la trattativa ebbe un momento di ripensamento.
Ecco, questi erano i rappresentanti dello Stato nel 1992: si stupivano del «muro contro muro» fra mafia e Stato, non si davano pace nel vederli l’una contro l’altro armati dopo decenni di festosa convivenza. Infatti si precipita- rono a ripristinare le «larghe intese», andando a trattare con un mafioso come Vito Ciancimino per ristabilire lo status quo. C’è tutta una filosofia, nelle parole di Mo- ri. Che va ben oltre il suo pensiero. È l’atteggiamento dello Stato italiano, che ha sempre dichiarato di voler «combattere la mafia», mai di volerla sconfiggere: al massimo, per contenerla quando alza troppo la cresta. Per sconfiggerla bisognerebbe dichiararle guerra e poi vincerla. E la guerra alla mafia per sconfiggere la mafia non l’avevano in testa nemmeno i carabinieri del Ros.
Il processo in corso a Palermo vede imputate dodici persone: sei per la mafia e sei per lo Stato. Perfetta par condicio. Anche se non si capisce bene dove finisca l’una e dove cominci l’altro.
Per la mafia: i boss irriducibili Salvatore Riina, Ber- nardo Provenzano (attualmente «stralciato» per le sue gravi condizioni di salute), Leoluca Bagarella, il mafioso pentito Giovanni Brusca, e gli «ambasciatori» di Cosa nostra Antonino Cinà e Massimo Ciancimino.
Per lo Stato: gli ex carabinieri del Ros Antonio Su- branni (all’epoca comandante), Mario Mori (viceco- mandante) e Giuseppe De Donno (braccio destro di Mori); gli uomini politici Calogero Mannino (nel 1992 ministro del Mezzogiorno del governo Andreotti), Ni- cola Mancino (nel 1992-93 ministro dell’Interno dei governi Amato e Ciampi) e Marcello Dell’Utri (presi- dente di Publitalia e ideatore di Forza Italia insieme a Silvio Berlusconi).
Ciancimino risponde di concorso esterno in associazione mafiosa e calunnia nei confronti di Gianni De Gennaro. Mancino è accusato «soltanto» di falsa testi- monianza. Gli altri dieci imputati sono a giudizio per il reato previsto dagli articoli 338 e 339 del Codice penale: «Chiunque usa violenza o minaccia a un Corpo politico, o amministrativo o giudiziario o a una rappresentanza di esso, o a una qualsiasi pubblica Autorità costituita in Collegio, per impedirne, in tutto o in parte, anche temporaneamente, o per turbarne comunque l’attività, è punito con la reclusione da uno a sette anni» (che, con le aggravanti delle armi e del numero dei colpevoli, possono arrivare fino a quindici anni di reclusione). Qual è il «Corpo politico o amministrativo» violentato e minacciato nel nostro caso? Il governo italiano, anzi i governi italiani presieduti da Giuliano Amato nel 1992, da Carlo Azeglio Ciampi nel 1993, da Silvio Berlusconi nel 1994 e così via.
In separata sede sono indagati altri tre rappresentanti delle istituzioni, per false dichiarazioni al pm: Giovanni Conso (già ministro della Giustizia dei governi Amato e Ciampi), Adalberto Capriotti (dal 1993 direttore del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria presso il ministero della Giustizia) e Giuseppe Gargani (all’epoca parlamentare della Dc, poi di Forza Italia, ora in forza all’Udc). Per legge, saranno giudicati al termine del processo principale.
Nessun imputato è accusato di «trattativa»: il reato contestato è il Grande Ricatto ordito dai boss contro le istituzioni democratiche, con l’aiuto di esponenti delle istituzioni medesime che agevolarono il progetto di Cosa nostra e l’aiutarono a mettere in ginocchio vari governi, cioè lo Stato.
Si dice: per sapere se la trattativa è esistita, bisogna attendere la sentenza definitiva del processo. Eh no, troppo comodo. Sarebbe come dire: per sapere se Meredith Kercher è stata uccisa, bisogna attendere la sentenza definitiva del processo di Perugia. Il processo sulla trattativa serve ad accertare se vi furono dei reati, e in caso affermativo se sono proprio quelli contestati agli imputati, e in caso positivo se gli imputati li hanno commessi. Ma la trattativa è già certa oggi: sia perché esistono sentenze definitive che l’hanno accertata, sia perché la consecutio dei fatti la dimostra senza ombra di dubbio.
È, questo, il terzo modo di raccontare la trattativa: quello dei giornalisti (quelli veri, si capisce). L’informazione non deve fondarsi soltanto sugli atti giudiziari (che riguardano solo i reati provati al di là di ogni ragionevole dubbio), ma anche e soprattutto sui fatti accertati (in- dipendentemente dalla loro rilevanza penale). Fatti che stanno in piedi da soli, senza alcun bisogno di sentenze che li confermino. Fatti che continuerebbero a esistere anche se il processo non si celebrasse, e persino se gli attuali imputati dovessero finire tutti assolti. Fatti che possiamo raccontare già oggi, a prescindere dal processo.
«Io so, ma non ho le prove» diceva Pier Paolo Pasolini a proposito della strage di piazza Fontana. Noi, a proposito della trattativa Stato-mafia, siamo più fortunati: abbiamo le prove. Ma quasi tutti fanno finta di non sapere.
Marco Travaglio, È Stato la Mafia.Tutto quello che non vogliono farci sapere sulla trattativa e sulla resa ai boss delle stragi, Ed. Chiarelettere, Milano 2014, Libro + DVD, pagg.160, € 14,90
Condividi su Facebook
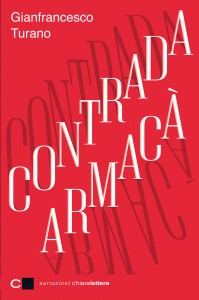 Un giallo ambientato nel cuore di Reggio Calabria, tra violenza e bellezza, irresistibile vitalismo e sanguinaria ferocia. Scritto dal bravo giornalista, e inviato dell’Espresso, Gianfrancesco Turano (nato lui stesso a Reggio Calabria).
Un giallo ambientato nel cuore di Reggio Calabria, tra violenza e bellezza, irresistibile vitalismo e sanguinaria ferocia. Scritto dal bravo giornalista, e inviato dell’Espresso, Gianfrancesco Turano (nato lui stesso a Reggio Calabria).