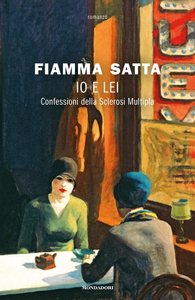– Evita assolutamente di conoscere i nomi dei correntisti.
– E se invece li chiedessi?
– Amico mio, avrai quindici minuti per mettere in
sicurezza i tuoi figli.
Conversazione telefonica riservata tra l’ex presidente Ior
Ettore Gotti Tedeschi e un uomo delle istituzioni
Le verità che mancavano.
I segreti e le paure di papa Luciani.
La trattativa mai svelata sul caso Emanuela Orlandi.
I documenti riservati dello Ior.
I conti correnti di papi, cardinali, attori famosi e politici.
La verità sulle dimissioni di Ratzinger.
La battaglia sotterranea contro le riforme di Francesco.
Gli abusi sessuali tra i chierichetti del papa che vivono in
Vaticano.
L’imperversare della lobby gay.
IL LIBRO
Dopo “Vaticano Spa”, “Sua Santità”, “Via Crucis”, tre inchieste che ci hanno introdotto nelle stanze e nei segreti più profondi del Vaticano, in questo nuovo libro , presentato ieri a Roma, Gianluigi Nuzzi ricompone, attraverso documenti inediti, carte riservate dall’archivio Ior e testimonianze sorprendenti, i tre fili rossi – quello del sangue, dei soldi e del sesso – che collegano e spiegano la fitta trama di scandali, dal pontificato di Paolo VI fino a oggi. Una ragnatela di storie dagli effetti devastanti, che hanno suscitato nel tempo interrogativi sempre rimasti senza risposta e che paralizzano ogni riforma di papa Francesco.
L’autore ricostruisce finalmente molte verità che mancavano, a cominciare dal mistero della morte di papa Luciani e il suo incontro finora mai divulgato con Marcinkus; la trattativa riservata tra Vaticano e procura di Roma per chiudere il caso Emanuela Orlandi; i conti di cardinali, attori, politici presso lo Ior, tra operazioni milionarie, lingotti d’oro, fiumi di dollari e trame che portano al traffico internazionale di droga; l’evidenza di una lobby gay che condiziona pesantemente le scelte del Vaticano, tra violenze e pressioni perpetrate nei sacri palazzi e qui per la prima volta documentate. Ecco il “fuori scena” di un blocco di potere per certi aspetti criminale, ramificato, che continua ad agire impunito, più forte di qualsiasi papa (Ratzinger è stato costretto alle dimissioni aprendo però la strada a Bergoglio), sempre capace di rigenerarsi, che ostacola con la forza del ricatto e dei privilegi ogni tentativo di riforma.
L’AUTORE
Gianluigi Nuzzi, milanese, è autore di diverse inchieste e scoop che hanno avuto vasta eco, anche internazionale. Nel 2009 “Vaticano Spa” rivela, grazie alle carte segrete di monsignor Renato Dardozzi, gli scandali finanziari e politici dei sacri palazzi, accelerando le dimissioni del presidente dello Ior Angelo Caloia, in carica da vent’anni. Nel 2012 “Sua Santità” rende pubbliche le carte riservate del papa, stravolgendo gli equilibri di potere vaticani e facendo scoppiare una crisi che contribuirà alle dimissioni di Ratzinger nel 2013. Nel 2015 “Via Crucis” racconta la lotta di papa Bergoglio per una chiesa più trasparente e cristiana svelando nuovi documenti segreti. Per questo l’autore sarà processato e poi prosciolto. Nuzzi ha anche ideato e condotto la trasmissioni “Gli intoccabili” su La7 e attualmente conduce su Rete4 “Quarto grado”, incentrata sui grandi casi di cronaca che appassionano e dividono l’opinione pubblica.

PER GENTILE CONCESSIONE DELL’EDITORE
PUBBLICHIAMO UNO STRALCIO DEL LIBRO
Questo libro
Papa Francesco e le sette domande
Peccato originale vuole rispondere a sette precise domande, che rappresentano i tasselli mancanti nel lavoro di ricerca che porto avanti ormai da dieci anni, un lavoro che con Vaticano S.p.A., Sua Santità e Via Crucis ha trovato le prime verità. È stato ucciso Albino Luciani? Chi ha rapito Emanuela Orlandi? Se la ragazza ormai «sta in cielo», come afferma papa Francesco, il Vaticano ha delle responsabilità nell’omicidio, e quali sono? Perché le riforme per la trasparenza della curia, avviate prima da Joseph Ratzinger e adesso da Bergoglio, puntualmente falliscono o rimangono incompiute? Cosa blocca il cambiamento? E ancora: i mercanti del tempio continuano a condizionare la vita della Chiesa dopo aver avuto un ruolo nella rinuncia al pontificato di Benedetto XVI? Infine, la questione più drammatica: lo stallo nel quale sono cadute le riforme di Francesco è dovuto a chi non vuole questo papa, dentro e fuori i sacri palazzi, e dunque ne ostacola l’opera riformatrice? Per rispondere a queste sette domande, come insegnava il giudice Giovanni Falcone, ho seguito il filo del denaro, che in ogni storia di potere s’intreccia a quello del sangue e a quello del sesso. Tre fili rossi, quindi, che annodandosi tra loro costituiscono una fitta trama d’interessi opachi, violenze, menzogne, ricatti, e soffocano ogni cambiamento, alimentando inevitabilmente quella che Ratzinger indicava come la crisi della fede. Una ragnatela mortale che si espande già nel pontificato di Paolo VI, in un mondo dilaniato dalla guerra fredda, nell’Italia instabile delle rivolte operaie, del terrorismo, dei poteri occulti che trovano nei sacri palazzi la sponda più inattesa, potente, ramificata. Bisogna partire da lì, riconsiderando soprattutto l’operato dell’arcivescovo Paul Casimir Marcinkus, al vertice dello Ior, la banca del papa, e le sue inquietanti connessioni fin dentro l’appartamento pontificio, fino ai paradisi offshore nell’America dei cartelli, dei golpe, della cocaina. In Vaticano Marcinkus raccoglie e garantisce interessi che ora si possono ricostruire attraverso l’archivio inedito dello Ior, fatto di decine e decine di documenti finora rimasti sconosciuti: contabili, appunti, fogli di cassa, che rivelano depositi dai saldi sorprendenti, come quelli intestati a monsignor Pasquale Macchi, storico segretario particolare di Paolo VI, o i conti di clienti inattesi come l’attore Eduardo De Filippo o madre Teresa di Calcutta, ospite riverita negli uffici più riservati della banca. Queste carte, con i desiderata inconfessabili di preti e cardinali, tra compravendite d’oro, dollari e palladio, spiegano perché il pontificato di papa Luciani è durato solo trentatré giorni e perché, anche negli anni Novanta, gli eredi di Marcinkus hanno perseverato sulla sua stessa strada, condizionando le finanze vaticane. Fino ad arrivare ai giorni nostri, al pontificato di Benedetto XVI che mette in cantiere le riforme volte a chiudere per sempre con questo passato. Un’opera portata avanti dagli uomini scelti da Ratzinger, porporati e laici, che tuttavia sono stati inesorabilmente «impallinati»: chi licenziato, chi delegittimato, chi esautorato, in una fine strategia svelata in queste pagine grazie a interviste con alcuni dei protagonisti e a documenti inediti e rivelatori.
Quando Benedetto XVI pianificava la rinuncia
Da qui, la pianificazione della rinuncia di Benedetto XVI, che vede manomesso il suo pontificato. I nuovi elementi raccolti e svelati in questo libro, tra retroscena e raffinati giochi di potere, portano a retrodatare già all’inverno del 2011 la progettazione di questo clamoroso passo indietro, preparato in ogni dettaglio. È proprio in quel periodo che in Vaticano si consumano gli scontri più violenti e finora mai trapelati: da una parte precise azioni per risolvere questioni drammatiche e togliere così ingombranti fardelli al successore di Ratzinger, dall’altra sofisticate operazioni per sabotare questi cambiamenti. Una situazione che si ripete nel pontificato di Francesco. A lui la folla acclamante, il grande sostegno delle piazze, l’abbraccio infinito della moltitudine di fedeli nel mondo. Alla curia la gestione dell’amministrazione della Chiesa e del piccolo Stato Città del Vaticano, che vivono grazie alle offerte dei fedeli. Ma di come questi denari vengano spesi e investiti ancora oggi si sa poco o nulla. Due volti, un unico mondo: nei sacri palazzi c’è chi sostiene Bergoglio ma anche chi si prodiga a sabotare le riforme. «Se vogliamo che tutto rimanga com’è – scriveva Giuseppe Tomasi di Lampedusa ne Il Gattopardo – bisogna che tutto cambi.» Non è un caso se proprio oggi arrivano denunce su presunte vessazioni e abusi sessuali consumati all’interno delle mura vaticane, con notti da incubo raccontate da chi era presente. A tutela delle vittime, ma anche del presunto carnefice, ho preferito sostituire i nomi dei protagonisti con altri di fantasia, in attesa che la giustizia faccia il suo corso. Per questo una delle prime copie del libro è già stata portata all’attenzione dei giudici vaticani. È necessario partire innanzitutto dal filo del sangue, dalla storia di Emanuela Orlandi, un caso che con Ratzinger, prima della rinuncia, torna a essere di stringente attualità. Non è una storia del passato, è una storia di oggi. Emanuela, la ragazza di appena quindici anni, figlia di un messo pontificio, sparita misteriosamente a Roma il 22 giugno 1983 è una spina nel fianco del Vaticano. Anche del pontificato di papa Francesco. La sua scomparsa rappresenta una ferita ancora non rimarginata, un fantasma che ritorna mostrando verità indicibili rimaste chiuse nei sacri palazzi, diventate strumenti di potere e ricatto per chi ne è a conoscenza. Grazie a documenti e testimonianze di chi ha deciso di uscire allo scoperto e di raccontare, per la prima volta, ciò che ha visto e sentito, siamo in grado di ricostruire come la verità su quanto accaduto alla ragazza sia nascosta proprio in Vaticano. Una storia ancora da scrivere negli sviluppi più clamorosi rimasti riservati. Una storia che preoccupava Benedetto XVI tanto da spingere la Santa sede ad aprire, negli ultimi due anni del suo pontificato, un dialogo segreto, una «trattativa» con la procura di Roma. Un caso che ha visto l’interesse anche di papa Francesco, con la richiesta di approfondimenti affidata al suo primo collaboratore, il segretario di Stato Pietro Parolin. La speranza è che oggi, finalmente, queste nuove verità possano aiutare a dare giustizia a Emanuela, ai suoi familiari e a chi le vuole bene.
Gianluigi Nuzzi, Peccato originale. Conti segreti, verità nascoste, ricatti:il
blocco di potere che ostacola la rivoluzione di Francesco, Ed. Chiarelettere,
Milano 2017 . 18,60 euro, pagg.352



 Arrigo Petacco, incominciamo questa “chiacchierata” con il dire che “Caporetto” non esiste, o meglio si tratta di una storpiatura fatta dagli italiani di un nome sloveno, che esiste, ci spieghi come nasce questa “invenzione”…
Arrigo Petacco, incominciamo questa “chiacchierata” con il dire che “Caporetto” non esiste, o meglio si tratta di una storpiatura fatta dagli italiani di un nome sloveno, che esiste, ci spieghi come nasce questa “invenzione”…