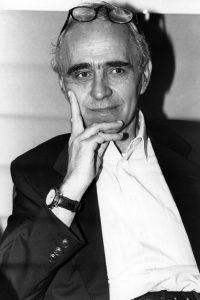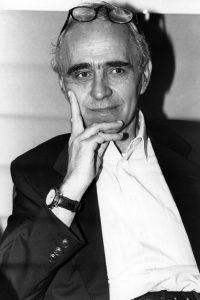
Pierre Carniti (Foto LaPresse)
Ieri, nel pomeriggio, Pierre Carniti ha scritto una lettera aperta alle tre grandi Confederazioni sindacali italiane: Cgil,Cisl e Uil. Per gentile concessione, della testata online letruria.it, pubblichiamo il tesato della lettera.
Cari amici e compagni,
la recente sortita di Di Maio, con la inconcepibile minaccia rivolta soprattutto al sindacalismo confederale, minaccia che comprende il proposito di riformarlo autoritariamente se mai lui dovesse arrivare a Palazzo Chigi, è sicuramente indicativa dei limiti del dirigente “pentastellato”. Sia della sua cultura costituzionale, come della sua consapevolezza circa il ruolo essenziale dell’autonomia dei gruppi intermedi nell’assicurare l’indispensabile vitalità democratica, nelle società complesse e fortemente strutturate. L’improvvida uscita del giovane parlamentare, della nebulosa grillina, potrebbe indurre i più sprovveduti a credere che la dialettica sociale possa essere neutralizzata “statalizzando” la società. Tuttavia, non c’è dubbio che la sconsiderata sortita di Di Maio può, al tempo stesso, essere interpretata come una spia anche del declino della popolarità del sindacato. Condizione che induce alcuni politici e politicanti ad uniformarsi a quello che viene considerato il “senso comune”. Anche se, come spiegava bene Manzoni, è generalmente diverso, e non di rado opposto, al “buon senso”. Insomma, Di Maio è stato l’ultimo in ordine di tempo a dire sciocchezze sul sindacato. Ma non è nemmeno l’unico. Basterà ricordare che non moltissimo tempo fa un noto politico, investito da preminente responsabilità istituzionale, non aveva esitato ad affermare che il tempo dedicato al confronto con il sindacato era da considerare, nei fatti, “tempo sprecato”.
In ogni caso, più che occuparci delle intimidazioni del candidato premier grillino con la sua pretesa di reclamare una “oscura autoriforma” del sindacato o, in assenza, di una riforma decisa dispoticamente dal governo, proposito che, fortunatamente non sembra costituire un reale pericolo imminente, vale la pena di interrogarci sulle difficoltà che hanno progressivamente indebolito ed indeboliscono il consenso su cui può contare il sindacato.
La prima cosa da dire è che sicuramente non hanno giovato alla sua credibilità ed al suo prestigio i deplorevoli episodi di devianza etica di singoli dirigenti e militanti. Anche perché non sempre sono stati contrastati con la tempestività e la determinazione che sarebbe stata invece necessaria. Il che ha ovviamente favorito l’ampliamento del fronte di quanti chiedono all’organizzazione dei lavoratori, come prova suprema di responsabilità, semplicemente di scomparire. Opinione incoraggiata da titubanze ed incertezze che, di fronte a riprovevoli episodi, che si sono purtroppo verificati, andavano invece scongiurate con la tempestività, la trasparenza e la determinazione necessaria. Quanto meno per impedire strumentalizzazioni e, soprattutto, che venisse gettata un’ombra sulla moralità e reputazione dell’intero sindacato. Il rammarico quindi è che ciò non si sia verificato con la decisione auspicabile. Che non sempre si è invece vista. Quanto meno nei termini e nelle forme necessarie ed attese. Tuttavia, per quanto questi episodi di devianza siano stati indiscutibilmente dannosi, non si può oscurare il fatto che i veri fattori di criticità e di debolezza del movimento sindacale vanno ricercati altrove. Soprattutto nelle questioni irrisolte di carattere strutturale. Che coinvolgono sia problemi oggettivi, che limiti soggettivi. Cause che sono alla base della tendenza diffusa a snervare progressivamente la reputazione ed il ruolo del sindacato.
Per quanto riguarda i problemi oggettivi l’elenco delle questioni è noto. A cominciare dalla svalutazione del lavoro. Sia sul piano dell’affievolimento dei diritti, che del trattamento economico. Strettamente intrecciata è la questione cruciale del lavoro. Del lavoro che cambia e del lavoro che manca. Membri del governo e della maggioranza non lesinano, comprensibilmente, sforzi per valorizzare l’occasionale diminuzione di qualche decimale di punto del tasso di disoccupazione. Variazioni, che però non producono cambiamenti sostanziali dei reali termini del problema. Del resto basta osservare il “tasso di occupazione” per capire come stanno veramente le cose. Da noi sono occupate poco più di sei persone su dieci. Il dato peggiore dell’Unione europea. Ad eccezione della Grecia. Abbiamo inoltre un forte squilibrio di genere (71,7 gli uomini occupati, 51,6 le donne). Grande anche il divario territoriale tra Centro-Nord e Sud (69,4 contro 47 per cento). Dati che dovrebbero indurre a riflettere sulla congruità ed appropriatezza delle misure adottate per migliorare la situazione occupazionale. Come si sa, prevalentemente incentrate in interventi dal lato dell’offerta, incentivi, bonus ecc. Con il risultato di aumentare in parte la precarietà e comunque con esiti inversamente proporzionali alle cospicue risorse mobilitate. Non è perciò arbitrario ritenere che insistendo su queste politiche la soluzione del problema del lavoro resti un miraggio. Con tutte le gravi conseguenze personali, familiari e sociali che questa crisi si porta dietro.
Ci sono poi le questioni della tutela del lavoro e della protezione sociale. Al riguardo non si dovrebbe mai dimenticare che una fondamentale ragione d’essere del sindacalismo (specie confederale) sta nel conseguimento di modelli e regole “universalistiche”. In particolare, con riferimento alla previdenza, all’assistenza. alla salute, all’istruzione, ecc. In proposito, si deve rilevare che diversi indicatori segnalano come silenziosamente (nel senso che non se ne ritrova traccia nel dibattito pubblico) si sta invece andando nella direzione opposta. Per fare un solo esempio. L’Istat ci informa che il 23,3 per cento della spesa sanitaria è ormai a carico delle famiglie. Risultato: secondo una stima, non contestata da nessuno, 12 milioni di italiani (soprattutto nelle fasce sociali più fragili e deboli) non si curano più. Perchè tra ticket e superticket, analisi a pagamento (se si vogliono effettuare gli esami in tempo utile) non sono in condizione di fare fronte alle spese relative. Sicché un diritto fondamentale, come quello alla salute, tende a dipendere sempre più dal possesso, o meno, di una carta di credito. Colpisce il fatto che per giustificare tale involuzione si usi una formula esoterica. Gli “esperti e gli addetti ai lavori” parlano infatti di “universalismo selettivo”. Se la cavano quindi con un ossimoro. Che tradotto nel linguaggio popolare significa semplicemente “per un discreto numero, ma comunque non per tutti”. Il senso politico che se ne deve trarre è che la “libertà”, se deve essere difesa come requisito universale, richiede equità e giustizia sociale. Quando questi requisiti difettano, o diventano evanescenti, non si può parlare di vera libertà. Per la buona ragione che non è la condizione di tutti.
C’è poi il dramma di quanti, pur avendo un lavoro, non riescono ad arrivare alla fine del mese. I dati del rapporto Istat “Noi Italia” ci dicono che il nostro Pil pro-capite, misurato in standard di potere d’acquisto (depurato, per rendere possibile il confronto, dai differenti livelli dei prezzi nei vari paesi), risulta inferiore del 4,5 per cento rispetto a quello medio dell’Unione Europea. Significativamente più basso di quello di Germania e Francia (rispettivamente del 23,6 e 9,2). Naturalmente, come per tutte le statistiche, anche questa si basa sulla “media di Trilussa”. Il che ci aiuta comunque a capire perché le diseguaglianze dilagano, e 7 milioni di persone sono in condizione di povertà relativa, mentre 4 milioni e mezzo sono in condizione di povertà assoluta. Cioè senza casa, senza tetto, senza tutto.
Non minore rilievo ha infine il problema delle pensioni. Che non a caso domina, a proposito ed a sproposito, sui media e nel dibattito pubblico. Con allarmi e disinformazioni che tolgono il sonno a milioni di lavoratori, a quanti sperano di diventarlo, ed alle relative famiglie. Sul tema prevale una voluta confusione. Si cammina infatti in una nebbia fitta nella quale si sentono in lontananza interventi allarmistici che, non di rado, sfociano in forme di terrorismo verbale. C’è quindi la urgente necessità di mettere una questione così delicata con i piedi per terra e cercare, per quanto faticoso, di farla uscire dal pantano. Muovendo da questo intento la prima cosa da fare consiste nell’impedire alla politica dal continuare a pasticciare in materia previdenziale. I disastri che ha combinato nel corso degli anni sono più che sufficienti per reclamare una decisione in tal senso. Per non farla lunga basterà ricordare: la concessione, quando la “bonomiana” era la più potente lobby parlamentare, della pensione ai coltivatori diretti, senza pagamento di contributi. Oppure il privilegio riconosciuto (nel 1973 dal governo Rumor) ai dipendenti pubblici inquadrati nell’Inpdap (Ente di previdenza per i dipendenti della P.A.) delle baby pensioni. Trattamento usufruibile da tutti i lavoratori statali che avessero maturato un periodo di lavoro di almeno 15 anni sei mesi e un giorno. Ancora meno per le donne con figli. L’esito, come forse non era difficile prevedere (malgrado all’epoca la finanza pubblica fosse certamente in condizione migliore di quanto non sia ora), è stato che, nel giro di non molti anni, i conti dell’Inpdap sono finiti in dissesto. A quel punto la “soluzione” escogitata fu quella di trasferire e far assorbire dall’Inps l’Ente previdenziale dei dipendenti pubblici. Scaricando così sul bilancio dell’Inps, assieme all’obbligo di onorare il pagamento delle baby pensioni, anche i debiti accumulati. Il precedente aveva fatto scuola. Infatti, si è fatto ricorso all’Inps per fare fronte al sostanziale fallimento dell’Ente previdenziale dei dirigenti d’azienda. Poi per quello dei trasporti. Infine per quello delle telecomunicazioni. Anche tante altre questioni, nel corso degli anni, sono state affrontate con la stessa disinvoltura. Al punto che si è ormai determinato un inestricabile intreccio tra assistenza e previdenza. Tant’è vero che le pensioni vengono normalmente considerate dai commentatori come un unico capitolo della spesa pubblica. Assumendolo come parametro della loro sostenibilità. In sostanza, la specificità della previdenza nel dibattito pubblico è sostanzialmente scomparsa. Ha contribuito ad alimentare questa confusione il fatto che a seguito delle cervellotiche scelte compiute dalla politica, l’Inps si è progressivamente trasformato in “un’ Idra”, in una “conglomerata”, in un “combinat”, nel quale è stato scaricato “anche se non tutto”, “un po’ di tutto”. Comprese un buon numero di incombenze, che con la corresponsione delle pensioni non c’entrano assolutamente nulla. Per rimediare a questo pasticcio la strada maestra non può che essere quella di dividere l’Inps. Istituendo due Enti distinti. Uno con il compito di occuparsi di Welfare pubblico e l’altro incaricato esclusivamente di gestire la previdenza. Senza questa misura tanto drastica, quanto razionale, è praticamente impossibile togliere il tema delle pensioni dal magma nel quale, ogni giorno che passa, rischia di affondare. Oltre tutto realizzando due organismi separati e distinti: uno per assicurare una efficace assistenza e protezione sociale, l’altro per gestire esclusivamente pensioni e garantire il loro equilibrio economico-finanziario, ci metteremmo in linea con il resto dell’Europa. Soprattutto si incomincerebbe a dare ai cittadini di questo paese, sempre più inquieti e preoccupati, la concreta prospettiva che venga ricostruita la speranza che torni ad essere possibile il passaggio dalla vita attiva ad una vecchiaia ancora ragionevolmente serena. Guardando i termini attuali della situazione si è indotti a ritenere che “non c’è tempo da perdere”. Anche perché diversamente, si deve mettere in conto che, se dovesse continuare l’attuale andazzo, “sarà il tempo a perdere noi”.
Quelle richiamate non sono ovviamente tutte le situazioni negative che gravano sull’incerta condizione attuale del lavoro, che richiedono di essere riformate. Tra l’altro vi si dovrebbe aggiungere la necessità di una ripartizione del lavoro. Passaggio obbligato, se l’obiettivo del pieno impiego deve essere preso sul serio. Oppure l’esigenza di intervenire sul cuneo fiscale che oggi pesa in maniera squilibrata sul lavoro dipendente rispetto agli altri redditi. O ancora sulla urgenza di migliorare le competenze, e quindi la produttività, con investimenti, non puramente simbolici, sul “capitale umano” e quindi sulla formazione continua. Dove siamo in grave ritardo rispetto al resto dell’Europa. Tuttavia ciò che serve non è un elenco dettagliato, analitico, delle questioni che pesano negativamente sulla condizione del lavoro e reclamano una soluzione. Serve in particolare la capacità di selezionare e decidere le priorità. Per riuscirci dobbiamo fare i conti con i “limiti soggettivi”, che attualmente affliggono il ruolo sindacale. A cominciare dallo sbrindellamento della contrattazione e della rappresentanza del lavoro. Alcuni indicatori non possono che suscitare allarme e preoccupazione. Basti pensare che i contratti nazionali, o pseudo tali, hanno ormai superato l’incredibile cifra di 800 e che le strutture organizzative vere, fasulle, false, contraffatte, danno vita ad un sottobosco nel quale si trova di tutto: formazioni composte da quattro amici del bar, oppure da “parentes et clientes”. In non pochi casi, esclusivamente finalizzate a beneficiare questo o quel personaggetto. Quindi il dato che colpisce è che siamo ormai in presenza di una frammentazione, di una proliferazione del tutto inimmaginabile fino a pochi decenni fa. Un paio di esempi possono valere di più di mille parole. Il primo. Come si ricorderà, non è passato molto tempo dalla protesta dei tassisti. Che per le modalità con cui si è svolta, più che uno sciopero, assomigliava piuttosto ad una incontrollata ribellione. Ebbene, con l’intento di riportare la situazione alla “normalità”, il Ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture ha convocato una riunione, alla quale hanno liberamente partecipato tutte le organizzazioni conosciute e sconosciute. Risultato: intorno al tavolo del confronto, in rappresentanza dei 50.000 tassisti di tutta Italia, si sono ritrovate ben 21 diverse sigle. Se passiamo dal lavoro autonomo, concessionario però di un servizio pubblico, a quello più classicamente dipendente, colpisce il caso dell’Atac (l’azienda di trasporto pubblico) di Roma. Dove in rappresentanza dei 12 mila dipendenti ci sono ben 15 organizzazioni sindacali. Anche senza voler stabilire un arbitrario rapporto di causa ed effetto, si è indotti a pensare che sullo sfascio dell’azienda, che è ormai sotto gli occhi di tutti, a crescere sono soltanto le rendite di posizione.
Questa situazione non è stata e non è priva di conseguenze. Perciò, se, come sarebbe utile, Cgil, Cisl ed Uil intendono invertire la pericolosa frammentazione in atto, debbono fare scelte chiare ed assumere comportamenti coerenti. Ad iniziare da sé stesse. Per dirla in termini chiari la propensione alla dispersione ed alla frammentazione si combatte, innanzi tutto, con l’esempio di un impegno unitario. Condotta che in alcune circostanze si è anche fortunatamente realizzata. Ma che non può essere certo interpretata come un vincolo, bensì come un discrimine di valore strategico al quale sia legata la gestione delle scelte sindacali. Infatti, sul bisogno di unità, nella pratica quotidiana dominano piuttosto le esigenze di identità. E, nella sostanza, un atteggiamento inevitabilmente orientato alla concorrenza ed alla competizione. La giustificazione degli “addetti ai lavori” per questo stato di cose è nota e, secondo alcuni, anche ragionevole. In sostanza viene invocato il motivo che le differenze di orientamento, di cultura, di tradizioni, nei fatti, producono inevitabilmente anche strategie politiche diverse. A ben vedere si tratta però di una spiegazione che non spiega nulla. Intanto per la buona ragione che le differenze sulle politiche ci sono sempre state e ci saranno sempre. Non solo tra diverse organizzazioni, ma anche all’interno di ciascuna organizzazione. E quando non si manifestano è un cattivo segno. Perché vuol dire che la dialettica interna è anestetizzata dal conformismo e dall’opportunismo. In ogni caso, si possono anche capire tutti i dubbi e le perplessità, ma viene un momento e questo momento per il sindacalismo confederale è sicuramente venuto, che dubbi e perplessità rischiano di non essere altro che un alibi per sfuggire alle proprie responsabilità. Il lavoro da sviluppare è, dunque, quello di cogliere l’unità nella diversità e di trasformare il superamento delle diversità in una ragione di irrobustimento dell’unità. Condizione indispensabile per realizzare, come richiesto dalle sfide da affrontare, un impegno solidale, condiviso, efficace. Va detto che in proposito non è possibile alcuna indulgenza, nessuna condiscendenza. Perché, mentre per la soluzione dei problemi che riguardano la condizione del lavoro si devono fare i conti con l’opposizione, la resistenza delle controparti e degli avversari, in questo campo tutto dipende esclusivamente dalla volontà e dalla coerenza soggettiva del movimento sindacale confederale.
Sappiamo che le cose sono cambiate e non saranno mai più le stesse di un tempo. Perché la storia accelera e scopriamo non solo di essere in affanno e spesso in ritardo. Tuttavia, non possiamo essere condiscendenti con noi stessi. Perché quanti, come chi scrive, sono convinti che il sindacato abbia ancora una funzione essenziale da esercitare, per realizzare più equità sociale, migliori condizioni di lavoro e di vita, garantire un importante pilastro della democrazia, devono fare quanto dipende da loro per cercare, con un impegno collettivo, di risalire la china. Non possono quindi esimersi dal compiere i passi necessari, a cominciare dalle indispensabili pre-condizioni, per ridare al mondo del lavoro un progetto ed una speranza credibili. Inutile sottolineare che la strada è tutta in salita e che il cammino è alquanto impervio. Perché le difficoltà da affrontare sono serie ed impegnative. Ma al tempo stesso si deve essere consapevoli che c’è una sola difficoltà davvero insuperabile: è la rassegnazione. Per scongiurare questo pericolo, faccio mia l’affermazione dell’ex presidente del Consiglio europeo, già primo ministro belga, Herman Van Rompuy, che in un recente intervento a Roma, ha detto: “Io resto un uomo della speranza”
Fiducioso quindi che verranno compiute le scelte necessarie, assieme alla conferma della permanente vicinanza e solidarietà di vecchio militante, invio fraterni saluti.
Pierre Carniti
Roma, 9 ottobre, 2017
Condividi su Facebook