
In occasione dei 50 anni dalla morte di Romano Guardini, il grande teologo italo-tedesco , uno dei “Padri della Chiesa del XX secolo”, avvenuta a Monaco di Baviera il 1 ottobre 1968 , Lo Studio Teologico san Zeno in collaborazione con Vicariato per la Cultura-Diocesi di Verona, Vicariato Verona centro e la “Fondazione Giorgio Zanotto”, hanno realizzato un convegno, lunedì scorso, per ricordare la sua figura. Pubblichiamo, per gentile concessione dell’autore, il testo dell’intervento del professor Silvano Zucal, docente di Filosofia Teoretica all’Università di Trento.
(I titoli dei paragrafi sono a cura del redattore)
Le due identità
(1) (2) (3) (4) Romano Guardini nasce a Verona nel 1885 e già l’anno successivo si trasferisce a Magonza con la famiglia. In quella città conseguirà la maturità ginnasiale. Si iscriverà poi alla facoltà di chimica a Tubinga per passare, successivamente, a quella di economia politica (1904) presso le Università di Monaco e di Berlino. Ma la sua vocazione lo conduce altrove e nel 1905 studierà alla facoltà teologica di Tubinga e poi di Friburgo fino a ricevere nel 1910 l’ordinazione sacerdotale. Una formazione culturale che avviene dunque interamente in àmbito tedesco. Ben diversa era la situazione in famiglia dove si parlava in italiano e si veicolava in modo convinto la tradizione culturale italiana. Il padre Romano Tullo, nato a Verona (1857), importatore di pollame(per la grande azienda italiana “Import Grigolon-Guardini &Bernardinelli GmbH”) è politicamente un appassionato sostenitore di Cavour e un cultore di Dante e nel 1910 diventerà console onorario italiano. La madre Paola Maria Bernardinelli è invece trentina, nativa di Pieve di Bono (1862) nelle valli Giudicarie (anche se la famiglia proveniva da Javrè in Val Rendena),viene da una famiglia che possedeva un’osteria e poi una macelleria, studierà nell’istituto delle Dame inglesi a Merano e nella famiglia rappresenta, ancor più profondamente e fortemente del marito, lo spirito italiano unito ad una posizione anti-asburgica e più in generale a un rifiuto non privo di risentimento per tutto ciò che è tedesco. Non potrà quindi che generare perplessità e sconcerto nella famiglia il fatto che il figlio primogenito Romano decidesse, nonostante l’opposizione esplicita dei genitori, di assumere nel 1911 la cittadinanza tedesca compiendo una sorta di “esodo” volontario dalla patria originaria italiana. Lui solo oltretutto di tutta la famiglia (rientrata poi in Italia dopo l’improvvisa morte del padre avvenuta nel 1919) aveva optato per il Nord.
(5) (6) Con la scelta della cittadinanza, Guardini divenne a pieno titolo e con una sorta di sigillo formale un pensatore espressivo della cultura tedesca, che egli aveva ormai assorbito in modo irreversibile. Se nella casa paterna di Magonza, nel Gonsenheimer Hohl, egli aveva respirato la cultura italiana oltre ad averne appreso la lingua, al di fuori di essa, a scuola, tra gli amici, nella formazione spirituale, all’Università, lingua e cultura furono infatti indelebilmente segnate dal mondo tedesco. Certo frequenti furono ancora i viaggi in Italia in visita alla madre (vivrà fino 95 anni, morendo nel 1957 quando Guardini aveva già 72 anni), ai tre fratelli Gino Ferdinando, Mario e Aleardo e ai nipoti, con soste prolungate nella residenza materna inizialmente sul lago di Como e poi, soprattutto a partire dalla fine degli anni ’20, a Villa Guardini a Isola Vicentina presso Vicenza dove egli amava preparare le sue lezioni camminando tra gli amati alberi che contemplava senza stancarsi. Una sorta di addio all’Italia sarà l’ultimo viaggio nell’agosto del 1968 (dal 28.8 al 15.9), avvenuto poco prima di morire (morirà il 1 ottobre) con tappe deliberate prima di attraversare il confine a Trento e a Bressanone. Oltrepassato il Brennero egli comunque osservò: «Ho sempre l’impressione che qua nel Nord vi sia una dimensione in più…».
(7) Questa relazione seppur intensa con l’Italia non cambierà mai la sua prospettiva culturale complessiva. Quando, durante la prima guerra mondiale, dovrà addirittura svolgere il servizio militare come infermiere in un ospedale militare indossando l’uniforme tedesca mentre due fratelli prestavano servizio nell’esercito italiano il conflitto latente tra le sue due identità diverrà ancor più lacerante ed esplosivo. Alcuni anni più tardi cercherà di mostrare come aveva vissuto questa singolare conflittualità e come aveva cercato di uscirne ovvero con il suo auto-identificarsi come “cittadino europeo”. Di qui l’assoluto rilievo dei suoi scritti sull’Europa.
La genesi dell’ Europa
I numerosi saggi europeistici di Romano Guardini restituiscono non solo la potenza dell’argomentare del filosofo italo-tedesco ma anche un clima aurorale, una “genesi” del “fatto-Europa”. Elemento su cui merita ritornare soprattutto nel contesto odierno in cui l’Europa vive una particolare crisi d’identità. Parto sofferto quello europeo, drammatico, non scontato, esito di conflitti, di inquietudine e di tormenti sia biografici sia nazionali.
Guardini sente gravare su di sé un destino di primo acchito irriducibile e insieme incomponibile: l’appartenenza a due patrie, due mondi culturali e spirituali diversi e nella grande guerra civile del Novecento ora alleati ora in conflitto. Come uscirne? Le sue potenti meditazioni sull’Europa dicono che solo l’Europa poteva diventare non solo “un destino” di ricomposizione per la sua personale identità duale, ma anche un compito etico da consegnare al futuro dei popoli europei fuoriusciti dall’epoca tragica segnata dalle guerre, dai totalitarismi e dalla macchia indelebile della Shoà. I quattro testi più rilevanti sono composti in momenti diversi con una sorta di crescendo.
Il primo, in senso cronologico, è un intervento ripreso dagli appunti di Josef Außem. Siamo a Grüssau (Slesia), nella Pentecoste del ’23, a un convegno della Jugendbewegung e Guardini è già il leader riconosciuto del movimento giovanile tedesco. La descrizione di Außem ci restituisce in modo quasi palpitante (sorta d’affresco) il clima spirituale davvero ambiguo della Germania frustrata e occupata, foriero purtroppo di tragedie, e impressiona quell’accorrere di migliaia di giovani in attesa famelica di un obiettivo che dia senso al loro futuro. Guardini dovrebbe parlare solo d’altro, del “senso della Chiesa”, ma in una sorta di coup de théâtre il relatore ufficiale sul tema politico e sul rapporto tra dimensione nazionale ed Europa, il parroco Rohn, viene a mancare e toccherà proprio a Guardini, italiano naturalizzato tedesco, affrontare un tema per lui imprevisto e in parte problematico. Egli si schermisce, appare come titubante ad affrontare da oriundo italiano un tema “cosi tedesco”, ma poi coglie proprio una tale occasione per confessare in pubblico il suo tormento interiore relativo alla scelta del servizio militare con l’esercito tedesco: «Il suo essere spirituale si radica, egli sostenne, nella cultura tedesca. Ha militato nell’esercito come soldato e la guerra e la disfatta lo avevano posto di nuovo di fronte alla decisione di definire a quale popolo egli davvero appartenesse. Si è deciso per la Germania. […] È intimo dovere morale stare dalla parte del proprio popolo e contribuire a sostenere la sua opera. […] Questo dovere sussiste in periodi normali, più che mai in quelli straordinari, quando al popolo sopravviene una distretta; allora la fedeltà dev’essere doppiamente profonda e l’unita doppiamente grande. Al tempo della disfatta avemmo la sensazione di uno che affoga, per il quale ne va dell’onore e dell’essere. Per chiunque abiti in un territorio occupato si faceva buio nel giorno più luminosamente chiaro quando vedeva comparire le uniformi straniere».
Chiarito il significato di “fedeltà”, in specie nel momento della disfatta, emerge pero già in questo intervento di Guardini un primo spiraglio di carattere europeistico. La fedeltà al popolo e alla cultura tedesca non gli impediscono di guardare all’Europa come luogo deputato al superamento di ogni forma di sciovinismo che scatena i bellicismi e che divide addirittura i fratelli tra di loro (come era avvenuto proprio nella sua famiglia). Questa “novità di formulazione” colpì particolarmente gli ascoltatori, che sentirono Guardini articolare in modo raffinato una relazione dialettica tra fedeltà al proprio popolo e apertura a un contesto superiore: «Non intendiamo parlare degli arrabbiati, – e Guardini lo dice nell’anno della terribile inflazione tedesca post-bellica – che per un risentimento si scostano dal proprio popolo e deviano in quella direzione. Vi sono però persone che hanno un senso dei legami che superano quelli di un solo popolo. Non è lecito scambiare con questo piano spirituale l’internazionalismo socialista. Noi vediamo l’Europa vivente, che è emersa, vive ed esercita il suo influsso in un certo numero di persone». E al movimento giovanile consegnava proprio questo impegno peculiare di riconoscere il «fatto spirituale dell’Europa» come proprio destino: «Chi è nello spirito della Jugendbewegung? È colui che interiormente è lacerato, è inquietato da questi problemi, che diventano per lui destino. Suo compito è quello di vedere il fatto (Faktum) Europa. La soluzione non si può trovare traendola da qualche genere di risentimento. Noi dobbiamo deciderci se agire demagogicamente o se vedere le cose in un’ottica di carattere essenziale e pensare e agire sulla base della responsabilità di fronte a questo nuovo sviluppo», ormai, ineludibile in direzione europea. Monito che purtroppo rimarrà in larga parte inascoltato in quegli anni che porteranno di lì a poco ai totalitarismi e frantumeranno ogni ipotesi di costruzione europea. Guardini aveva dimostrato una singolare lucidità profetica. Profeta purtroppo inascoltato (con rare eccezioni come gli studenti della “Rosa Bianca”) poiché la Germania andrà incontro alla sua deriva totalitaria e sciovinista.
In questo contesto, Guardini scrive il suo secondo testo, di certo il più drammatico. Lo scrive da professore senza cattedra e senza più magistero perché l’unica cattedra e l’unico magistero è quello del “grande” Führer e insieme Verführer (seduttore). Nell’isolamento del suo pensionamento forzato impostogli dal regime egli cerca di analizzare come tutto ciò sia potuto accadere e quale possa essere in futuro il fattore immunizzante. I saggi (L’Europa e Gesù Cristo; L’Europa e il cristianesimo) redatti negli anni bui del nazismo e della seconda guerra mondiale (una prima redazione è del ’35) rileggono il tutto cercando di saldare il discorso europeistico alla cristologia. Solo una prospettiva cristologica ed europeistica insieme, meglio le due realtà in inseparabile connessione, può e potrà eradicare la follia del “Blut und Boden”, un fantasma che può sempre risorgere. Pennellate efficaci, anche se stringate, sul rapporto vitale tra il tessuto profondo dell’anima europea e la cristologia portano Guardini a concludere che «l’Europa, ciò che è, lo è attraverso Cristo – una verità, che Novalis ha proclamato nel 1799 nel Frammento, sostenuto da forza profetica, La cristianità o l’Europa. […] Se l’Europa si staccasse totalmente da Cristo – allora, e nella misura in cui questo avvenisse, cesserebbe di essere».
Se l’Europa ha una genesi essenzialmente cristologica, questo si può riconoscere anche quando è avvenuta in larga parte l’apostasia dall’origine cristiana e scienza, cultura, politica, economia, filosofia europee vogliono realizzarsi fuori da quello spirito o addirittura in esplicita contraddizione con esso. Anche nelle manifestazioni negative o contraddittorie continua in realtà a operare la figura di Cristo. L’età dei totalitarismi ha tentato di innalzare il nuovo mito soteriologico del “salvatore terreno”, che avrebbe dovuto eliminare Cristo e la sua redenzione e fissare l’uomo in questo mondo. Se essi avessero definitivamente trionfato, sarebbe stata la fine dell’Europa, non tanto sul piano economico-politico, ma su quello della “figura umano-politica” che porta il nome Europa. Che cos’è allora, in ultima analisi, l’Europa? Guardini risponde in modo suggestivo con una pagina anche letterariamente accattivante, che è bene riprendere integralmente: «L’ Europa non è un complesso puramente geografico, né soltanto un gruppo di popoli, ma un’entelechia vivente, una figura spirituale operante. Si è sviluppata in una storia, che passa per quattromila anni e a cui non si può finora paragonare nessun’altra in ricchezza di personalità e di forze, in audacia d’azioni come in profondi movimenti di destini sperimentati, in ricchezza di opere prodotte come in pienezza di significato immessa in ordini di vita creati. […] Una cosa è però sicura […]: l’Europa diverrà cristiana, o non esisterà mai più. Può essere ricca o diventare povera; può avere un’industria altamente sviluppata o dover ritornare a livello rurale; può assumere questa o quella forma politica – in tutto ciò rimane se stessa, finché vive la sua forma fondamentale». Cristo è stato attivo per quasi due millenni nella più intima profondità dei popoli europei e ne ha plasmato una particolare sensibilità e finezza. L’essere di Cristo ha liberato il cuore all’uomo europeo, gli ha dato la capacità di vivere la storia e di esperire il destino, lo ha tratto fuori dall’antico stato servile e prigioniero nella natura e nel mondo e l’ha posto dinanzi a Dio nella sovrana libertà del redento. Una libertà e una conseguente responsabilità che dovrebbero essere immunizzanti dinanzi alla possibile catastrofe generata dalle sue opere.
Contro l’uomo europeo “cristi-forme” si muoveva il mito e l’istinto nazionalsocialista, che mirava a distruggere la dimensione europea per ottenere una massa informe di cui avrebbe potuto disporre a piacimento. Di qui l’odio mortale contro Cristo e contro tutto ciò che viene da Lui. Il mito del sangue come nuovo Mito del XX secolo (come recita il titolo della celebre e inquietante opera di Alfred Rosenberg, ideologo del nazismo) e l’annullamento di ogni dimensione spirituale come contrappeso alla semplice biologicità, e con ciò la fine dell’essenza europea. Il futuro dell’Europa è nella fedeltà a se stessa, nel suo essere non solo determinata nel profondo dalla figura di Cristo, ma – e ben più – nel suo essere come strutturata da tale figura cristica, se vuol conseguire la propria forma per eccellenza ed unica: «Se […] l’Europa deve esistere ancora in avvenire, se il mondo deve ancora aver bisogno dell’Europa, essa dovrà rimanere quella entità storica determinata dalla figura di Cristo, anzi, deve diventare, con una nuova serietà, ciò che essa è secondo la propria essenza. Se abbandona questo nucleo — ciò che ancora di essa rimane, non ha molto più da significare».
L’Europa è l’incontro fecondo di “opposti polari”
È invece più pacato il Guardini settantenne che, nel 1955, rivolgendosi ai colleghi dell’Università di Monaco che lo festeggiano, propone un intervento, sorta di bilancio, che salda insieme il tema dell’ Europa con quello della peculiarità del suo insegnamento di “visione cristiana del mondo» (Europa e Weltanschauung cristiana). In questo contributo il pensatore mette a tema la logica delle polarità: l’Europa per lui è nata nella polarità virtuosa delle sue due anime e tale dovrà essere anche l’Europa del futuro, incrocio fecondo di opposti polari. L’unità necessaria per ricomporre il proprio “io” frantumato dal duplice destino biografico, Guardini la trovò nell’essere europeo. In una sorta di bilancio, egli ricorda la feconda e liberante scoperta di quella “unita” e, insieme, mette in guardia sul rischio permanente di un’incomprensione tra Italia e Germania: «A questo punto mi è riuscita chiara per esserne personalmente impegnato quella realtà il cui nome è oggi sulla bocca di tutti, ma di cui allora quasi nessuno parlava: il fatto “Europa”. Lo riconobbi però, allora, come la base, unicamente sulla quale potessi esistere: familiarizzatomi intrinsecamente con la natura tedesca, ma attenendomi con fermezza fedele alla prima patria, ed entrambi gli atteggiamenti non come una mera giustapposizione, ma fusi come una cosa sola nella realtà “Europa”, che certo nasce da necessità storiche, ma anche dalla vita di coloro che ne fanno l’esperienza nella propria esistenza. Ancora qualcosa d’altro mi riuscì chiaro. Tra la Francia da un lato e la Germania dall’altro, nonostante tutte le sventurate difficoltà politiche, l’“Europa” era da lungo tempo in via di realizzazione, seppure più dall’Est all’Ovest che nella direzione opposta. Tra l’Italia e la Germania tuttavia sembrava che le cose stessero in modo diverso. Certo da sempre l’aspirazione dei Tedeschi verso il Sud era stata operante; tuttavia per lo più in un modo estetico-lirico, peculiarmente irreale, che si manteneva nell’àmbito dell’arte e del paesaggio, e invece non prendeva molta cognizione della realtà storico-politica. Alla relazione del Nord verso il Sud non ne corrispondeva nemmeno una analoga in senso contrario».
L’Europa vive dunque delle sue opposizioni polari, della sua dialettica Nord-Sud, Est-Ovest, della sua polarità geografica tra l’altezza delle Alpi e la pianura, del suo essere crocevia di diversità non incomponibili ma fecondamente intrecciabili: «Ancora sempre mi commuovo nel cuore […] quando sulla carta geografica vedo la sua immagine: la configurazione piccola e graziosa […] come fosse disposta dal cesello di un orafo tra i colossi Asia, America, Africa. La ricchezza delle sue forme, l’insinuarsi reciproco tra il mare e la terra, la molteplicità delle sue situazioni etniche dalle Alpi fino alla pianura più bassa – tutto questo appare come una preparazione al destarsi dello spirito più luminoso a opere grandi e audaci imprese».
L’ultimo apporto in ordine di tempo, il più ampio, raffinato e completo, è nato da una circostanza accidentale ma insieme dice il riconoscimento della grande originalità della sapienza europeistica di Guardini: il conferimento, nel 1962, del Premio Erasmo a Bruxelles. Il testo (Europa. Realtà e compito) pone una domanda urgente all’Europa, assegna ad essa una nuova missione. Se, forse, la stagione fanatica dell’autoaffermazione senza limiti dell’imperium nazionale è alle spalle e l’integrazione europea è ormai possibile, la nuova sfida è il dominio del nuovo imperium: quello della téchne. Se l’identità europea è nel suo radicamento cristiano, meglio ancora nel suo legarsi alla “figura Christi”, quale è dunque la missione dell’Europa, il suo compito (Aufgabe) specifico nel contesto mondiale? Sul piano numerico essa potrà non esser più competitiva né dal punto di vista demografico, né sul terreno economico o industriale o anche scientifico e artistico. C’è però una «prestazione assegnata in modo speciale all’Europa e che potrebbe essere certamente compiuta anche da altre parti del mondo, ma non con una tale, diciamo intrinseca, competenza?».
Il destino dell’Europa
La tesi di Guardini è riassumibile in questo: missione dell’Europa è il disciplinamento etico della potenza. Senza giungere ai toni apocalittici di Heidegger, qui Guardini vede la sfida etica e spirituale del futuro. Una sfida che compete proprio alla “vecchia Europa” e solo a essa, perché la sua “anzianità” può essere l’antidoto a ogni acritica ebbrezza e passiva fascinazione per il novum che può essere soltanto il veicolo di un inedito dominio. Utopia morale? Certo quest’Europa che può assumersi una tale impegnativa missione non è ancora all’orizzonte. Per essere tale non deve rimanere un semplice fatto economico o politico, ma deve diventare una “disposizione di spirito”, un comune sentire. Occorre fuoriuscire definitivamente dalla logica degli Stati nazionali chiusi su di sé. Il formarsi dell’Europa presuppone invece che tutte le nazioni che la compongono ripensino la loro storia e intendano il loro passato in relazione al costituirsi di questa grande ««forma vitale» che è appunto l’Europa. Occorre un’Europa compiutamente dialogica che superi l’egoismo nazionalistico degli Stati membri. Ciò potrà avvenire con l’esercizio fecondo dello «specchio», ovvero col vedere davvero se stessi nell’unico modo possibile, vale a dire nel vedersi con gli occhi dell’«altro»: «Chi vuole liberarsi dall’irretimento del proprio carattere etnico che si chiama “nazionalismo” deve imparare a conoscere persone di altra nazionalità e poi, in un momento adatto, domandarsi: come potrà apparire la nostra natura, il nostro comportamento reciproco, il nostro stile di vita agli occhi di un francese, di un inglese, di un italiano? Nel caso in cui tale sguardo gli riesca, ciò che appare è inquietante, ma anche questa inquietudine è salutare. In questo modo la persona impara a sentire come una parola pronunciata da un tedesco possa suonare agli orecchi di un francese, che effetto faccia a un inglese ciò che il tedesco definisce bravura, che sensazioni possano determinare in Italia il modo di vestire e il comportamento dei turisti tedeschi. Per il processo, di cui tanto si parla, di formazione di un’Europa veramente unita sarebbe utile che davvero molti eseguissero questo esercizio». Dalle nicchie autoreferenziali delle nazioni si esce solo costruendo «ponti», intessendo ovunque «relazioni trasversali non solo di carattere organizzativo, come accordi commerciali o forme di influenza politica, ma anche di natura umana. La storia di queste relazioni intermedie costituisce in realtà un importante capitolo della storia della nostra civiltà e cultura europee».
“Destino” dunque l’Europa, situazione destinale dell’immediato e del futuro per gli uomini che abitano il continente e che hanno finalmente trovato ragioni per unirsi e per non sbranarsi, ma insieme “compito” che fa sì che questo “stare-insieme” non sia solo mercantile e monetario ma abbia un obiettivo più alto. La lezione di Guardini è un prezioso viatico in tale direzione.
Note
(1) Per la ricostruzione biografica il testo di riferimento e di documentazione rimane quello di Hanna Barbara Gerl, Romano Guardini 1885-1968.Leben und Werk, Mainz, 1985, tr.it. di Benno Scharf, Romano Guardini: la vita e l’opera, Brescia, Morcelliana, 1988.
(2) Memore di questo fatto Guardini dedicherà al padre il primo volume dei suoi studi danteschi (Der Engel in Dantes Göttlicher Kömodie, Leipzig, Hegner, 1937) utilizzando eccezionalmente anche nell’edizione tedesca la lingua italiana: “Alla memoria di mio padre, dalle cui labbra fanciullo i primi versi di Dante colsi”.
(3) Cfr. Romano Guardini, Berichte über mein Leben. Autobiographische Aufzeichnungen, Aus dem Nachlass hrsg. von F. Messerschmid, Paderborn, Ferdinand Schöningh Verlag, Paderborn 1980, p. 58, tr.it. Diario. Appunti e testi dal 1942 al 1964, Brescia, Morcelliana, Brescia 1983, p.72: «Mio padre, che aveva trapiantato a Magonza l’attività di mio nonno, stimava molto la Germania , ma si sentiva tuttavia sempre ospite. Mia madre era ancora più radicale. Era nata nel Sud Tirolo [Guardini qui confonde Sud Tirolo con Trentino, anche se i Trentini all’epoca venivano effettivamente chiamati tirolesi] e aveva, sin da bambina, sviluppato in sé l’amore appassionato dell’ “irredenta” Italia. Era stata, certo, educata a Merano in un istituto tedesco; ma colà appunto si intensificò ancora di più questa disposizione d’animo. Quando tre anni dopo il suo matrimonio si trasferì con mio padre in Germania, non lo fece volentieri e perciò il suo rifiuto di tutto quanto era tedesco si fece sempre più netto. A Magonza essa, fatta eccezione per alcuni rapporti di cortesia inevitabili, non trattenne relazioni con nessuno”.
(4) Come afferma lo stesso Guardini a suo padre “sembrava molto difficile concepire il fatto che suo figlio primogenito potesse rinunciare alla cittadinanza del proprio Paese» (in Romano Gaurdini, Stationen und Rückblike, Würzburg, Werkbund, 1965, p.13).
(5) Cfr. Romano Guardini, Europa.Wirklichkeit und Aufgabe in Sorge um den Menschen, Bd.I, Würzburg, Werkbund, 1962, tr.it. di M. Paronetto Valier e di Albino Babolin, Europa-Realtà e Compito in Ansia per l’uomo, vol. I, Brescia, Morcelliana, 1970, pp.275-292, il riferimento a pp. 275-276:«Quando venimmo in Germania, io ero nella prima infanzia. In casa si parlava italiano; ma la lingua della scuola e della formazione spirituale fu il tedesco. Questo ebbe il sopravvento, e non poteva essere diversamente, come lingua, con la quale mi pervennero il sapere e la conoscenza della vita. Più tardi fu anche la lingua delle Università che frequentai e nelle quali cominciò la mia personale attività creativa spirituale.Da tutta questa situazione sorse un conflitto profondamente sentito, quando alla semplice bramosia di sapere sopravvenne il problema della professione.[…] Dal punto di vista intellettuale, io dovevo esercitare questa professione in Germania, poiché la mia formazione e la mia idea della vita erano tedesche; io pensavo in tedesco, giacché si pensa pure in una lingua. D’altra parte, però, era sempre viva la mia unione con l’Italia, che per i miei genitori era la patria e perciò la terra in cui, secondo il loro pensiero, doveva vivere e lavorare il loro figlio. […Oltretutto] i miei genitori erano italiani e patrioti appassionati».
(6) Dal resoconto del viaggio del medico personale che l’aveva accompagnato Franz Riedweg redatto nell’estate del 1983 e consegnato alla biografa Hanna Barbara Gerl. Cfr. Hanna Barbara Gerl, Romano Guardini: la vita e l’opera, cit., p. 424.
(7) Su questa vicenda cfr. Alfred Schüler, Romano Guardini. Eine Denkergestalt an der Zeitenwende, in “Archiv für mittelrheinische Kirchengeschichte” 21 (1969), p.134.
(8) In ordine cronologico: l’intervento riportato da J. Außem, Grüssau, in «Die Schildgenossen» 3, 5-6 (1922-1923), pp. 188-194, tr. it. in Europa. Compito e destino, a cura di S. Zucal, Morcelliana, Brescia 2004, pp. 63-74; i due paragrafi, il quinto, Europa und Jesus Christus, e il settimo, Europa und das Christentum, di Der Heilbringer in Mythos, Offenbarung und Politik. Eine theologisch-politische Besinnung, Deutsche Verlagsanstalt, Stuttgart 1946 (prima edizione ridotta con il titolo Der Heiland sulla rivista «Die Schildgenossen» 14, (1934-1935), pp. 97-116), tr. it, L’Europa e Gesù Cristo; L’Europa e il cristianesimo, in Il Salvatore nel mito, nella rivelazione e nella politica. Una riflessione politico-teologica, in Scritti politici, Opera Omnia a cura di M. Nicoletti, Morcelliana, Brescia 2005, vol. VI, pp. 293-345, i due paragrafi alle pp. 329-332 e 341-345; «Europa» und “Christliche Weltanschauung”. Aus der Dankrede bei der Feier meines siebzigsten Geburstags in der Philosophischen Fakultät der Universität München am 17. Febr. 1955, in Stationen und Rückblicke, Werkbund, Würzburg, 1965, pp. 11-22, tr. it., «Europa» e “Weltanschauung” cristiana. Dal discorso di ringraziamento in occasione della celebrazione del mio settantesimo compleanno presso la Facoltà di Filosofia dell’Università di Monaco il 17 febbraio 1955, in Scritti politici, cit., pp. 487-494; Europa. Wirklichkeit und Aufgabe (discorso per il conferimento del Praemium Erasmianum a Bruxelles il 28 aprile 1962), Werkbund, Würzburg 1962, tr . it., Europa. Realtà e compito in Scritti politici, cit., pp. 549-563; Wann ich Europäer bin, Bayerisch Rundkunf, München 1962 (Archiv. n. 62-10-196) in cui Guardini legge alla radio alcuni passaggi dei suoi testi europeistici; Europa kann keine Aufgabe versäumen, in «Europa» (Bad Reichenhall) 18(1967), pp. 52-53.
(9) J. Außem, Grüssau, cit., pp. 70-71.
(10) Ivi, p. 71.
(11) ivi, p. 72.
(12) Cfr. la tr. it. a cura di A. Reale, La cristianità o l’Europa, Bompiani, Milano 2002.
(13) Romano Guardini, L’Europa e Gesù Cristo, cit., p. 332.
(14) Ivi, pp. 342, 344.
(15)Der Mythus des XX. Jahrhunderts, Hoheneichen, München 1933.
(16) Romano Guardini, L’Europa e Gesù Cristo, cit., p. 345.
(17) Romano Guardini, “Europa” e “Weltanschauung” cristiana, cit., pp. 489-490.
(18) Ivi, p. 490.
(19) Romano Guardini, Europa. Realtà e compito, cit., p. 553.
(20) Romano Guardini, Ethik. Vorlesungen an der Universität München (1950-1962), Grünewald-Schöningh, Mainz Paderborn 1993, ed. it. a cura di M. Nicoletti e S. Zucal, Etica, Morcelliana, Brescia 2001, p. 261.
(21) Ivi, p. 529.
Condividi su Facebook


 Ci sono eventi, che pur nella loro retorica, nel loro mettere in scena riti e relative
Ci sono eventi, che pur nella loro retorica, nel loro mettere in scena riti e relative

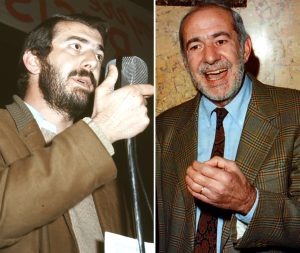


 Sono giorni drammatici per Gerusalemme. La decisione del Presidente americano, Donald Trump, di insediare l’ambasciata Usa a Gerusalemme sta creando caos e morte. Eppure, tra mille difficoltà, c’è ancora, in Israele, chi non si rassegna. E’ il caso del piccolo villaggio, situato nella biblica Valle di Ayalon, di Neve Shalom. Ne parliamo, in questa intervista, con il teologo Brunetto Salvarani.
Sono giorni drammatici per Gerusalemme. La decisione del Presidente americano, Donald Trump, di insediare l’ambasciata Usa a Gerusalemme sta creando caos e morte. Eppure, tra mille difficoltà, c’è ancora, in Israele, chi non si rassegna. E’ il caso del piccolo villaggio, situato nella biblica Valle di Ayalon, di Neve Shalom. Ne parliamo, in questa intervista, con il teologo Brunetto Salvarani.