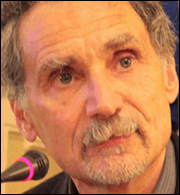Di seguito pubblichiamo il testo del Discorso, tenuto a Brescia lo scorso 4 settembre, in occasione del IV anniversario della scomparsa di Mino Martinazzoli durante la presentazione del libro “La legge e la coscienza”.
Di seguito pubblichiamo il testo del Discorso, tenuto a Brescia lo scorso 4 settembre, in occasione del IV anniversario della scomparsa di Mino Martinazzoli durante la presentazione del libro “La legge e la coscienza”.
Ricordare Mino Martinazzoli qui a Brescia è sempre una emozione. Farlo in occasione della presentazione di tre suoi importanti testi che rappresentano quello che giustamente Tino Bino definisce il suo “testamento spirituale”, lo è ancor di più.
Se è vero infatti che il suo testamento politico è racchiuso nei suoi interventi congressuali e in quelli parlamentari, non c’è dubbio che nei testi che presentiamo stasera è contenuta l’essenza del suo pensiero più profondo che trascende, comprendendola, la lezione di una vita spesa per le istituzioni.
Nella prefazione Tino Bino rivela poi due episodi dei suoi ultimi giorni, molto toccanti, che illuminano la sua morte. Una morte silenziosa, dignitosa, avvolta nel mistero e nella speranza, che ne rende ancora più grande la statura umana e fa venire alla mente un verso di uno dei suoi poeti più frequentati, Giorgio Caproni,
…l’uomo che se ne va
e non si volta: che sa
d’aver più conoscenze
ormai di là che di qua…(1)
Mino è sicuramente stato una delle personalità politiche più importanti e originali della nostra repubblica, il cui carisma era legato, oltrechè a una particolare intelligenza della storia, alla sua capacità di parlare cesellando le parole, levigandole, approfondendone il valore e il significato. Per lui, come per il suo maestro Aldo Moro, la parola era la politica, la responsabilità della politica e degli uomini.
Ne troviamo conferma anche in alcune mirabili pagine di questo volume a proposito del sostantivo “nicodemismo”, scavato in profondità sino a rilevare l’inganno di una immagine attribuita al grande rabbi come l’uomo della visita notturna a Gesù, anziché come l’uomo che si è fatto interpellare in profondità dall’ insegnamento del suo interlocutore sino a farlo proprio, seppure nella sofferenza del dubbio e della non completa comprensione.
Martinazzoli era un seduttore del pensiero.
Con la parola catturava l’intelligenza dei suoi ascoltatori e interlocutori, li trascinava lungo percorsi argomentativi anche impervi per costringerli all’approfondimento e al confronto; basterebbe ricordare il silenzio pensoso con cui erano seguiti i suoi interventi in parlamento. Per evocare una immagine classica, si può dire che nel suo discorso c’era l’ispirazione di Peitho e di Charis, le dee della persuasione e della grazia, poiché ciò che convince, come osserva Christian Meier, non sono semplicemente “le argomentazioni, ma qualcosa che va al di là di queste: la maniera di formularle, di esprimerle, il modo di presentarsi in pubblico, in definitiva la grazia, in cui spiritualità, spontaneità e consapevolezza, misura e libertà si uniscono “(2).
Di lui è stato detto che fosse un intellettuale prestato alla politica. Io preferisco dire, parafrasando ciò che scrisse Achille Ardigò a proposito di Giuseppe Dossetti (3), che “in lui c’era l’intellettuale nel politico e il politico nell’intellettuale”, per rispettare e rendere onore a una persona che – giustamente- ha sempre rifiutato l’idea di non essere pienamente politico.
Mi soffermerò su ciò che più mi ha colpito nei testi raccolti nel volume “La legge e la coscienza”, al di là dell’intrigante e sempre attuale conflitto fra la coscienza, la legge, il potere.
I tre testi sono apparentemente molto diversi, ma uniti dalla stessa ricerca sulle questioni di fondo che ha accompagnato Martinazzoli per tutta la sua esistenza e che io riduco a due: il senso della vita e il senso della democrazia.
Sì perché, pur essendo vero che almeno i primi due testi trattano di personaggi biblici, non è men vero che, dopo un’accurata esegesi del testo sacro, Martinazzoli lo contemporaneizza, lo fa parlare dei nostri problemi, senza forzature, quasi per un naturale sviluppo di un pensiero coltivato nella sua radice più lontana e portato a maturazione lungo il cammino della storia successiva. Qualcuno potrebbe sospettare in questa supposta piegatura del discorso un tentativo di riflesso autobiografico. Conoscendo Martinazzoli mi sento di negarlo: la sua sobrietà e il suo pudore glielo impedivano. E’ giusto invece cogliere un suo personale riconoscersi nella profondità e originalità di tali personaggi.
Martinazzoli non nasconde infatti la sua simpatia per Mosè, Nicodemo e Manzoni, proprio perché, dopo averne indagato in profondità lo spessore, vi ha trovato sofferenze spirituali e morali largamente condivise.
La solitudine innanzittutto.
“E’ un grande e solitario italiano – scrive infatti -il cittadino Alessandro Manzoni. Impolitico non perché ignorasse Macchiavelli ma perché non gli riusciva di comprendere un potere disgiunto dalla ragione morale”.
Così come dice di sentire il dovere di “pronunciare l’elogio di Nicodemo, della sua discrezione, persino dei suoi dubbi e della sua ambiguità”.
Ma è soprattutto attorno alla figura di Mosè che io colgo la suggestione, che molto lo intriga, del peso e della sofferenza per la sua destinazione profetica. Perché, viene da chiedersi, l’aspetto tragico del servizio della parola, della profezia, viene sottolineato nella figura di Mosè piuttosto che in quella di altri grandi profeti, come Abramo ad esempio? Andrè Neher, il grande rabbino francese, dà questa risposta: “Perché il profeta secondo Abramo è un individuo, il profeta secondo Mosè è inserito nella storia di un popolo. Abramo è il profeta da solo, è da lui che nasce il popolo; la missione di Mosè, invece, lo introduce nell’ambiente di una comunità umana… E allora necessariamente si crea il conflitto, la lotta concreta, il dialogo con gli uomini. Ed è un dialogo molto difficile e molto differente dal semplice dialogo con Dio, perché è molto più sottomesso al rischio dello scacco” (4).
Profeta del popolo e con il suo popolo, dunque.
Potremmo cogliere proprio in ciò la ragione della simpatia di Martinazzoli il quale, non a caso, pur scegliendo, per una sua postura caratteriale e in parte soffrendone, una certa solitudine, mai ha considerato la possibilità di un’esperienza umana e politica disgiunta da quella di una comunità, di un popolo. Il popolarismo per lui era esattamente questo: la scelta di camminare fra il popolo e insieme al popolo, costasse pure – e Dio sa quanto gli costò – sofferenze, incomprensioni e conflitti.
Un’altra suggestione che attraversa i tre testi è quella della rinascita.
Nei suoi discorsi politici Martinazzoli parlava spesso dell’esigenza di un ricominciamento, che è una declinazione meno impegnativa e più storica, anche se non rinunciava all’idea che a questo nostro tempo fosse necessaria una vera e profonda conversione culturale ed etica, diciamo pure antropologica. Sul testo del vangelo di Giovanni a proposito di Nicodemo, Martinazzoli indugia molto sulla risposta che Gesù dà alla domanda del suo interlocutore (“Come può un uomo nascere quando è vecchio? Può forse entrare una seconda volta nel grembo di sua madre e rinascere?): “Se uno non nasce da acqua e da Spirito, non può entrare nel regno di Dio…Il vento soffia dove vuole e ne senti la voce, ma non sai di dove viene e dove va: così è di chiunque nato dallo Spirito”. Mistero. Fede. Dubbi. Fascino. E proprio su questi interrogativi di Nicodemo, solo due giorni fa su Avvenire, scrivendo del Giubileo e delle ultime sorprendenti e profetiche prescrizioni a suo riguardo di papa Francesco, Pierangelo Sequeri chiosa: “Si può rinascere dall’impossibile. Non è la perfezione che cambia la storia: sarebbe già affondata. E’ la conversione che la cambia. La cambia individualmente e anche collettivamente” (5).
Per “rinascere di nuovo, si tratta effettivamente di tornare nel grembo: in quello di Dio, però, e non in quello della propria madre “(6).
Tornando al Mosè, vorrei brevemente soffermarmi sul percorso singolarissimo impresso da Martinazzoli ai testi del Pentateuco, per sospingerli nei meandri più intriganti del dibattito aperto, oggi ormai in tutto il mondo potremmo dire, sulla crisi della democrazia. Se la sua intenzione fosse stata quella di fare una lettura politica del testo biblico avrebbe potuto soffermarsi forse sui tanti spunti offerti dai dialoghi di Mosè con il faraone alla ricerca, come ha fatto in modo memorabile p. Carlo M. Martini (7), del loro insospettato valore politico, ma soprattutto alla ricerca del “faraone che è in noi” e del “Mosè che è in noi”.
E invece no, Martinazzoli rumina sino a sminuzzarlo il testo, senza volere distaccarsene, facendosi trascinare quasi senza intenzione: dalle tavole alla legge, dalla legge alla libertà, dalla libertà alla democrazia, partendo dalle “profondità minerali della storia” e, camminando attraverso i classici greci, su su sino a Heghel e Kafka, per arrivare a cogliere il definitivo salto di qualità del modello democratico moderno quando esso ha potuto configurarsi come “patto fra eguali”. Le tavole di Mosè evidentemente centrano con questa eguaglianza. “Giunti a un’epoca della storia – scrive – che dichiara come diritto la dignità di ogni creatura, non dovremmo indietreggiare”. (E invece proprio le cronache di questo tempo che ci parlano dei flussi nuovamente biblici dei migranti, ci descrivono un maledetto indiettreggiamento che mette a dura prova la nostra capacità di “restare umani”). Martinazzoli ha ben presente, lo ha sempre avuto sin da quando lo ha scoperto, che “la dolorosa fondazione del fondamento” di quel patto fra eguali ha portato l’”inaudita potenza speculativa” di Antonio Rosmini (come l’ha definita Giuseppe Capograssi) a individuare nella persona la ricapitolazione di tutto, di ogni diritto, essendolo essa stessa: “non la persona ha il diritto, ma la persona è il diritto”.
In questo principio rosminiano è racchiuso tutto il sistema di pensiero di Martinazzoli, dell’uomo, del politico e dello statista.
Alcune altre figure, non moltissime per la verità, possono essere indicate come i suoi punti di riferimento: Sturzo, De Gasperi, Moro, Tocqueville, Montini e Manzoni appunto. Ma questo punto solido, questa pietra angolare su cui appoggia buona parte dell’antropologia e della filosofia rosminiana lo ha veramente conquistato.
Giuseppe Capograssi è il filosofo del diritto che, insieme a Leopoldo Elia costituzionalista e Mino Martinazzoli uomo più dedicato alla politica, ha contribuito a sviluppare il personalismo rosminiano.
Capograssi in particolare, pensatore molto stimato da Mino, ne ha fatto una sintesi assunta anche dagli altri due quando ha definito la persona come un’individualità infinita che ha bisogno del rapporto con gli altri, attraverso l’immersione nella storia, per raggiungere la sua pienezza; ma , nello stesso tempo, “proprio perché la persona è il diritto, la storia è storia di legislazioni, di istituzioni, di ordinamenti e di coazioni, l’affermazione positiva e volontaria che essa fa di se stessa nella individualità originale ed insostituibile della sua vita in mezzo al concreto” (8)
Queste considerazioni ci hanno portato al largo se ripensiamo i punti da cui siamo partiti.
Il viaggio di Mosè a un certo punto finisce, quantunque incompiuto.
Il prudente capo ebreo Nicodemo si trova imprevedibilmente a raccogliere il corpo crocefisso di Gesù.
Manzoni si trova solo a contemplare impotente le ragioni di una ingiustizia inopinatamente consentita dal Signore della storia.
Tre figure che costringono a riflettere sull’imperscrutabilità delle ragioni e delle circostanze che sottendono i diversi destini personali.
A Martinazzoli è toccato quello di una leadership politica non cercata ma non rifiutata, accompagnata da una incolpevole solitudine che non è mai degenerata in isolamento, non foss’altro per le sue frequentazioni intellettuali, di uomini e autori, cui è stato chiesto di porre i sigilli sulla fine di una esperienza politica in cui più di altri aveva creduto. Lo ha fatto conservandone l’essenza, anzi risalendo alle radici primigenie per trovare quelle gocce di linfa generativa necessarie a chi, venendo dopo di lui, avesse avuto l’ambizione se non di una rinascita almeno di un ricominciamento o di una reinvenzione.
Per arrivare poi alla conclusione, valida per lui e per noi tutti, che “Amare il proprio destino, assumerne tutto lo spazio di libertà e di responsabilità: questa è forse, la ventura delle venture”.
NOTE
1) Giorgio Caproni, “Tutte le poesie”, senza titolo, Garzanti ed.
2) Christian Meier, “Politica e Grazia”, Il Mulino
3) “Di Dossetti si può dire che c’era il monaco nel politico, e il politico nel monaco”
4) André Neher, “L’essenza del profetismo”, Marietti ed.
5) Pierangelo Sequeri, “La Chiesa sfida anche se stessa”, Avvenire, 2 settembre 2015
6) Pino di Luccio s.j., “Qoèlet, Nicodemo e la vita eterna”, La Civiltà Cattolica, n. 3958 del 30 maggio 2015
7) Carlo Maria Martini, “Vita di Mosè”, Borla ed.
8) “Il diritto secondo Rosmini”, citato in Giorgio Campanini, “Giuseppe Capograssi, nuove prospettive del personalismo”, Studium ed.
dal sito: www.pierluigicastagnetti.it
Condividi su Facebook
 Lo consigliamo a docenti e alunni. Vale la pena di leggerlo a scuola, offre molti spunti di riflessione sia per il docente e che per l’alunno.
Lo consigliamo a docenti e alunni. Vale la pena di leggerlo a scuola, offre molti spunti di riflessione sia per il docente e che per l’alunno.