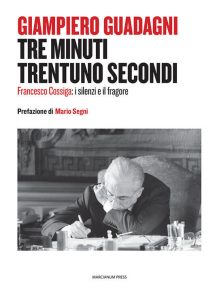A fine luglio del 2009, Julian Assange e la sua organizzazione contattarono Stefania Maurizi per la prima volta: avevano un documento sull’Italia e volevano l’aiuto di un giornalista per verificarne l’autenticità e l’interesse pubblico. Da quel momento hanno lavorato fianco a fianco, loro per WikiLeaks, Stefania per il suo giornale – L’Espresso e La Repubblica prima, oggi Il Fatto Quotidiano – alla pubblicazione di un’infinità di documenti segreti.
A fine luglio del 2009, Julian Assange e la sua organizzazione contattarono Stefania Maurizi per la prima volta: avevano un documento sull’Italia e volevano l’aiuto di un giornalista per verificarne l’autenticità e l’interesse pubblico. Da quel momento hanno lavorato fianco a fianco, loro per WikiLeaks, Stefania per il suo giornale – L’Espresso e La Repubblica prima, oggi Il Fatto Quotidiano – alla pubblicazione di un’infinità di documenti segreti.
Dopo il terremoto WikiLeaks il prezzo da pagare per il giornalista e hacker è stato altissimo: Assange non ha mai più conosciuto la libertà. Chiuso in una cella di una delle più famigerate prigioni di massima sicurezza del Regno Unito, la Belmarsh Prison di Londra, lotta contro le più potenti istituzioni della Terra che da oltre un decennio lo vogliono fare a pezzi. Per il potere meno visibile e più pervasivo, Julian Assange è tra i peggiori criminali che esistano e, come tale, va punito nella maniera più brutale. Addirittura c’è chi chiede la pena di morte, per aver violato una legge del 1917, l’Espionage Act, che vietava la diffusione di notizie riservate durante la Prima guerra mondiale. Il processo attualmente in corso a Londra (e che vede la partecipazione della stessa Maurizi nella veste di testimone) è accompagnato da una grande mobilitazione dell’opinione pubblica: in sua difesa si sono pronunciati alcuni dei più importanti giornalisti d’inchiesta internazionali, svariate organizzazioni per i diritti umani, lo stesso Consiglio d’Europa e l’Onu che hanno espresso preoccupazione e sdegno richiamando il reato di tortura. Tutta la storia di Assange, dall’esplosione di WikiLeaks in avanti, è un giallo incredibile che questo libro racconta con lo stile avvincente di un romanzo, uscito per Chiarelettere due settimane prima del ventesimo anniversario dell’attentato alle Torri Gemelle di New York, evento a proposito del quale Assange portò alla luce una serie di documenti scottanti tramite Wikileaks.
Una vicenda lunga 10 anni che è un forte atto di denuncia nei confronti del potere segreto che governa le nostre democrazie. In questa intervista approfondiamo alcuni aspetti del libro. Stefania Maurizi scrive per Il Fatto Quotidiano è una delle giornaliste più vicine a Julian Assange da sempre: in Italia è stata la persona che ha diffuso i documenti di WikiLeaks. Partecipa come testimone al processo in corso a Londra per l’estradizione di Assange negli Stati Uniti. È stata anche lei vittima dell’attività di spionaggio presumibilmente per conto dei servizi segreti americani all’interno dell’ambasciata dell’Ecuador che ha ospitato per anni Assange accogliendo la sua richiesta di asilo politico.
Stefania, il tuo libro è davvero un libro forte. È un atto di accusa ben documentato al “potere segreto” (ovvero a quelle entità statuali che si sottraggono al controllo democratico). Partiamo dalla fondazione di Wikileaks. Come nasce e qual è la sua “filosofia”?
“Il Potere Segreto, che dà il titolo al mio libro e che ricostruisco con i documenti segreti rivelati da Wikileaks, è qualcosa di molto preciso: è il potere dello Stato schermato dal segreto di Stato, usato non per proteggere la sicurezza dei cittadini, ma per nascondere la criminalità di Stato ai più alti livelli e garantire l’impunità agli uomini delle istituzioni che commettono questi crimini. Quando parlo di criminalità di Stato ai più alti livelli intendo reati eccezionalmente gravi, come la falsificazione dell’intelligence che permise all’amministrazione Bush di trascinare gli Stati Uniti in una guerra devastante come quella dell’Iraq, in cui il nostro Paese ha avuto un ruolo sciagurato, perché ha concesso agli Stati Uniti tutto quello che Washington ha chiesto: basi, aeroporti, ferrovie per spostare truppe e armamenti, come rivelano i cablo della diplomazia USA pubblicati da WikiLeaks. E anche crimini tipo l’extraordinary rendition di Abu Omar: un uomo rapito a mezzogiorno a Milano, come fosse nel Cile di Pinochet. I nostri bravissimi magistrati, Armando Spataro e Ferdinando Pomarici, riuscirono a individuare i responsabili, 26 cittadini americani, quasi tutti agenti della Cia, riuscirono a ottenere per loro condanne definitive, eppure nessuno dei 26 ha fatto un solo giorno di galera: impunità assoluta. Mentre nei regimi, questo Potere Segreto è percepito anche dal cittadino comune, che si sente sotto controllo, oppresso da esso, nelle nostre democrazie, questo potere non è percepito dalla gente ordinaria. Nelle democrazie, i cittadini si interessano soprattutto al potere visibile, quello che decide delle loro pensioni, della loro sanità, del loro lavoro, e non pensano che questo Potere Segreto sia rilevante per le loro vite di persone comuni. E invece non è così. E’ un potere che decide eccome le loro vite e su cui loro non hanno alcun controllo, perché non hanno accesso alle informazioni su come opera, in quanto sono blindate dal segreto di Stato. Ma per la prima volta nella Storia, WikiLeaks ha aperto un profondo squarcio in questo Potere Segreto e ha permesso a miliardi di cittadini di tutto il mondo di avere accesso sistematico e senza restrizioni a milioni di documenti coperti da segreto che rivelano come opera. E’ per questo che Julian Assange ha fondato WikiLeaks il 4 ottobre 2006: è una creatura frutto della sua visione, anche se chiaramente non ha fatto tutto da solo, gli altri giornalisti di WikiLeaks hanno grandemente contribuito a renderlo possibile, e così avvocati, tecnici che hanno dato il loro contributo. Ed è per questo lavoro che dal 2010 in poi, quando ha rivelato i documenti segreti del governo americano, che Julian Assange non ha più conosciuto la libertà e rischia di finire per sempre in prigione negli Stati Uniti. La sua vita è appesa a un filo”.
Perché bisogna ritenere credibile Wikileaks? A quali criteri giornalistici risponde?
“E’ credibile perché, come tutte le organizzazioni giornalistiche, prima di pubblicare i documenti li verifica con un processo che, almeno fin dal 2010 e nella maggior parte dei casi, è stato portato avanti con noi media partner, ovvero noi giornalisti di media tradizionali che abbiamo accesso ai file in modo esclusivo per un periodo limitato. Noi facciamo le nostre verifiche sull’autenticità dei documenti, in parallelo a quelle fatte da WikiLeaks, e, una volta stabilito che sono autentici, noi pubblichiamo le nostre inchieste e i nostri articoli sui nostri giornali, mentre WikiLeaks pubblica i documenti originali, in modo che chiunque possa leggerli. Rendendoli accessibili a chiunque, WikiLeaks fa una cruciale opera di democratizzazione dell’informazione e della conoscenza, perché permette a chiunque di usarli per capire la realtà e anche per incidere su di essa. Per esempio, un cittadino tedesco di nome Khaled el-Masri, che è stato una vittima innocente delle extraordinary rendition della Cia ed è stato torturato e stuprato, ha potuto non solo scoprire informazioni cruciali sul suo caso nei cablo della diplomazia Usa rivelati da WikiLeaks – informazioni che non avrebbe potuto ottenere in nessun altro modo, perché coperte da segreto – ma ha anche potuto usare i cablo per cercare giustizia alla Corte Europea dei diritti dell’Uomo. E anche un gruppo di cittadini che lottano per tornare a vivere nel loro arcipelago, le Chagos Islands – un paradiso a sud delle isole Maldive, che tra gli anni ’60 e ’70 il Regno Unito ha evacuato, costringendo gli abitanti all’esilio per trasformarle in una base militare degli Stati Uniti – hanno trovato un aiuto cruciale nei cablo per la loro lotta davanti alla giustizia britannica. Infine, rendendo i documenti accessibili a tutti, WikiLeaks contribuisce a dare potere ai lettori, riducendo l’asimmetria tra i giornalisti, che hanno accesso alle fonti primarie delle informazioni, e i lettori che invece non ce l’hanno. Quando un lettore ha accesso alle fonti primarie, può usarle per approfondire e anche per verificare come il giornalista ha lavorato sui materiali: ha nascosto qualcosa? Ha manipolato i documenti oppure ha fatto un buon servizio alla verità?”
Parliamo del suo leader, Julian Assange. Il capitolo in cui ricostruisci la sua personalità lo intitoli “Cypherpunk”. Perché?
“Non parlerei di ‘leader’ di WikiLeaks, ma di fondatore e direttore, come per tutte le altre organizzazioni giornalistiche. Oggi il direttore di WikiLeaks è il giornalista investigativo islandese Kristinn Hrafnsson, e Julian Assange rimane il fondatore, ma ovviamente non può dirigere l’organizzazione, essendo in prigione. Julian Assange è un Cypherpunk: da giovanissimo, negli anni ’90, era un assiduo collaboratore di questa mailing list, che erano appunto i Cypherpunk, un formidabile collettivo di appassionati di privacy e crittografia, le cui idee hanno contribuito enormemente a trasformare la realtà. I Cypherpunk erano visionari e libertari. Includevano matematici come Eric Hughes dell’università della California, Berkeley, che aveva scritto il Manifesto del Cypherpunk e anche il fisico Timothy May, che aveva lavorato per il gigante dei microprocessori Intel e ne aveva tratto profitti così ingenti che, a trentaquattro anni, si era potuto permettere di andare in pensione, dopo aver calcolato che non avrebbe dovuto lavorare mai più nella sua vita. Politicamente avevano idee molto diverse tra loro, ma erano accomunati da un profondissimo interesse: ragionare sull’impatto della sorveglianza e sviluppare strumenti a difesa della privacy e dell’anonimato, e sistemi di pagamento anonimi per difendere l’individuo dal controllo assoluto dello Stato. Erano avanti di decenni, ed è grazie alle loro riflessioni e ossessioni che sono emersi strumenti che hanno cambiato il mondo, come WikiLeaks, nel caso di Julian Assange, o come l’uso di massa della crittografia, in chat come Signal, e anche le criptovalute, come il bitcoin. Senza Bitcoin, difficilmente WikiLeaks sarebbe sopravvissuta al blocco delle donazioni bancarie. Nel 2010, infatti, appena iniziò a pubblicare i cablo della diplomazia, i giganti del credito, da Visa e Mastercard a PayPal e Bank of America, tagliarono dal giorno alla notte la possibilità di donare a WikiLeaks, che vive esclusivamente delle donazioni dei suoi sostenitori. Senza uno straccio di provvedimento giudiziario alla base di questo provvedimento, l’organizzazione si ritrovò con i rubinetti dei soldi completamente chiusi. Immagini se dalla sera alla mattina, i giganti del credito avessero tagliato i conti del New York Times o del Guardian: sarebbe stato uno scandalo internazionale e tutti i media del mondo avrebbero espresso solidarietà. Ma con WikiLeaks questo non è successo”.
Per alcuni, anche per qualche giornalista, Assange è una persona “controversa”. Tu contesti radicalmente questa affermazione. Perché?
“Personalmente, credo che l’osservazione delle persone sul lungo periodo sia uno dei pochissimi criteri per capire con chi si ha a che fare. Come giornalista, ho conosciuto da vicino e per oltre 10 anni il fondatore di WikiLeaks, penso quindi di avere molte informazioni fattuali per capire che tipo di essere umano è. Non dico di aver condiviso qualunque cosa abbia detto o fatto da quando lo conosco e sono la prima a dire che è un individuo complicato, ma è profondamente diverso da come viene dipinto dai media. Julian Assange è una persona di grandissima intelligenza, uno che, come scrisse il settimanale tedesco Der Spiegel, poteva fondare la sua azienda di software nella Silicon Valley e fare i soldi, e invece ha usato il suo talento intellettuale per rivelare i crimini di guerra e le torture in Afghanistan e in Iraq, pagando un prezzo mostruosamente alto a livello personale, perché da quel momento in poi non ha più conosciuto la libertà. Sono 11 anni che non può camminare per la strada da uomo libero, godersi un po’ di sole, correre, sdraiarsi sull’erba di un prato, e rischia di non poterlo fare mai più, perché sul suo capo pende una condanna a 175 anni di galera esclusivamente per aver rivelato quei crimini. E’ anche una persona che sa essere dolce, affettuosa e molto divertente: Julian Assange non è affatto il personaggio truce e con quell’aura di mistero e minaccia, che gli viene spesso attribuita. E’ divertente, ha un umorismo tagliente. Come scrivo nel mio libro, non sono l’unica a descriverlo così. Anche altri colleghi che lo conoscono bene, la pensano come me. Se l’opinione pubblica ne ha un’idea completamente distorta è perché lui ha certamente difficoltà nelle interazioni sociali, molto probabilmente collegate alla sua sindrome di Asperger, come racconto nel libro, ma il fattore che più ha contribuito a deformare la percezione dell’opinione pubblica è stata la lunga campagna di demonizzazione del personaggio. Invece di sottoporre a un minuzioso scrutinio agenzie potentissime, come il Pentagono e la Cia, responsabili di atroci violazioni dei diritti umani, tipo la distruzione dell’Iraq o le torture nelle prigioni segrete e a Guantanamo, tutta la forza critica dei media si è concentrata sulla persona di Julian Assange. Dal 2010 in poi è stato accusato di tutto, in particolare di aver messo a rischio vite umane, quando invece 11 anni dopo la pubblicazione dei documenti, non risulta un solo morto, una sola persona ferita o imprigionata a causa di quelle rivelazioni. Dieci anni di demonizzazione avrebbero alienato la simpatia e il sostegno dell’opinione pubblica anche a un santo. Di fatto hanno completamente alienato l’empatia dell’opinione pubblica verso Julian Assange. E non dimentichiamoci che questa empatia è l’unico scudo che può proteggerlo, visto che non ha alcuna speranza di opporsi alla sua distruzione da parte delle autorità inglesi e americane confidando nelle corti del Regno Unito o degli Stati Uniti”.
Ritorneremo sulla figura di Assange.
Parliamo delle rivelazioni clamorose di Wikileaks. Quali sono state le più importanti?
“Il video Collateral Murder, in cui si vede un elicottero americano Apache sparare su civili inermi a Baghdad, mentre l’equipaggio ride di gran gusto, è uno dei documenti che rimarranno per sempre. Così come i documenti sulle guerre in Afghanistan e in Iraq, che hanno permesso di guardare alla realtà di quelle due guerre, al di là della micidiale macchina della propaganda bellica. I cablo della diplomazia americana rimangono di eccezionale importanza: 11 anni dopo la loro pubblicazione, ci permettono ancora di capire il mondo. In questi ultimi 11 anni, non ho mai smesso di consultarli. Quando è emerso che l’Italia armerà i suoi droni militari, la prima cosa che ho fatto è stata quella di andare a consultare i cablo per avere informazioni fattuali sulla guerra dei droni. E così le schede dei detenuti di Guantanamo. E’ per questi documenti che Julian Assange rischia 175 anni di galera. Ma in aggiunta a questi file segreti del governo americano, ci sono altri documenti di grande importanza. Le email dell’azienda italian Hacking Team, per esempio, ci hanno permesso di entrare nel mondo oscuro delle aziende private del cyberspionaggio e dei loro affari con le dittature e i servizi segreti di regimi famigerati per le loro violazioni dei diritti umani. Quando l’opinionista del Washington Post, Jamal Khashoggi è stato ucciso barbaramente dalle autorità saudite, il Washington Post ha consultato le email della Hacking Team, pubblicate da WikiLeaks anni prima, alla ricerca di informazioni sulle cyberarmi che i sauditi avevano acquistato da varie aziende, tra cui appunto l’italiana Hacking Team, per sorvegliare i dissidenti. Le rivelazioni sullo spionaggio della NSA contro i leader mondiali, tra cui Berlusconi e i suoi più stretti alleati, sono molto importanti, come anche importantissime le rivelazioni sulle cyberarmi della Cia, perché permettono per la prima volta di scoprire l’arsenale di armi fatte di software – da qui il nome ‘cyberarmi’ – con cui l’agenzia penetra nei computer, nei telefoni, nei dispositivi elettronici, nelle televisioni smart, per sorvegliare un obiettivo e rubare informazioni. Si tratta di armamenti invisibili, proprio perché fatti di software, la cui proliferazione crea rischi immensi, anche perché è molto più difficile da monitorare, in quanto queste armi non si vedono, non vengono caricate su navi o treni nei porti”.
Approfondiamo la vicenda dell’Afghanistan. Cosa hanno svelato i documenti pubblicati da Wikileaks di quella missione occidentale?
“I documenti sulla guerra in Afghanistan, che WikiLeaks rivelò nel luglio del 2010, furono un grande colpo giornalistico: permettevano di aprire quella che il New York Times chiamò ‘una straordinaria finestra sul conflitto’. Si trattava di 91.910 report segreti, compilati dai soldati americani sul campo tra il gennaio del 2004 e il dicembre del 2009. Per la prima volta dal lontano 1971, quando Daniel Ellsberg aveva rivelato i 7mila documenti top secret sulla guerra in Vietnam, passati alla storia come Pentagon Papers, era possibile avere decine di migliaia di documenti segreti su una guerra, non 30-40 anni dopo la sua fine – quando ormai interessavano giusto agli storici di professione – ma proprio mentre i combattimenti erano in corso. La documentazione permetteva di ricostruire quanto poco avessero ottenuto le truppe americane e quelle della coalizione internazionale dopo 9 anni di guerra. Per esempio, nella regione di Herat, controllata dagli italiani, dopo quasi un decennio di addestramento condotto dai nostri soldati, gli americani scrivevano nei loro report che la polizia afghana abbandonava la divisa per arruolarsi nei talebani, perché gli agenti non venivano pagati e non era chiaro dove andassero a finire i soldi degli stipendi. Addittura arrotondavano con i sequestri di persona, mettendosi d’accordo con i rapitori. I denari stanziati per costruire infrastrutture decisive, come le strade, per lo sviluppo di un paese i cui abitanti, non dimentichiamolo, hanno un’aspettativa di vita media di circa 54 anni, sparivano nel nulla. Anche la guerra segreta, condotta con unità speciali, come la Task Force 373 – di cui non si era mai saputo niente prima delle rivelazioni di WikiLeaks – non era esattamente un successo: a volte, la Task Force non aveva letteralmente idea di chi ammazzava e quindi colpiva civili innocenti o perfino le stesse forze afghane. Queste stragi creavano un forte risentimento nella popolazione locale contro le truppe occidentali. I documenti sulla guerra in Afghanistan fotografavano già il fallimento che 11 anni dopo abbiamo visto tutti: 20 anni di una guerra senza senso, dove alla fine l’esercito più potente del mondo, il più tecnologicamente avanzato, è stato sconfitto da una forza medievale come i talebani”.
Qual è stata la ricaduta, in Italia, delle rivelazioni di Wikileaks? Negli Usa lo sappiamo, nel nostro paese?
“Ricordo come fosse ieri quando nell’ottobre del 2010 pubblicai, con quello che era allora il mio caporedattore a l’Espresso, Gianluca Di Feo, le rivelazioni sull’Italia, che emergevano dai 91.910 file segreti di WikiLeaks: gli Afghan War Logs. Mentre la retorica nazionale si fermava alla storia dei ‘nostri ragazzi’ che andavano in Afghanistan per aiutare le popolazioni locali, i file raccontavano un’altra storia: la guerra vera e propria che, dal 2004 al 2009, i soldati italiani combattevano ogni giorno con centinaia di guerriglieri uccisi, raid dal cielo, i micidiali improvised explosive devices (IED), le imboscate, i kamikaze, decine di soldati feriti, chi in modo grave e chi meno, di cui in Italia non si era mai saputo nulla. Con il mio caporedattore facemmo un grande lavoro sui documenti, leggendone migliaia, e pubblicando una lunga inchiesta su quello che era allora il mio giornale, l’Espresso. Come scrivo nel mio libro, con quell’inchiesta avevamo fornito per la prima volta dati e informazioni fattuali alla politica, ai media e all’opinione pubblica italiana, che potevano finalmente guardare a quel conflitto al di là della nebbia della guerra e della propaganda dei ‘ nostri ragazzi’. Ma non ci fu nessun dibattito: il silenzio della politica e l’incapacità o la mancanza di volontà dei media italiani di fare squadra, contribuendo a esercitare pressione sulle istituzioni, furono patetici. Con i documenti successivi, come per esempio i cablo, le reazioni non mancarono, ma tutto è sempre stato gestito all’insegna del troncare e sopire. Per esempio, nel caso delle rivelazioni dello spionaggio della NSA contro Berlusconi e i suoi più stretti collaboratori, che pubblicai in partnership con WikiLeaks nel febbraio 2016, la procura di Roma aprì un’inchiesta, io ero in attesa di essere interrogata come persona informata dei fatti, visto che avevo rivelato quelle intercettazioni insieme a WikiLeaks. Beh, ancora aspetto la procura di Roma: nessuno mi ha mai interrogato e l’indagine non è mai pervenuta… Il nostro Paese è diventato la piattaforma di lancio delle guerre USA – dall’Iraq fino alla guerra segreta dei droni – nella complicità della politica e nel silenzio complice o comunque colpevole dei mezzi di informazione”.
Torniamo ad Assange. Tu lo conosci bene, ti chiedo cosa ti ha insegnato, perdonami il verbo, sul piano giornalistico?
“Mi ha insegnato moltissimo. Mi ha insegnato a usare la crittografia per proteggere le mie fonti giornalistiche. Poi, è grazie a lui e ai giornalisti di WikiLeaks che ho acquisito una solida capacità di verificare l’autenticità di documenti segreti di cui non conoscevo con certezza la provenienza e su cui non potevo andare in giro a fare domande, perché quando un giornalista ha in mano file segreti della Cia o della Nsa o del Pentagono, non può andare a chiedere a questo o a quello se ti dà una mano a scoprire se la documentazione è vera o falsa. Se il giornalista lo fa, si espone a un grave rischio personale ed espone le sue fonti a enormi rischi. Infine, Julian Assange mi ha dato la lezione più importante: la battaglia contro il segreto può essere vinta. Prima di WikiLeaks, per me era inconcepibile pensare di riuscire a esporre sistematicamente i crimini di quello che io chiamo il Potere Segreto. Sì, ero consapevole di quanto aveva fatto Daniel Ellsberg con i Pentagon Papers, ma mi appariva un episodio isolato, di difficile riproducibilità. E invece Julian Assange e WikiLeaks mi hanno fatto capire che l’impossibile era diventato possibile. Se guardo al nostro Paese alla luce di questa lezione, io sono convinta che in Italia le istituzioni sono riuscite a coprire gli stragisti e a nascondere la verità sui cosiddetti ‘misteri italiani’ per quasi 60 anni, ma le cose potrebbero cambiare profondamente in futuro. WikiLeaks ci ha fatto capire che né il Pentagono, né la Cia, né la NSA riescono più ad avere il controllo totale dei loro sporchi segreti, tanto da aver perso il controllo di centinaia di migliaia di file classificati, pubblicati da WikiLeaks e da cui emergono crimini di guerra, torture e gravissime violazioni dei diritti umani. Credo che sarà solo questione di tempo e anche gli apparati dello Stato italiano subiranno la stessa sorte e finalmente potremo scoprire come agiscono quando sono completamente al riparo dagli sguardi dell’opinione pubblica e dei media. Non esiste democrazia se i giornalisti non hanno la libertà di rivelare gli angoli più oscuri del potere e se i cittadini non hanno la possibilità di scoprirli, grazie ai giornalisti e alle loro fonti. E’ esattamente questa la differenza più profonda tra le democrazie e regimi: nelle dittature, i giornalisti non sono liberi di rivelare la criminalità di Stato ai più alti livelli e se lo fanno, finiscono ammazzati o in galera per sempre. Nelle democrazie, invece, deve essere possibile. Ecco perché ho investito così tanto su questo caso. Perché voglio contribuire, con il mio giornalismo, a creare una società in cui un giornalista può rivelare la criminalità di Stato ai più alti livelli e farlo in assoluta sicurezza. Per questo, Julian Assange e i giornalisti e collaboratori di WikiLeaks devono essere salvati e protetti”.
Il tuo libro è una battaglia contro il potere segreto (di qualsivoglia colore). Per concludere, con un messaggio di speranza, qual è l’arma più potente per sconfiggerlo? Il giornalismo?
“Il mio libro è il frutto di un lavoro di giornalismo investigativo durato 13 anni sia sui documenti segreti di WikiLeaks sia sul caso Julian Assange e WikiLeaks: 13 anni che ne includono 6 di battaglia legale con il Freedom of Information Act (Foia) in ben 4 giurisdizioni – Inghilterra, Stati Uniti, Australia e Svezia – per ottenere i documenti del caso, visto che nessun giornalista al mondo ha mai provato a richiederli per ricostruire il caso in modo fattuale. Perché ho investito tutti questi anni e questo enorme lavoro su questo caso? Perché se il complesso militare-industriale degli Stati Uniti riesce a estradare e chiudere per sempre in prigione Julian Assange e i giornalisti di WikiLeaks, quello che io chiamo ‘il Potere Segreto’ avrà vinto e nelle nostre democrazie i giornalisti non saranno liberi di rivelare i crimini di guerra e le torture, senza perdere la libertà. E senza la luce di quel giornalismo, la nostra democrazia muore”.
IL LIBRO:
Stefania Maurizi, Il potere segreto. Perché vogliono distruggere Julian Assange e WikiLeaks (Prefazione di Ken Loach ), Ed. Chiarelettere, Milano, 2021, pagg. 400. € 19,00