
Fabio Martini (AUGUSTO CASASOLI/A3/CONTRASTO)
Come si svilupperà la sfida politica nella sinistra? Quali saranno le possibili novità? Ne parliamo, in questa intervista, con il cronista politico della Stampa Fabio Martini.
Siamo all’ultimo giro di questa complicata legislatura. Dopo l’approvazione della legge di stabilità inizierà il “rettilineo” che ci porterà, in primavera, alle elezioni. Eppure ci sarebbe ancora lo spazio e il tempo per dare un senso compiuto alla legislatura. Mi riferisco, certamente. allo ius soli e alla legge elettorale . Incominciamo dallo ius soli. Secondo te è possibile che Gentiloni, anche per il pressing della CEI, ponga la fiducia? Insomma nel Pd passerà la linea Boschi o quella di Del Rio?
Per far passare la legge, basterebbe cercare un compromesso, che salvaguardando il principio ispiratore, superi qualche automatismo. Ma quel compromesso ragionevole nessuno lo cerca. E infatti nel Pd dicono: cerchiamo fino all’ultimo i voti, ma nessuno si batte per un punto di incontro. I principali attori della scena hanno tutti interesse allo statu quo, per cui quasi certamente la legge non passerà. Il Pd, che rivendica la riforma ma ne teme l’impopolarità, può dare la colpa ad Alfano e alla destra; i centristi possono fregiarsi di non averla fatta passare. L’unico che vorrebbe farla approvare, raggiungendo un punto di equilibrio, è il presidente del Consiglio, che infatti è l’unico che non ha dato tutto per perso. Ma il decreto legge su questioni così controverse non è immaginabile.
Parliamo della legge elettorale . Anche questo è uno snodo decisivo per il futuro della prossima legislatura . Però, anche qui, non è molto chiara la prospettiva. Ma Renzi ci crede veramente? Eppoi se davvero dovesse andare in porto quali sarebbero le “coalizioni” a sinistra, visto che il centrodestra appare più compatto? Insomma sono più i dubbi che le certezze. Qual è la tua opinione?
Dopo il lancio del “Rosatellum”, i principali partiti hanno iniziato a fare le loro simulazioni, negli ultimi giorni nel Pd qualcuno sussurra che Renzi si sarebbe convinto che il ridotto numero di collegi previsto dal nuovo testo, avvantaggerebbe il Pd. La partita non è ancora conclusa, ma se Forza Italia la ostacolerà, non se ne farà nulla.
Guardiamo all’interno degli schieramenti. Incominciamo dal leader “riluttante”, Pisapia. Quello che appare è che sia un poco infastidito dal pressing dalemiano- bersaniano. E avrà pure un allontanato la sua tenda dal PD. Però, al contrario di D’Alema, non percepisce Renzi come nemico. Insomma cosa si aspetta dal PD?
All’ex sindaco di Milano non piace lo stile della leadership di Renzi, ma per una prospettiva di governo, ritiene indispensabile un futuro accordo di governo col Pd, con Paolo Gentiloni a palazzo Chigi. L’Mdp di Bersani e D’Alema punta alla sconfitta politica di Renzi. Quasi certamente finirà che le due aree a sinistra del Pd si separeranno. E in questa scomposizione non si possono escludere sorprese, con l’apparizione di personaggi destinati a sparigliare tutto.
Parliamo di Mdp. Gli scissionisti del PD, pur tra sfumature diverse, sono ancora alla ricerca di un ubi consistam . Ovvero vogliono creare un nuovo centrosinistra di governo. L’impressione è che si stanno avvitando su se stessi. Per cui per loro il rischio è che che siano sempre più percepiti solo come anti PD. Tu non vedi questo avvitamento?
L’impressione dell’avvitamento su se stessi corrisponde ad un fatto oggettivo. Per gli scissionisti l’imperativo categorico è cancellare la leadership Renzi. Il resto viene dopo. Ogni loro mossa è subordinata a questo obiettivo. Ecco perché paiono ruotare attorno allo stesso perno.
Massimo D’Alema sta vivendo una fase inedita per uno con la sua storia . Una sorta, come qualcuno polemicamente lo ha definito, di “gruppettaro”. Una strana eterogenesi dei fini per l’uomo più di apparato della politica italiana. Verrebbe da ricordargli il monito di Lenin sull’estremismo…Come ti spieghi questa fase dalemiana, una fase assolutamente da non banalizzare solo come anti renzismo. C’è qualcosa di più profondo?
Sì, la domanda coglie molto bene la mutazione, quasi genetica, di uno dei leader politici più influenti degli ultimi 25 anni, uno dei 28 italiani che ha fatto il presidente del Consiglio nel secondo dopoguerra. Per tutta una vita D’Alema ha incarnato la concezione leninista-gramsciana-togliattiana per cui prima di tutto viene il Partito. Per cui il noi viene sempre prima dell’io. Per cui è meglio sbagliare col Partito che aver ragione da soli. Incoraggiando la scissione dal “Partito” per ragioni prevalentemente di incompatibilità personale con Renzi, D’Alema ha archiviato la propria storia comunista e appare come uno dei tanti leader, che sembrano mossi più da motivazioni individuali che da spinte “generali”. Magari non è così. Ma l’impressione è quella.
Il PD pare vivere una congiuntura di non tensione. Ma dietro l’angolo ci sono le le elezioni siciliane. E lì il tappo salta. che faranno Franceschini e Orlando?
Vedremo. Ci sono le liste elettorali da fare e i non-renziani del Pd contratteranno una tregua con Renzi, in cambio di qualche seggio in più. Se avranno coraggio, porranno il problema del leader da indicare per palazzo Chigi, cioè Gentiloni. Altrimenti se ne riparlerà dopo le elezioni. Se il Pd conquisterà più del 25 per cento, Renzi resterà segretario, ma se i democratici alle Politiche prenderanno un voto in meno del Pd di Bersani nel 2013, allora la poltrona di Renzi potrebbe saltare.
Veniamo al centrodestra. Berlusconi dice: Io sono il PPE in Itala. Però ha capito che senza l’alleanza con Salvini non vince . Intanto apre al rosatellum. Insomma anche qui siamo nella precarietà politica. E’ così?
Berlusconi è più avanti di Renzi nella costruzione di una coalizione. Ma fino a quando non si sa come si vota, sono tutte illazioni.
Ultima domanda: Quale sarà il futuro di Gentiloni? Io non credo la “panchina ” anzi…
Paolo Gentiloni non muoverà una foglia per passare dalla “panchina” al ruolo di centravanti. E’ leale con Renzi che lo ha scelto e sa che, brigando per sé, diventerebbe uno dei tanti trasformisti della storia della Repubblica. Attenderà di essere “chiamato” come salvatore della Patria. La partita si giocherà prima delle elezioni, Renzi non lo indicherà spontaneamente come candidato a palazzo Chigi, ma la “forza delle cose” potrebbe riservare qualche sorpresa.



 Papa Francesco nel visitare, il 26 giugno scorso nel 50° anniversario della morte, la tomba di Don Lorenzo Milani a Barbiana, paesino della Diocesi di Firenze, ha voluto ricordare la vita esemplare del priore di Barbiana. Il Pontefice ha spiegato il suo gesto come «risposta a quella richiesta più volte fatta da don Lorenzo al suo Vescovo, e cioè che fosse riconosciuto e compreso nella sua fedeltà al Vangelo e nella rettitudine della sua azione pastorale». Quel gesto, ha detto il Papa, «oggi lo fa il Vescovo di Roma. Ciò non cancella le amarezze che hanno accompagnato la vita di don Milani – ha precisato -, ma dice che la Chiesa riconosce in quella
Papa Francesco nel visitare, il 26 giugno scorso nel 50° anniversario della morte, la tomba di Don Lorenzo Milani a Barbiana, paesino della Diocesi di Firenze, ha voluto ricordare la vita esemplare del priore di Barbiana. Il Pontefice ha spiegato il suo gesto come «risposta a quella richiesta più volte fatta da don Lorenzo al suo Vescovo, e cioè che fosse riconosciuto e compreso nella sua fedeltà al Vangelo e nella rettitudine della sua azione pastorale». Quel gesto, ha detto il Papa, «oggi lo fa il Vescovo di Roma. Ciò non cancella le amarezze che hanno accompagnato la vita di don Milani – ha precisato -, ma dice che la Chiesa riconosce in quella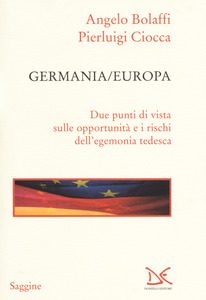 Tutta l’opinione pubblica europea si sta interrogando sulle conseguenze del voto tedesco di domenica scorsa. Un voto che ha visto il crollo di consensi elettorali dei due partiti storici: CDU e SPD. Angela Merkel,Cancelliera riconfermata dal voto, ora inizierà una lunga trattativa per dare un governo alla Germania. Cerchiamo di capire, in questa intervista, con il filosofo della politica e grande studioso della cultura germanica, come si evolverà la situazione politica tedesca.
Tutta l’opinione pubblica europea si sta interrogando sulle conseguenze del voto tedesco di domenica scorsa. Un voto che ha visto il crollo di consensi elettorali dei due partiti storici: CDU e SPD. Angela Merkel,Cancelliera riconfermata dal voto, ora inizierà una lunga trattativa per dare un governo alla Germania. Cerchiamo di capire, in questa intervista, con il filosofo della politica e grande studioso della cultura germanica, come si evolverà la situazione politica tedesca.