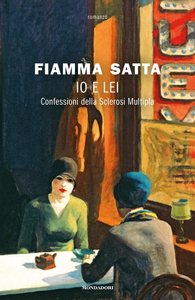Pubblichiamo per gentile concessione della testata on line “L’Etruria.it” questa riflessione di Pierre Carniti (ex Segretario generale della Cisl) sulla strategia di fondo che il movimento sindacale deve seguire per la tutela del lavoro. Un testo che fa chiarezza su un dilemma, che ha diviso il movimento sindacale italiano, tra “conflitto o partecipazione.
Pubblichiamo per gentile concessione della testata on line “L’Etruria.it” questa riflessione di Pierre Carniti (ex Segretario generale della Cisl) sulla strategia di fondo che il movimento sindacale deve seguire per la tutela del lavoro. Un testo che fa chiarezza su un dilemma, che ha diviso il movimento sindacale italiano, tra “conflitto o partecipazione.
Per il “lavoro che manca” ed il “lavoro che cambia” non esiste, allo stato, una politica concreta e nemmeno obiettivi condivisi. Continua infatti una navigazione a vista tra gli scogli. Avventurosa e del tutto priva di carte nautiche. Travisante è anche il dilemma sostanzialmente nominalistico, fasullo e deviante, che tiene banco sui media e divide trasversalmente: pseudo esperti, commentatori e apparati sindacali. Schierati tra “conflitto” e “partecipazione”. Considerate alternative nelle strategie di tutela del lavoro. In realtà si tratta, appunto, di un dilemma falso. E per diverse ragioni. Intanto perché nelle società democratiche e relativamente strutturate, il “conflitto” non può essere esorcizzato. In quanto costituisce un fattore di progresso economico, sociale e politico. Con esclusione naturalmente del “conflitto” praticato senza la “convenzione di Ginevra”. Vale a dire il conflitto fine e sé stesso. Puramente distruttivo. Per intenderci, quello che esercita una irresistibile attrazione tra molti dei così detti antagonisti: “black-block”, “no-global”, “centri sociali”. Tra i quali, appunto, non mancano mai provocatori e violenti.
Altrettanto infondato risulta il riferimento alla “partecipazione”. Ritenuta da molti una categoria salvifica. Ma del tutto,del tutto evanescente ed irrilevante, quando non accompagnata da strumenti, norme, diritti di intervento, in definitiva di co-decisione. In particolare nei e per i processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale e produttiva. A ben vedere, requisiti del tutto estranei alla regolazione in atto dei rapporti di lavoro.
Naturalmente si può sempre cercare di cambiare il corso delle cose. A patto però che si realizzino le indispensabili pre-condizioni. Per il cui conseguimento si richiede una consistente iniziativa ed un impegno sindacale di lunga lena. Del quale purtroppo, almeno per ora, non si vede traccia. Non mancano quindi fondate ragioni di preoccupazione. Anche per la buona ragione che il conseguimento delle necessarie pre-condizioni è destinato e restare un pio desidero se non fosse supportato da un effettivo potere contrattuale.
Per correggere quindi le tendenze in atto è, innanzi tutto, necessario impegnarsi in una unificazione del mondo del lavoro. Oggi diviso e frammentato. Non solo tra lavoro stabile e precario, ma anche tra giovani ed anziani, tra impiego pubblico e privato, tra lavoro subordinato e pseudo lavoro autonomo. In secondo luogo è indispensabile perseguire il monopolio della rappresentanza del lavoro. Scopo che diventa praticabile solo se accompagnato da un indispensabile recupero di tensione unitaria. Necessaria per restituire un ruolo essenziale al sindacalismo confederale. Altrimenti avviato alla irrilevanza. Basti pensare ai contratti nazionali. Arrivati ormai alla incredibile cifra di ottocento. Oltre la metà dei quali stipulati da “sindacati gialli”. Circostanza che, a parte ogni altra considerazione, è certamente una delle spiegazioni relative al deprezzamento ed alla svalutazione del lavoro. Infine c’è il problema, particolarmente grave, in Italia dell’occupazione. Il dato incontrovertibile e del quale si dovrebbe prendere atto, è che la coperta del lavoro disponibile è corta. Se copre gli ultracinquantenni, scopre i giovani. E viceversa. Occorre quindi che la contrattazione affronti, nei mille modi possibili, una ripartizione del lavoro disponibile.
Invece di perdersi in formule e chiacchiere inutili, impressione che si ha assistendo ai dibattiti della solita “compagnia di giro”, è richiesta, al contrario, capacità di mettere in campo un impegno vero, credibile. In grado di invertire la diffusa tendenza e la propensione all’individualismo e alla competizione. Che hanno soppiantato la solidarietà e l’eguaglianza. Producendo, tra l’altro, un intollerabile, continuo, aumento delle diseguaglianze.
Secondo Bauman queste sono alcuni fattori di quella che ha definito la “società liquida”. Dove domina la crisi dello Stato. Quale conseguenza del progressivo affievolimento della sua libertà decisionale. Di fronte allo strapotere delle multinazionali. In particolare della finanza. In tale quadro si è, mano a mano, indebolita una condizione che nel passato consentiva la ragionevole possibilità di affrontare e risolvere i problemi di coesione sociale. In particolare quelli relativi al lavoro. Per altro, con la crisi dello Stato, sono entrate in crisi le ideologie, così come i partiti e le grandi organizzazioni sociali. In sostanza le strutture che, con tutti i loro limiti, avevano costituito il tramite per una comunità di valori che permetteva al singolo di sentirsi parte di qualcosa che ne interpretava i bisogni. Ma soprattutto la speranza di un possibile miglioramento.
Rispetto a pochi decenni fa il contesto è dunque profondamente cambiato. Tuttavia, questa constatazione non può essere assunta come giustificazione di impotenza e paralisi. Occorre quindi promuovere i requisiti essenziali che consentano di affrontare le nuove ed impegnative sfide del nostro tempo.
Poiché nel sindacato, pur senza eliminare la mobilitazione e l’azione quando necessaria, sembrerebbe prevalere la “partecipazione” quale orizzonte strategico, occorre sapere che tale scelta, per essere credibile, esige anche un radicale cambiamento delle modalità di decisione delle stesso sindacato.
In questa prospettiva, la trasparenza e l’etica sindacale restano questioni perennemente aperte. Come, d’altra parte, si richiede ad organizzazioni che gestiscono poteri, influenzano ruoli e carriere, governano patrimoni umani. E non solo. Ebbene, di norma, i correttivi alle trasgressioni, ai comportamenti devianti risiedono in un uso accurato e rigoroso delle regole democratiche e nel culto della rettitudine. Ma a poco rischiano di servire i correttivi se non accompagnati da obiettivi, contenuti, modalità di comportamenti che diano il senso all’azione collettiva ed intorno ai quali affermare una credibile etica della responsabilità.
A tale proposito meritano una riflessione, ed un profondo rinnovamento, le modalità di comunicazione. Per renderle idonee a coinvolgere effettivamente militanti, iscritti e non iscritti al sindacato. Si tratta di una esigenza ineludibile. Tenuto conto che sono praticamente esaurite le modalità originarie della comunicazione sindacale: i volantini, i giornaletti ciclostilati, le assemblee di piccoli o grandi gruppi di lavoratori. Inizialmente nelle parrocchie, o nelle Case del popolo. Successivamente, quando è stato conquistato il diritto di assemblea in fabbrica, nei reparti, o nelle mense aziendali. Non è un mistero che queste modalità comunicative sono praticamente andate in disuso. Il circuito comunicativo si è infatti, poco a poco, ridotto a coinvolgere solo una parte di dirigenti ed operatori. Lasciando fuori il grosso dei rappresentanti di base, degli iscritti, ma anche le centinaia di migliaia, per non dire milioni, di lavoratori collocati fuori dal perimetro della rappresentatività sindacale.
Il punto quindi è che la “partecipazione”, per essere efficace nel rapporto tra le parti deve essere sorretta da una parallela e vera partecipazione interna all’organizzazione sindacale. Tale da assicurarle la forza e la credibilità necessaria. E’ arrivato perciò il momento, reso possibile anche dalle enormi potenzialità delle nuove tecnologie, di costruire un sistema di comunicazione e di interlocuzione interna che consenta al movimento sindacale confederale di ricostituire una condotta di relazioni personalizzate. Una struttura che permetta al singolo iscritto, ma anche al lavoratore senza rappresentanza, di dire la sua opinione. Sulle priorità, sulle cose da fare, sugli obiettivi da assumere. In buona sostanza, di poter valutare e condividere o meno le proposte che si vorrebbero portare avanti. Senza naturalmente alcuna concessione alla chimera, cara (stando a quel che si legge e si ascolta) a buon numero di politici. Confusi ed eccentrici. In particolare i devoti della “democrazia diretta”, concepita come sostitutiva delle forme di democrazia deliberativa e rappresentativa. Rifiutare queste pericolose e stravaganti bizzarrie non significa, ovviamente, cadere nell’errore opposto. Cioè quello di pensare che sia possibile esaurire la democrazia sindacale nell’autoreferenzialità degli apparati.
Se si intende scongiurare questi opposti errori è necessario, assieme alla consapevolezza dei termini attuali della situazione, poter disporre di una piattaforma informatica. Per intenderci, una struttura hardware, cioè fisica. Che consenta di collegare centinaia di migliaia di componenti periferiche (i computer, i telefonini) e coloro che li usano. E’ indispensabile inoltre un sistema operativo (software) che svolga la stessa funzione della prima. Ma in modalità digitale. E’ facile capire che si tratta di un progetto piuttosto impegnativo. Il quale anche, per la sua necessaria consistenza, può essere realizzato solo con un impegno unitario di tutto il movimento sindacale confederale.
Chi ha qualche esperienza in grandi organizzazioni sociali non farà fatica a rendersi conto che un simile proposito possa suscitare la contrarietà, la reazione, la resistenza trasversale, di un certo numero di dirigenti sindacali. Che si faranno verosimilmente forti dell’argomentazione che non andrebbe fatto nulla che possa implicare il rischio di una limitazione al pluralismo culturale e politico. Esigenza sempre irrinunciabile. A maggior ragione quando si è impegnati ad attraversare una incerta fase di passaggio della storia.
Tuttavia costoro non dovrebbero ignorare due aspetti. Altrettanto essenziali. Il primo riguarda la cospicua quantità di risorse che devono essere impegnate per realizzare e far funzionare una simile piattaforma. La seconda è che di per sé la tecnologia è “neutra”. Dipende sempre, naturalmente, dall’uso che ne viene fatto. Per altro le piattaforme di comunicazione ed interlocuzione, per loro natura, sono semplicemente strutture-ospiti, che abilitano la funzionalità di altri elementi, tanto del mondo fisico (telecamere, monitor, smartphone, ecc.), che del mondo digitale (documenti, dichiarazioni, giudizi, ecc.).
Comunque, una cosa è certa. Si possono sempre capire tutti i dubbi e le perplessità. Ma viene un momento, e questo momento per il sindacalismo confederale è indiscutibilmente venuto, che dubbi e perplessità rischiano di non essere altro che un alibi per sfuggire alle proprie responsabilità.
L’auspicio quindi è che tutti e ciascuno riescano a fare propria l’esperienza che ci viene dalla vita. Non ci è forse capitato di trovarci alle prese con problemi che ci sembravano irrisolvibili, prima di rivelarsi invece del tutto solubili? Da quelle esperienze dobbiamo perciò sapere trarre la necessaria lezione: il rischio dell’impegno è sempre da preferire alla rassegnazione.
Pierre Carniti


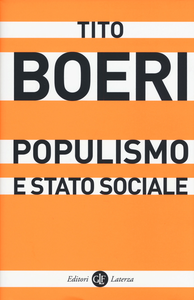 populismo: ovvero la messa in crisi del welfare state europeo. Perché la “ricetta” populista mette in crisi lo Stato Sociale?
populismo: ovvero la messa in crisi del welfare state europeo. Perché la “ricetta” populista mette in crisi lo Stato Sociale?