 Ratzinger rinuncia alla rinuncia? La domanda può sembrare una provocazione, ma un episodio fa sorgere questo dubbio. Si tratta della pubblicazione di una “prefazione” , come anticipato dal “Corriere della Sera” e dalla “Nuova bussola quotidiana”, ad un libro, dal titolo la “Forza del Silenzio”, del Cardinale conservatore Sarah, Prefetto della Congregazione per il culto Divino. Sappiamo che il cardinale è un ultras della “Riforma della Riforma” liturgica del Vaticano II. E sappiamo, anche, che Papa Francesco è su altre posizioni. Insomma quale “statuto” deve avere il “papa” emerito? Ne parliamo, in questa intervista, con il professor Andrea Grillo ordinario di Teologia al Pontificio Ateneo Sant’Anselmo di Roma.
Ratzinger rinuncia alla rinuncia? La domanda può sembrare una provocazione, ma un episodio fa sorgere questo dubbio. Si tratta della pubblicazione di una “prefazione” , come anticipato dal “Corriere della Sera” e dalla “Nuova bussola quotidiana”, ad un libro, dal titolo la “Forza del Silenzio”, del Cardinale conservatore Sarah, Prefetto della Congregazione per il culto Divino. Sappiamo che il cardinale è un ultras della “Riforma della Riforma” liturgica del Vaticano II. E sappiamo, anche, che Papa Francesco è su altre posizioni. Insomma quale “statuto” deve avere il “papa” emerito? Ne parliamo, in questa intervista, con il professor Andrea Grillo ordinario di Teologia al Pontificio Ateneo Sant’Anselmo di Roma.
Professore, il sito ultratradizionalista “La nuova bussola quotidiana ” e il “Corriere della Sera”, hanno lanciato l’anticipazione della “postfazione” (nell’edizione italiana sarà una “prefazione”) di Joseph Ratzinger (Papa Benedetto XVI) ad un libro (titolo “La force du silence”) del Cardinale Sarah, Prefetto della Congregazione per il culto divino. Sappiamo che il cardinale è un ultras della “Riforma della Riforma” liturgica del Vaticano II. E sappiamo, anche, che Papa Francesco è su altre posizioni. Non sfugge, quindi, che la decisione di Ratzinger sia da interpretare come una blindatura di Sarah. Insomma un condizionamento non da poco. E’ così?
Bisogna considerare bene la singolarità della situazione. Un papa rinuncia all’esercizio del proprio ministero petrino. Si apre la procedura di successione e viene eletto il successore. Normalmente ciò accade “mortis causa”. Quando la ragione non è la morte del precedessore, ma la “dimissione”, questo fatto apre per la istituzione un delicato caso di possibile conflitto di autorità. Che dovrebbe essere superato dalla “consegna del silenzio” del predecessore. Il quale, nella prefazione con cui esalta le doti del Prefetto Sarah, cita un testo di Ignazio di Antiochia che dice: “E’ meglio rimanere in silenzio…”. Se non solo parla, ma addirittura esalta un Prefetto che ha creato continui imbarazzi alla Chiesa e al suo successore, si apre un conflitto pericoloso, che richiederebbe comportamenti più prudenti e parole più responsabili. Si dovranno prevedere, in futuro, norme che regolamentino in modo più netto e sicuro la “morte istituzionale” del predecessore e la piena autorità del successore, in caso di dimissioni.
Sulla liturgia, all’interno della Chiesa, c’è un dibattito, certo tra addetti ai lavori, decisivo però sul cuore stesso della Chiesa. La liturgia non è mera ritualità: è l’estroversione della testimonianza cristiana; le chiedo, allora, la posta in gioco è molto alta?
La liturgia è fonte e culmine di tutta la azione della Chiesa, come dice il Concilio. Questo significa che una lettura chiusa, inadeguata, nostalgica della liturgia – che Sarah ha in comune con Ratzinger – insidia in radice ogni percorso di “uscita” e di “liberazione dalla autoreferenzialità”. La fissazione sul “rito antico” è, precisamente, il segno preoccupante che accomuna il Vescovo emerito di Roma e il Prefetto della Congregazione del culto. E su questo papa Francesco ha preso posizione con giusta fermezza.
Veniamo a Ratzinger. Papa Francesco lo ha definito come un “nonno saggio”. E Ratzinger ha manifestato stima nei confronti di Bergoglio. Eppure la visione idilliaca di un “Papa” emerito pone non pochi problemi. Se uno lascia il ministero, anche esteriormente dovrebbe manifestarlo. Insomma regge o non regge questa “coabitazione”?
Non può esserci coabitazione. Questo è ora del tutto evidente. Come è evidente che la veste bianca e la loquacità, oltre alla residenza, debbono essere dettagliatamente normate. Il Vescovo emerito deve allontanarsi dal Vaticano e tacere per sempre. Solo a queste condizioni è possibile configurare una reale “successione”. E’ ovvio che per Ratzinger, come per Bergoglio, si tratta di un “experimentum”, poiché non vi sono precedenti. Per questo si deve fare paziente esperienza di questi inciampi. E non vi è dubbio che questa Postfazione (o Prefazione) sia un capitombolo. Le intenzioni di discrezione e di umiltà sono palesemente violate, in modo quasi scandaloso. E trovo veramente sconcertante che il Vescovo emerito di Roma lodi Francesco per una nomina che sa bene di aver contribuito pesantemente a determinare. Questo mi sembra il dato più grave, un segno di clericalismo e direi anche di una certa ipocrisia.
Vi sono stati episodi di condizionamento fatti da Ratzinger? Mons.Gaenswein, tempo fa, parlava di un “ministero allargato”…
Anche questi sono “sogni di visionari interessati”: non vi è alcun ministero allargato. C’è una successione al papato che è avvenuta senza morte, ma che deve esigere un silenzio e una discrezione che non alterino l’esercizio del ministero petrino da parte del successore. E’ ovvio che chi perde il potere cerca di mantenerlo. E i segretari spesso sognano e brigano molto più dei pontefici…
ULTIMA domanda: come giudica l’apertura di Papa Francesco nei confronti della “Fraternità San PIO X” , che ha provocato uno scisma negli anni del post-concilio?
Mi sembra che Francesco voglia due cose: comunione e misericordia. E le voglia giustamente con e per tutti. Questo, ovviamente, non significa una “resa incondizionata”. Occorrono adeguate garanzie di “fedeltà a tutta la tradizione” (compresa quella più recente) per poter recuperare una comunione effettiva con chi era caduto in condizione di scomunica. Magari anche recuperando, in forma differenziata, soggetti legati a tradizioni più rigide e chiuse, ed eliminando così la tentazione che per recuperare loro si contaminino le fonti comuni a tutti. Mi riferisco, in particolare, all’uso del “rito antico”, che con un accordo di comunione con i lefebvriani – subordinato a specifiche garanzie – sarebbe sottratto all’”uso straordinario” ed entrerebbe nelle caratteristiche rituali di un settore specifico della esperienza ecclesiale, che per questo risulterebbe accuratamente circoscritto e controllato.

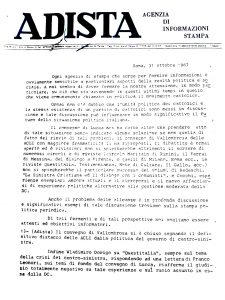

 Cinquant’anni fa Papa Paolo VI pubblicò la Populorum progressio. Una Enciclica che segnò per sempre la Storia della Chiesa contemporanea. Quel 26 marzo del 1967 si verificò, a due anni dal Concilio Vaticano II, lo spostamento dell’asse dell’Evangelizzazione della Chiesa: “Lo sviluppo dei popoli, in modo particolare di quelli che lottano per liberarsi dal giogo della fame, della miseria, delle malattie endemiche, dell’ignoranza; che cercano una partecipazione più larga ai frutti della civiltà, una più attiva valorizzazione delle loro qualità umane; che si muovono con decisione verso la meta di un loro pieno rigoglio, è oggetto di attenta osservazione da parte della chiesa. All’indomani del Concilio ecumenico Vaticano II, una rinnovata presa di coscienza delle esigenze del messaggio evangelico le impone di mettersi al servizio degli uomini, onde aiutarli a cogliere tutte le dimensioni di tale grave problema e convincerli dell’urgenza di una azione solidale in questa svolta della storia dell’umanità”. Iniziava così il documento pontificio. A 50 anni dalla sua pubblicazione è ancora attuale questo documento? Ne parliamo, in questa intervista, con Padre Gianpaolo Salvini, gesuita, economista ed ex direttore della prestigiosa rivista “La Civiltà Cattolica”.
Cinquant’anni fa Papa Paolo VI pubblicò la Populorum progressio. Una Enciclica che segnò per sempre la Storia della Chiesa contemporanea. Quel 26 marzo del 1967 si verificò, a due anni dal Concilio Vaticano II, lo spostamento dell’asse dell’Evangelizzazione della Chiesa: “Lo sviluppo dei popoli, in modo particolare di quelli che lottano per liberarsi dal giogo della fame, della miseria, delle malattie endemiche, dell’ignoranza; che cercano una partecipazione più larga ai frutti della civiltà, una più attiva valorizzazione delle loro qualità umane; che si muovono con decisione verso la meta di un loro pieno rigoglio, è oggetto di attenta osservazione da parte della chiesa. All’indomani del Concilio ecumenico Vaticano II, una rinnovata presa di coscienza delle esigenze del messaggio evangelico le impone di mettersi al servizio degli uomini, onde aiutarli a cogliere tutte le dimensioni di tale grave problema e convincerli dell’urgenza di una azione solidale in questa svolta della storia dell’umanità”. Iniziava così il documento pontificio. A 50 anni dalla sua pubblicazione è ancora attuale questo documento? Ne parliamo, in questa intervista, con Padre Gianpaolo Salvini, gesuita, economista ed ex direttore della prestigiosa rivista “La Civiltà Cattolica”.